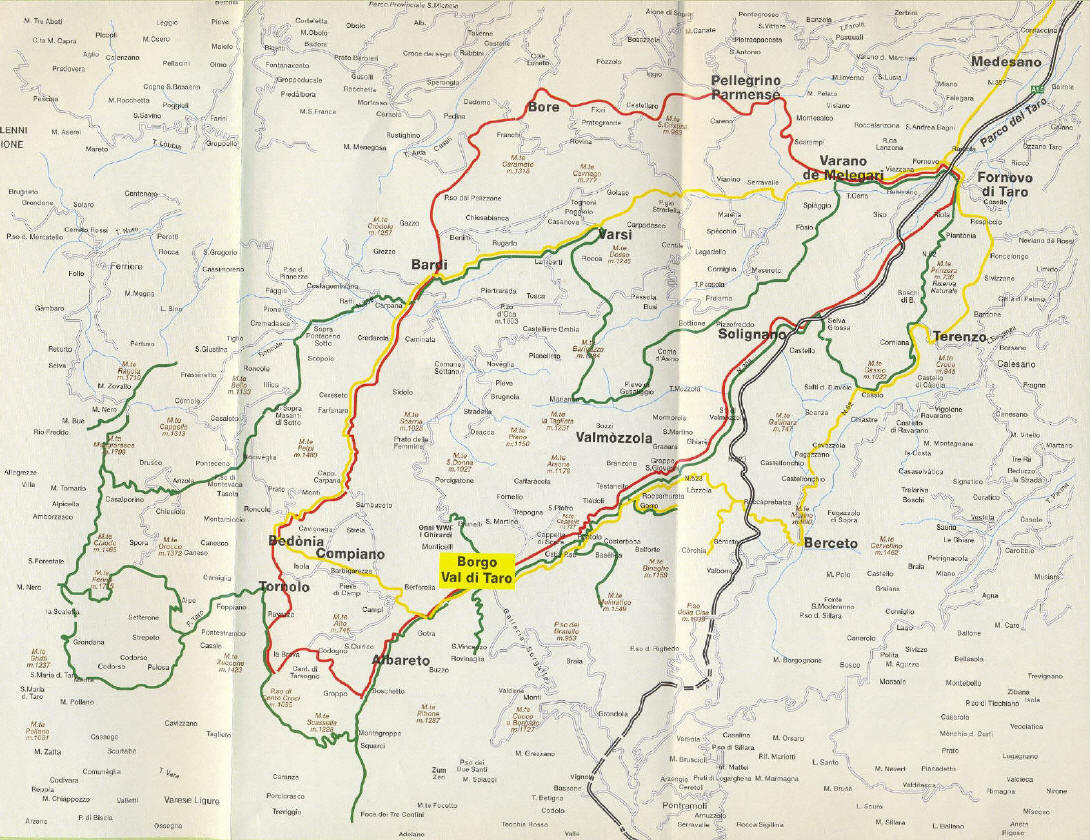Ferruccio Ferrari

A ricordo dei genitori sfollati a Tornolo , che staffette insospettabili, ripercorsero a piedi i vecchi sentieri; del nonno “Peppin de Bertacca” che instancabilmente con la lena giovanile costruì rifugi, per i suoi e tutti gli altri restando sempre vigile con con fede incrollabile di fronte alle minacce e continue scorrerie delle orde nazi-fasciste
SENATORE PROF. PAOLO EMILIO TAVIANI Presidente della F.I.V.L.
PRESENTAZIONE
Ferruccio Ferrari ripercorre in questo volume i lunghi mesi della lotta di Liberazione, da lui vissuti in prima persona in una tormentata zona della provincia di Parma e nell’adiacente provincia di Genova. . E’ una zona che conosco bene, e altrettanto bene conosco le battaglie che vi abbiamo combattuto, le tragedie sofferte durante la guerra partigiana. Come non ricordare i drammi di Bedonia, di Compiano, di Tornolo e l’entusiasmante vicenda dello Stato Libero del Taro? Il testo non vuole svolgere un’analisi storica; intende raccogliere molti ricordi, così come i protagonisti li hanno conservati nei loro cuori o li hanno tramandati, spesso solo oralmente, alle successive generazioni.
Anche come Presidente della Federazione Italiana Volontari della Libertà non posso che apprezzare lo sforzo che da più parti si è compiuto e si va ancora compiendo – il presente volume ne è una testimonianza – affinché ricordi come questi non vadano perduti, ma siano conservati, a costituire una componente di studio per la critica storica.
Emerge nel libro una cronaca scarna, efficace, che si dilata fino a dare voce e spazio ai sentimenti di coloro che in quegli anni tragici furono travolti dai più angoscianti dilemmi esistenziali. I molti episodi che vi sono narrati confermano quanto sia esatta li definizione della guerra partigiana come guerra dei cento fronti. Essa fu al tempo stesso «souterraine» e guerriglia, e la guerriglia fu di montagna, di collina, di campagna, di città. Ben di rado si determinarono linee di demarcazione delle zone controllate dai partigiani. Si riuscì a instaurare delle vere e proprie «repubbliche partigiane» ma esse non ebbero di solito lunga vita e, quando l’ebbero, furono di modeste « enclaves »; soltanto negli ultimi mesi (fine gennaio-aprile), alcuni veri e propri Stati partigiani – in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli acquisirono dimensioni di rispetto.
Tuttavia, ben prima che questi « Stati» si consolidassero, i partigiani costituivano un esercito di trecentomila uomini, con ancor più numerosi sostenitori e aderenti, che agiva, interveniva, colpiva ovunque, con successi e insuccessi, infliggendo perdite al nemico in uomini e mezzi, ma subendo ne anche in contraccolpi e le repressioni, lasciando sul campo o nei luoghi di tortura e di sterminio migliaia di vittime. Dall’intreccio fra « guerre souterraine» e guerriglia deriva una conseguenza positiva: la guerra partigiana italiana non comportò alcuna possibilità di distinzione, e tanto meno di differenza, fra prima e seconda linea, fra il rischio del fronte e l’azione della retrovia. Perché come non c’era « un» fronte non c’era « una» retrovia. Di qui pure la provvidenziale assenza, anche sul piano storiografico, della tradizionale contesa propria dei reduci d’ogni guerra fra chi più e chi meno avrebbe rischiato e meritato.
Fu dunque la guerra partigiana in Italia una guerra dei cento fronti: ed è questa la ragione principale per cui a distanza di quarant’anni è difficile per chi non l’abbia vissuta, comprenderla e « vederla» nella sua concreta vicenda quotidiana. Di qui la imprescindibile utilità della testimonianza e dei ricordi. Protagonista della Resistenza fu il popolo italiano. L’autentica Resistenza d’Italia fu del popolo; fu forza popolare di ogni ceto, uomini e donne, militari, montanari, operai, studenti, intellettuali, contadini, impiegati, con il sostegno del clero. Fu genuina e spontanea, germinò senza preparazione e solo in un prosieguo di tempo – acquistò coscienza, si organizzò, divenne chiaramente la rappresentanza viva e vitale del legittimo Stato nazionale.
Senza questa grande forza popolare e nazionale, il movimento politico militare non avrebbe potuto raggiungere i risultati che invece raggiunse, perché gli sarebbe mancato il supporto necessario, indispensabile. Questa grande, genuina forza popolare e nazionale, al di là dei partiti, delle ideologie, delle impostazioni politiche, fu il fattore imponderabile che permise di « riuscire» laddove l’insufficienza di mezzi e di organizzazione avrebbe segnato inevitabilmente una partita perduta. La Resistenza fu dunque un tipico fenomeno di massa, e perciò essenziale e determinante ne risultò fin dal primo momento la partecipazione dei cattolici: uomini e donne di radicata formazione cristiana. Una ragione profonda sta alla base di questo: il nemico non era un qualsiasi straniero: erano i nazisti che esaltavano e praticavano il razzismo, il paganesimo, il più efferato totalitarismo. La concezione del mondo, la realtà di vita quotidiana rappresentavano quanto di più lontano si sia mai avuto o si possa immaginare rispetto alla civiltà cristiana. Parlare di paganesimo è forse ancora poco; il nazismo fu una perfetta antitesi del Cristianesimo.
Militanza armata, cospirazione, servizi ausiliari, collaborazione attiva e passiva con gli alleati, sabotaggi, assistenza spirituale e materiale, silenzi complici e sofferti: nei reparti e nei comandi partigiani, nelle squadre di città e nei CLN (governi regionali clandestini): in ogni ambiente di città o di campagna, la Resistenza ha con sé sacerdoti, pastori, suore e un’innumerevole schiera di uomini e donne di professata fede cristiana. Lottano non solo contro i tedeschi, ma anche e soprattutto contro l’idea pagana e anticristiana di cui i nazisti e i loro servi repubblichini sono spavaldi e sfrontati portatori. Tutte queste considerazioni emergono dal racconto e dalle testimonianze raccolte da Ferruccio Ferrari. Così come ne emerge che la Resistenza fu un fenomeno che coinvolse tutte le componenti della popolazione – ceti, generazioni, classi e ambienti che parteciparono in qualche modo alla lotta. Grande fu la partecipazione dei singoli e delle famiglie, e unanime lo sdegno per gli eccessi dell’oppressione nazifascista. Quasi tutti gli abitanti della media e alta montagna, dell’Appennino e delle Alpi, avrebbero ben meritato il brevetto di partigiano o di patriota.
Quale fu il frutto della Resistenza?
Il più importante fu che la libertà venne conquistata dal nostro popolo, con la sofferenza, il sacrificio, l’olocausto. « Più della servitù temo la libertà portata in dono », insegnava Mazzini. Ma va sottolineato anche un altro fatto, troppo spesso dimenticato. Al tavolo della pace il contributo alla vittoria alleata dei partigiani e del Corpo Armato di Liberazione fu determinante affinché De Gasperi riuscisse a evitare ben più gravi mutilazioni territoriali di quelle, pur gravi, che per la sconfitta dovemmo subire. E’ difficile, se non impossibile, fare la storia con i « se ». Ma possiamo pur dire che, se non ci fosse stato il contributo delle forze partigiane e del nuovo esercito alla vittoria alleata, i confini sarebbero oggi – a est, a nord, a sud e sul mare – diversi da quelli in cui si identifica l’unità nazionale della Patria Italiana. Una unità nazionale che – ristrutturatasi nella Repubblica nata dalla Resistenza – ha già vissuto quarant’anni di pace nella sicurezza e in uno straordinario sviluppo economico e sociale.
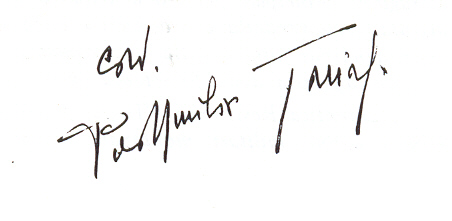
Piero Calamandrei
« Quando io considero questo misterioso e miracoloso moto di popolo, questo volontario accorrere di gente umile, fino a quel giorno inerme e pacifica, che in una improvvisa illuminazione sentì che era giunto il momento di darsi alla macchia, di prendere il fucile; di ritrovarsi in montagna per combattere contro il terrore, mi vien fatto di pensare a certi inesplicabili ritmi della vita cosmica, ai segreti comandi celesti che regolano i fenomeni collettivi, come le gemme degli alberi che spuntano lo stesso giorno, come certe piante subacquee che in tutti i laghi di una regione alpina affiorano nello stesso giorno alla superficie per guardare il cielo primaverile, come le rondini di un continente che lo stesso giorno s’accorgono che è giunta l’ora per mettersi in viaggio.
Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di morire da uomini per vivere da uomini. E cominciò allora quella guerra partigiana, diversa da tutte le guerre conosciute prima; quella guerra in cui non c’erano più combattenti, perché tutti erano combattenti; quella guerra in cui non vi erano più azioni militari, perché i gesti della normale vita quotidiana erano guerra, perché ormai il dovere militare aveva lo stesso volto del dovere civile, perché ormai l’unico modo di essere civile era quello di far la guerra all’ultimo sangue alla bestialità e alla barbarie ».
Piero Calamandrei
PREMESSA
Scrivere un libro sulla lotta di Liberazione 1944/45 non è cosa facile.
Senza alcuna pretesa di essere uno storico e tanto meno uno scrittore forbito, ho voluto descrivere con serietà, per tramandare ai posteri la verità su episodi rilevanti per la vita stessa delle nostre popolazioni che oltre averli vissuti, molto spesso li hanno subiti. C’è stato chi ha scritto sulla Resistenza fidandosi dei propri ricordi, magari dopo tanti anni. In questi casi, prescindendo dalla umana tentazione di autoincensamento di cui va soggetto chi ne è stato partecipe, la memoria può indurre involontariamente ad omissioni o distorsioni. C’è stato chi ha scritto senza avervi preso parte, attingendo informazioni da chi ha vissuto la nostra Resistenza, senza tuttavia spingere la propria indagine ad elementi rappresentativi di diverse correnti politiche o che avevano svolto differenti mansioni. Ne è risultata una interpretazione ed una esposizione dei fatti mutilata: enfatizzazione, minimizzazione e omissione ne sono risultate le inevitabili conseguenze.
Altri autori sono partiti col proposito di dimostrare tesi preconcette, in omaggio alle proprie convinzioni politiche o per fare l’apologeità di parte. Qualcuno ha voluto abbracciare analiticamente tutti gli episodi della Resistenza in campo nazionale, confondendo spesso località, date e fatti, menzionando episodi marginali e dimenticandone altri di notevole rilievo, con l’involontario risultato di creare più confusione che chiarezza. Ci sono state anche pubblicazioni nelle quali, con maggiore o minore abilità di simulazione, si è cercato di gettare fango sul fenomeno partigiano, collezionando e gonfiando episodi negativi per poi generalizzare. Non necessita faziosità, per classificare tali pubblicazioni come tentativi di reviviscenza nazi-fascista.
Non sono pochi i partigiani che, dopo qualche esperienza negativa, trascurano di leggere pubblicazioni sulla Resistenza per non doversi digerire i tentativi di qualcuno che vuole monopolizzare la lotta partigiana a fini di parte. Anche quella forma di complesso che porta a passare sotto silenzio episodi incresciosi, non giova alla verità storica e al buon nome della moltitudine dei partigiani onesti. Molti Stati hanno aperto gli archivi su episodi della II” guerra mondiale, per molto tempo top-secret. Quando cesserà il silenzio su certi fatti, che come tali non possono essere cancellati dalla storia, ai quali la stragrande maggioranza dei partigiani è estranea ma se ne sente ingiustamente gravata? La domanda può denotare il modo di ragionare dei non addetti ai lavori: ma talvolta il silenzio è molto peggiore della verità. Ispirandomi a questi principi, ho voluto ripercorrerne tutto il periodo della lotta di liberazione, riunendo gli stessi racconti di più autori che scrissero sull’argomento prima di me, rettificandone gli errori più grossolani e mettendo molto spesso tesi diverse a confronto, onde lasciare libera la opinione del lettore di trame un proprio giudizio per una valutazione più obiettiva.
Ho limitato inoltre la zona delle mie ricerche a quella di più diretta conoscenza, escludendo avvenimenti anche importanti e a questi direttamente collegati, ma sui quali sono già noti lunghi intervènti di altri narratori e di cui il lettore dovrebbe già conoscere tutto.
L’autore
LA POPOLAZIONE DEL TORNOLESE
IMPREPARATA ALL’ENTRATA IN GUERRA DELL’ITALIA
L’entrata in guerra dell’Italia, a fianco dell’alleata Germania, venne appresa dalle popolazioni dell’ Alta Val Taro dal notiziario radiofonico, allora EIAR. Nonostante la continua, alle volte puerile, campagna propagandistica, diffusa e strombazzata dalla radio e dalla stampa, per preparare il popolo ad accettare un terribile conflitto, i Tornolesi, noti per il loro spirito commerciale abbinato al buon senso, non- furono mai persuasi della convenienza e tanto meno della necessità dell’ultima guerra. Perciò non sentendola la subivano, con un animo sempre più portato ad avversarla. Inoltre man mano che si veniva a conoscenza delle notizie, sussurrate confidenzialmente nei mercati e nelle trattorie, sulla nostra impreparazione militare, si osava sperare che l’Italia non entrasse in guerra prevedendo una sicura rovina. La propaganda fascista che dopo le prime avvisaglie di facili vittorie, si rese conto sulla inconsistenza delle nostre scorte, corresse il programma propagandistico prospettando una guerra lampo con l’immancabile vittoria da parte delle truppe italo-tedesche.
Le famiglie che avevano congiunti alle armi, furono prese da grande sgomento mentre crescevano le preoccupazioni di chi aveva giovani abili al servizio militare. . Si cominciarono ovunque nelle chiese e nei luoghi di culto, preghiere speciali a tutti i santi e in modo particolare alla Madonna. A Tornolo per volere di Don Silvio Mutti, fu portata a nuovo culto S. Gemma e a lei vennero affidate la salvezza e la vita dei militari al fronte. Per S. Maria Taro Don Ce/so Mori ci ha tramandato:
Si cominciarono subito nel nostro Santuario speciali preghiere alla nostra Cara Madonna e per volontà del popolo, come già si fece durante la guerra 1915-18, la miracolosa Statua venne rimossa dalla sua nicchia ed esposta continuamente alla pubblica venerazione, con appeso al collo, un cuore d’argento, dono dei bambini della la Comunione, che racchiudeva tutti i nominativi dei nostri cari soldati. La nostra cara Madonna scesa dal suo trono, in mezzo al suo popolo, dava la sensazione che, quale madre amorosa, partecipasse più da vicino alle nostre pene ed ai nostri dolori e li alleviasse con le sue grazie e benedizioni. Vennero subito chiamate alle armi, con ritmo accelerato, varie classi e la partenza di questi cari giovani non faceva altro che aggravare le nostre preoccupazioni. Durante quei tre primi anni di guerra furono ben circa 120 gli uomini di S. Maria del Taro che vennero chiamati alle armi. Molti però poterono ottenere, tramite le Ditte locali, l’esonero per i lavori boschivi, e tornati a casa lavorarono tranquillamente. Il numero quindi dei nostri militari si mantenne sempre ad eccezione dei primi tempi, intorno agli ottanta.
Questi nostri cari soldati vennero dislocati su tutti i fronti e cioè in quello della Francia, Croazia, Dalmazia, Montenegro, Albania, Grecia, Etiopia, Libia, Tunisia, Russia, Sicilia, Corsica, Sardegna. Tutti i reduci che parteciparono a questo conflitto mondiale, potrebbero raccontarci tanti episodi di valore e di sacrificio, da loro compiuti; noi però ci limiteremo a descrivere la vita e l’ambiente locale, di come hanno vissuto soffrendo e sperando, le nostre famiglie impegnate sul fronte interno. Durante i primi tre anni di guerra, la nostra comunità non subì gravi danni.
Se non ci avessero impensierito le notizie che giungevano dai vari fronti e le preoccupazioni per i figli migliori alle armi, sembrava di non essere in guerra. Il rumoreggiare continuo di giorno e di notte, delle squadriglie aeree alleate, che andavano a bombardare, ci scuotevano riportandoci alla nuda e tremenda realtà della guerra in atto. I servizi pubblici funzionavano, poste, telegrafo e corriera; però arrivavano in maniera sempre più ridotta i generi alimentari tesserati. La popolazione, rispettava l’oscuramento attendendo ai lavori agricoli abituali, fatto eccezione di alcuni che per puro spirito commerciale o spinti dalle necessità si erano dati al mercato nero con la vicina Liguria, dove i generi alimentari scarseggiavano notevolmente. La guerra che infuriava sui fronti di combattimento, nei primi tre anni non era stata ancora provata dalla nostra popolazione nella sua cruda realtà. A questa relativa calma, subentrerà però una vera burrasca che attraversando il nostro territorio, travolgerà, durante i terribili rastrellamenti, persone, cose ed animali. Allora abbiamo conosciuto con strazio e con dolore indicibile che cosa era la guerra, la terribile guerra di cui tanto ne sentivamo parlare e che tanto avevamo temuto.
L’ ALTA VALLE DEL TARO
dal 25-7 all’8-9-1943
Era domenica l° agosto 1943 di pomeriggio, quando i ragazzi di S. Maria Taro, dietro istigazione dei vecchi antifascisti, abbatterono la stele in marmo su cui era scolpito il fascio littorio, collocata a suo tempo presso il ponte nuovo a ricordo della costruzione della strada provinciale Pontestrambo -S. Maria, inaugurata nel 1925. Il pezzo di marmo, dal simbolo ormai irriconoscibile, venne trascinato per le vie del paese e messo, come si soul dire, alla berlina e alla derisione del pubblico per finire poi gettato nel Taro. Scompariva così l’unico simbolo del Regime esistente in paese. La domenica successiva 8 agosto, una dimostrazione con folta partecipazione di popolo celebrava l’avvenimento, ricollocando sul piedistallo originale, la statua in bronzo del monumento ai caduti della 1° guerra mondiale.
Ricorderemo che il Governo Fascista per scopi bellici, aveva requisito tutti gli oggetti e utensili in rame, le cancellate di ferro, le campane delle chiese con la sola eccezione per le cattedrali e i Santuari. Le campane di S. Maria del Taro, vennero miracolosamente salvate dal parroco Don Celso Mori, il quale riuscì a dimostrare alle autorità preposte che la chiesa parrocchiale era da considerarsi il più antico Santuario dedicato alla Madonna, di tutta la Val Taro. Dopo le campane, era venuto il turno dei monumenti in bronzo. Non potendosi sostenere il valore artistico o storico di quello ai caduti, la Commissione, a rivalsa delle campane aveva requisito, la statua dell’ardito.
Questa rimozione fu una cerimonia puramente propagandistica del Fascismo. Per far passare l’atto simbolico come spontanea donazione, venne mandato da Bedonia l’Avv. Raggi il quale sostenne la tesi, che quella era la dimostrazione che i combattenti della 1915/18 partecipavano ancora una volta donando alla Patria i cimeli della loro gloria. Calato il bronzeo monumento, questo venne rinchiuso in una gabbia, fatta di robuste tavole in legno onde poterlo poi spedire a una fonderia di Torino. Fortunatamente causa la mancanza di mezzi di trasporto adeguati e la lontananza di centri meglio serviti, la cassa era rimasta in loco fino a quel giorno. Caduto Mussolini, i frazionisti di Grondana, presero l’iniziativa del restauro, ricollocando il monumento sul suo piedistallo dove era, come era.
Domenica 8 agosto fra il tripudio della popolazione tutta, galvanizzata da un infiammato discorso del noto antifascista Primo Guglielmetti, fu reso giustizia ai Caduti della guerra 1915/18 che certamente non avrebbero voluta una guerra a fianco della Germania, contro la quale avevano sacrificato la vita. Alla sera dell’otto settembre, sagra di S. Maria Taro celebrata con grande solennità, nonostante la guerra ancora in atto, si apprese dalla radio che l’Italia aveva firmato l’armistizio con gli “Alleati”. La popolazione Tarese, presa da indicibile entusiasmo ritenendo semplicisticamente finita la guerra, si riversò in chiesa a ringraziare la Madonna per la grazia ricevuta, nel giorno della Sua festa. Tale entusiasmo ebbe breve durata, nei giorni successivi si seppe che purtroppo il conflitto continuava.
Come noto, dopo 45 giorni veniva liberato Mussolini. I fascisti ne approfittavano per schierarsi nuovamente a fianco dei tedeschi. L’esercito italiano si sciolse di colpo e cominciarono ad arrivare di conseguenza soldati sbandati da tutte le direzioni. Vestiti in abiti civili offerti dalla popolazione, tentavano di raggiungere i paesi natii a piedi per sfuggire la deportazione in Germania come prigionieri di guerra. Molti Taresi vennero catturati tuttavia dai tedeschi, stipati e sigillati in carri bestiame, privi di acqua e pane e trasferiti in campi di concentramento in Germania. A Parma venne arrestato Malpeli Lino di Abramo; in Croazia Malpeli Alessandro di Luigi; in Grecia Tabarroni Renato e Mazza Gianni di Luigi; in Francia Chierici Antonio e Meschi Basilio di Giovanni; in Jugoslavia Brizzolara Giovanni di Luigi; mentre Dellapina Ernesto di Giuseppe fu catturato a Udine.
COME SI FORMÒ ILCORPO VOLONTARI DELLA LIBERTÀ
Costituendo la Repubblica Sociale Italiana, Mussolini intese richiamare alle armi tutti i militari che avevano volontariamente abbandonato il loro corpo dopo l’otto Settembre alla proclamazione dell’Armistizio. La maggioranza, però i così detti « Badogliani » preferirono non presentarsi e abbandonate le proprie famiglie, salirono sui monti, si costituirono in bande armate denominandosi « Corpo volontari della Libertà ». Come reazione, la Repubblica Sociale Fascista formò i primi reparti di Guardia Nazionale antiguerriglia per combattere questi «ribelli» fuori-legge emanando contemporaneamente, su richiesta tedesca, il decreto di pena di morte per quanti venissero catturarti con le armi in pugno.
Le varie « bande» inizialmente portavano il nome di battaglia del loro capo, così si aveva la banda di « Golico» (poi Scarpa) la banda dell’lstriano, quella di Bill, di Richetto, Virgola, Canepa, Berretta, Dragotte ecc. Ricorderemo come puro fatto di cronaca, preludio di guerra, la caduta di un quadrimotore da bombardamento alleato colpito dalla contraerea di Genova e finito sul M. Zatta m. 1125 a pochi metri dal Sanatorio – Collegio della fondazione Devoto.
Una suora addetta al collegio così ricorda l’avvenimento. Erano le ore 20 del 24 Novembre 1943 mandati a riposare nelle loro camerate i 118 bambini e bimbe con il tradizionale « buona notte» la Comunità si raccoglieva in refettorio per disporre il lavoro del giorno dopo quando l’oscurità fu rotta da accecanti bagliori e cupi boati fecero trasalire tutti i presenti. « Che c’è? Che succede? », furono le sole parole che uscirono dalle nostre labbra tremanti. Non ci fu il tempo materiale di prendere visione del fatto, che una bomba caduta a pochi metri dal collegio, esplodeva mandando in frantumi centinaia di vetri, schiantando porte, abbattendo finestre ed atterrando mobili. Fu un fuggi di bimbi scalzi, appena coperti, un precipitare dalle scale, un invocar l’aiuto della Vergine Ausiliatrice!
Quando tutti ebbero raggiunto il rifugio e al terrore subentrò una relativa calma, si venne a sapere che era caduto a pochi metri dalla casa incendiandosi un aereo anglo-americano che portava a bordo otto uomini e sette bombe di cui una sola era esplosa. La notte era tetra, un vento gagliardo fischiava rabbiosamente fra i faggi, la pioggia veniva a rovescio. L’equipaggio colpito perdeva cinque uomini; gli altri tre avevano evitato la catastrofe col paracadute e di loro non si seppe più nulla. Se la Madonna, così ardentemente invocata, non fosse prontamente intervenuta, parte del gran caseggiato sarebbe andato nella sua tremenda rovina ». Lo scoppio fragoroso che si ripercosse in tutta la valle, fu scambiato per un tuono del furioso temporale in corso e solo al mattino, sparsasi la voce della tragedia, fu un accorrere continuo di gente da tutti i paesi vicini per vedere l’immane cratere e la scena macabra che presentavano gli aviatori morti, alcuni dei quali interamente bruciati.
COLPI DI MANO
Il 23 Settembre 1944 giorno di sabato, con mercato a Bedonia, assieme a un gruppo di sabotatori, aiutati da scalpellini locali, i partigiani del nostro gruppo fanno brillare alcune mine in località « Trovina» sopra Piane di Carniglia, allo scopo di interrompere la strada Bedonia – Chiavari. La squadra sabotatori che era composta quasi completamente di Tornolesi ,anziché rientrare subito al distaccamento decide di rientrare, ciascuno a casa propria per passare la domenica in famiglia. Al paesello mi veniva riferito che il Tenente Collini (Comandante del presidio « Monterosa » a Passo Cento Croci, già laureando in ingegneria di Bologna e ottima conoscenza studentesca) faceva puntate quasi quotidianamente in Paese a bordo di una motocarrozzetta. Anzi, per il lunedì25 Settembre aveva ordinato al messo comunale, Sig. Lusardi Luigi ufficiale di stato civile, di preparare un elenco di tutti gli iscritti nelle liste di leva dal 1915 al 1926.
La decisione viene immediata ed unanime: aspettare il lunedì 25-9 mattina e in accordo con Emanuelli Giuseppe, locale dirigente della Sezione Annonaria e nostro ottimo informatore, andare in Comune e prelevare tutta l’anagrafe. Così fu, insaccati tutti i cartellini anagrafici in due bisacce da « carbone» li portiamo a nascondere nel sotto tetto della Chiesa di S. Rocco. Poi assieme agli amici Dalmi Casimiro, Ponzini Gino e Milani Camillo, proseguiamo sulla strada di Tarsogno per cercare di prelevare il tenente fuori dall’abitato, prima del suo arrivo in paese. Verso mezzogiorno, non vedendolo arrivare ed avvertiti che a Cento Croci già sapevano della nostra presenza, decidiamo il rientro, ripromettendoci di ritornare in forze, per un colpo di mano più impegnativo.
Il mercoledì 27 Settembre siamo nuovamente sul posto con un’intera squadra; ci accompagna lo stesso comandante del distaccamento Turco, Rossi « Dartagnan »; Per impedire le spiate, saliamo non visti da Villa Cerri, appostandoci prima in « Gainà » poi in località « Fontanellato », da dove era possibile prendere d’infilata con i mitra la strada quasi in rettilineo. Le ore passano, arriva mezzogiorno e non si vede nessuno; comincia una fitta pioggerellina che penetra nelle ossa; « Dartagnan » rinuncia alla cattura del tenente Collini e per non tornare a mani vuote, decide di convergere su Tarsogno dal monte, via Ravezza e Reneroni, dove arriviamo inaspettati e senza essere visti. Al Poggiolo come si accorgono della nostra presenza, la gente fugge a chiudersi in casa, gridandoci che in paese ci sono molti alpini. Incontro Lunardini Giorgio che cercando di convincermi ad andarmene mi offre per riparo un’ombrella da donna scassata. Scendiamo alla Crocetta, davanti alla trattoria di « Baldo»; troviamo fermo un carro della « Monterosa » trainato da due muli di razza
« alsaziana » enormi per mole. Dartagnan e Casimiro entrano al grido di « mani in alto », e « viva la libertà ». Esce subito di volata un tenente-medico con « Berretta » in mano che di fronte al mio mitra non ha problemi a consegnarmi la pistola e ad arrendersi. Il fatto mi è rimasto scolpito nella mente, non per l’azione in sè stessa, ma perché la rivoltella del tenente-medico era ingrassata e lucidata di fresco. . . tanto che dalla canna su di me puntata, usciva lo stoppino e alla mia richiesta di consegna, fatta in forma quasi comica, il tenente medico me l’allungava immediatamente” constatai che l’arma era ancora in sicura e con cane abbassato.
A cassetta sulla carretta sale « Casimiro con a fianco un sergente a mani legate, il quale gli coprirà il fianco destro. Io ed il tenente ci corichiamo all’interno della carretta sopra due quintali di patate. Il momento più pericoloso veniva al passare sullo stradale davanti a Villa Parmigiani, di fronte al campanile che fungeva da osservatorio e stazione RT, dove vistosamente era piazzato un mitragliatore. Comunque usciti dall’abitato i due muli furono lanciati al galoppo, la carretta su fondo ghiaioso saltava in maniera dannata; dal campanile eravamo seguiti a vista, ma il sergente faceva da scudo al conducente. Il tenente medico completava la copertura ergendosi in mezzo alle patate che saltavano come grilli, reggendo una bottiglia di marsala in mano, mentre sotto, sempre con il mitra puntato, gli continuavo a ripetere che se si chinava o rovesciava la marsala per lui era finita.
Così sfilammo indenni senza sparare un colpo. Un caporale e altri due alpini invece avevano seguito « Dartagnan » e gli altri via Reneroni, per la strada che avevamo fatto a piedi e a cavallo nell’andata. All’arrivo il tripudio fu grande, l’attraversamento del paese di Bedonia alla sera, fu quasi un trionfo e solo in nottata rientrammo alla nostra base in Selvola. Lassù in distaccamento arrivarono gli alpini affamati, trovarono avanzi di pastasciutta e al tenente offrii pane e latte in una fondina. A questo punto il loro umore cambiò e abbandonate le paure; si sciolsero in confidenze, rivelandoci che dal Cento Croci erano scesi per un po’ di spesa a Tarsogno e poter organizzare una festa per il sabato aspettando la visita del Comandante della Monterosa in persona e forse alla presenza dello stesso Maresciallo Graziani. Ecco come il fatto viene descritto, 30 anni dopo dalla studentessa Paola Bronzini, sulla base di racconti tramandati in famiglia e riportati nel volume di, ricerche scolastiche « La Scuola di Tarsogno » a cura del Prof. Luigi Trombi:
COME FURONO ORGANIZZATI I PRIMI LANCI
Credo che sia mio dovere correggere una discordanza nel racconto di Don Domenica, forse tradito dalla memoria sul tempo di guerriglia. Il primo lancio tutto « Inglese» al gruppo di Gianni Moglia « Golico » avvenne sul Monte Orocco, sopra Spora di Bedonia il 24-2-1944, tramite un’agente inglese dell’« Intelligence Service » munito di stazione RT piazzata alle Cabanne di Rezzoaglio, Genova. Golico arrivò al contatto tramite un carabiniere dei Travaglini, Botti Giovanni, che prestava servizio alla stazione dei CC di Rezzoaglio e godeva della fiducia del suo comandante, maresciallo Luigi Monaco, agente del gruppo « Dieci» sotto il controllo della organizzazione O.T.T.O. di Genova.
Il gruppo O.T.T.O. fu uno dei primi in Italia, operante e collegato con il governo alleato di Algeri, organizzatore fra l’altro anche di espatri clandestini per ex prigionieri di guerra verso la Corsica, utilizzando, dopo averli opportunamente attrezzati, moto-pescherecci in disuso. Del gruppo facevano parte il Prof. Ottorino Balduzzi, capo fondatore, oltre a molti illustri personaggi della Resistenza come il Cap. Vincenzo Cardinale, Roggero” Li Gobbi Edgardo Sogno. La sigla O.T.T.O. derivata all’inizio dal nome del suo fondatore venne poi rettificata in Organizzazione Territori Temporaneamente Occupati. Quando il 31 marzo 1944 il controspionaggio Tedesco eliminò tutto il gruppo in Genova inviando a Mauthausen il Prof. Balduzzi Ottorino, molti suoi esponenti sfuggiti alla cattura, si trasferirono in tempo in altre zone, dove diedero vita a nuovi gruppi che rinnovarono ampliandoli il collegamento via radio con «1’lntelligence Service» di Londra. Il Prof. Ottorino Balduzzi da Mauthausen verrà inviato in un ospedale militare speciale e di qui, in collegamento con gruppi antinazisti austriaci raggiungerà Linz, lo rivedremo alla fine della guerra in Alto Adige, componente del Comitato di Liberazione.
Edgardo Sogno con una fuga rocambolesca dalla casa dello studente, più tristemente nota come luogo di torture, passò in Lombardia e diede vita alla nuova organizzazione « Franchi» che per le sue imprese coraggiose, diventerà famoso, per temerarietà, sprezzo del pericolo in tante avventure, che raccontate oggi hanno del favoloso, pur sempre coronate da successo. Il Maresciallo dei CC. Monaco Luigi di Rezzoaglio, proseguì autonomamente come gruppo D.I.E.C.L in collaborazione con Ufficiali Inglesi, nascosti a Farfanosa e Gabanne. Nell’ardimentoso incarico si avvalse della collaborazione di tutti i suoi carabinieri, fra i quali in modo particolare ricorderemo Gardella e il nostro Botti Giovanni di Travaglini. Contattata Londra si stabilirono due messaggi di collegamento che venivano poi ritrasmessi in fondo alla rubrica politica della «B.B.C. » London Colen Italy, quattro volte al giorno.
Un primo messaggio, da noi in gergo chiamato negativo, confermava che avevano ricevuto la nostra richiesta di lancio e nel caso specifico era « Il Corriere di Lione». Da quel primo annuncio preparavamo la zona lancio dotandola di paglia e fascine per i fuochi, predisponendo più persone in continuo ascolto di Radio Londra in trepida attesa del messaggio di conferma. Entro una decina di giorni veniva poi trasmesso il messaggio « positivo » che per noi era « I promessi sposi». Dopo quella conferma si passava alla fase operativa e una squadra si trasferiva in zona lancio pronta ad accendere i fuochi segnaletici al primo rumore di apparecchio.
L’aereo arrivava al buio, girava in cerchio sulla zona segnalata e dalla disposizione dei fuochi il pilota capiva la direzione di lancio, sganciava con passaggi bassi a più riprese e ripartiva. Con lo smembramento della missione O.T.T.O, fu giocoforza rivedere le frasi e tutti i sistemi del contatti ormai a conoscenza anche del nemico. Accadde più di una volta che accesi i fuochi segnaletici anziché il lancio in armamenti, vestiario e viveri si verificasse un bombardamento Tedesco in piena regola con mitragliamenti e sganciamento di spezzoni. Pertanto dopo il rastrellamento di maggio « Golico » cambiò il proprio nome in « Scarpa» così che
« Il Corriere di Lione » fu aggiornato con il messaggio « Abbiamo le scarpe rotte» senza alcun riferimento al nostro amato. . . comandante. Segnalerò anche un fatto curioso che ci provocò notevoli difficoltà di « gestione » sui primi lanci, dovuto principalmente alla perfetta organizzazione militare inglese. Vennero lanciati con i grossi paracaduti di seta, anche alcuni bidoni di scarponi militari, però tutti di piede sinistro, molto probabilmente i bidoni con le destre finirono in altra zona a noi non nota. Più tardi a chiudere interminabili polemiche all’interno, (oltre alla inutile ricerca su chi si era « fregato » i bidoni degli scarponi destri ), da un ufficiale inglese si seppe che il magazzinaggio delle scarpe avveniva non per paia ma per numero; una ditta faceva in serie solo le destre un’altra solo le sinistre. In questo modo l’amministrazione militare inglese eliminava in partenza la vendita sottobanco ai civili, come per impedire che l’occasione « facesse l’uomo ladro ».
Comunque gli scarponi « sinistri» non vennero buttati, ma i nostri esperti calzolai della zona li scucirono e con un buon « guardolo » in corame le rimontarono a mano creando scarponi più robusti, in anfibio, inattaccabili dalla pioggia, certamente più eleganti. Fu possibile un totale recupero per il motivò che il numero più piccolo inglese era il cm. 42 . . . lasciava pertanto un margine valido di gioco e un ritaglio, ai nostri bravi artigiani locali.
Diario dei ricordi 25 luglio 1943 12 agosto 1945 di Dellacasa don Domenico <<Dado>>Parroco di Chiesiola di Bedonia
25 Luglio 1943 Dimissioni di Benito Mussolini
8 Settembre 1943

Don Domenica Dallacasa «Dado»
Il 26 luglio 1943 mi trovavo a Spora dove si celebrava, in tale data, la ricorrenza della festa della titolare della parrocchia: S. Anna. Terminato il canto della messa solenne, si era sparsa la voce che il giorno prima il Duce era stato costretto a dimettersi: era stato incarcerato e sostituito dal Re Vittorio Emanuele III con la persona del generale Badoglio. La nuova ci era giunta solo il 26, anche se l’avvenimento era successo il giorno prima, per il fatto che nessuno in parrocchia era in possesso di una radiolina,… la notizia quindi ci era giunta… a piedi.
Una notizia tanto sensazionale ci lasciò lì per lì indifferenti; non perché non meritasse la nostra attenzione, ma perché una enormità simile ci sembrava impossibile! Ma come!? Fino al giorno prima il Fascismo era invincibile, il Fondatore dell’Impero non si era mai piegato davanti a nessuno, ed ora si trovava in carcere? Ma chi aveva avuto tanto coraggio da ordinare e compiere un gesto simile? Dato e non concesso che ciò fosse vero, come faremo ora senza Capo;… senza il Duce?
Solo tardi, nella serata, ho potuto sentire dalla radiolina della signora Lusardi Angiolina ad Anzola i particolari che si potevano, più che sentire, intuire, da una radio che gracchiava maledettamente.
La notizia, tanto sensazionale, era ormai certa!
Da quel momento, anche nei nostri paesetti di montagna, si era avverato quello che avveniva in tutta l’Italia.
Se prima, il Duce, con il suo fascismo, era parso insostituibile, tanti che erano stati costretti a prendere la tessera fascista, per sopravvivere era diventata più necessaria della stessa carta annonaria, sconfessavano la loro fede fascista per timore di rappresaglie. Questi ex-fascisti erano additati con disprezzo come i capri espiatori delle angherie che avevamo dovuto subire fino al giorno prima.
Questo stato d’animo poteva degenerare e intaccare quello spirito di solidarietà che, sostenuto dalla fede cristiana, è una caratteristica dei piccoli paesi di montagna. Il sacerdote quindi, anche se da tutti conosciuto per la sua fede antifascista, doveva fare opera di mediazione per calmare gli animi e indurli a più miti consigli mostrando che l’odio e la vendetta, che sorgevano allora spontanei, non potevano portare che a mali maggiori di quelli da cui ci si era liberati. Non pochi, anche nella vallata del Ceno, erano additati come ferventi fascisti, specialmente fra coloro che fino a poco tempo prima avevano soggiornato all’estero. Fuori d’Italia erano stati aiutati moralmente ed economicamente dall’allora governo fascista, era quindi naturale, per loro, provare una certa stima, considerazione e riconoscenza verso chi li aveva allora aiutati.
Questo loro atteggiamento era pericoloso esternarlo! Quindi il parroco, come persona a cui ci si rivolgeva per ogni cosa, anche fuori del campo prettamente religioso, interveniva per sedare gli animi e spiegare come veramente stavano le cose prima e poi, inducendo i propri parrocchiani a non dividersi per avvenimenti in cui avevano avuto una parte tanto marginale come protagonisti. La nomina di Pietro Badoglio faceva supporre che tutto sarebbe cambiato, e siamo stati di questa idea fino ai giorni prossimi al fatidico 8 SETTEMBRE. La notizia dell’armistizio dell’8 settembre ci è pervenuta come una nuova notizia di liberazione, di respiro, di sollievo, di gioia. Finalmente finirà questa benedetta guerra!!! Avremo finalmente un po’ di quiete, ritorneranno i nostri giovani, i nostri richiamati.
Difatti nei giorni successivi molti giovani, e non più giovani, passavano per i nostri paesetti. Erano reduci che avevano i loro cari in tutte le parti d’ Italia: napoletani, siciliani, pugliesi, romani, toscani, veneti ecc. ecc. Erano male in arnese come vestiti, affamati, e tutti chiedevano un po’ di cibo, e verso sera, poi, anche il permesso di coricarsi sul fieno delle nostre cascine, ripromettendosi di rimettersi per strada il mattino dopo, per tempo, ed avviarsi nella direzione delle loro case. La popolazione del luogo, buona e caritatevole, comprendeva le condizioni, non solo fisiche, ma soprattutto morali di questi sbandati, e li accoglieva, facendo li partecipi dei loro desinari.
Questi accettavano questa offerta disinteressata, ma pochi parlavano, La maggior parte delle volte, specialmente coloro che passavano nei primi giorni di questo viavai, preferivano non entrare neppure nelle case, ma, muti, oppure parlando solo fra loro, mangiavano quanto veniva loro offerto e poi con un – grazie! -, che, si vedeva, veniva dal cuore, ripartivano. I parrocchiani, nel compiere questo gesto, dicevano: – Speriamo che in qualche parte d’Italia, dove si trovano i nostri figli, anch’essi possano trovare la carità che ora noi compiamo verso questi sconosciuti!
Questi giovani, come ho detto, dimostravano una certa diffidenza verso gli abitanti del luogo. Del resto era più che giustificabile il loro atteggiamento stante la confusione da cui erano scappati, e quella che trovavano per via, nelle località dove transitavano. La loro diffidenza dipendeva anche dal fatto che non conoscevano coloro che li soccorrevano: Coloro che li accoglievano erano dalla loro parte, cioè di coloro che, una volta liberi, desideravano una cosa sola: arrivare alle loro case se era possibile? Oppure si trovavano fra persone che potevano fare loro del male denunciando alle autorità la loro fuga e perciò anche la direzione del loro viaggio in modo che venissero rintracciati
Chiedevano notizie. Notizie che neppure noi potevamo dare per certe. Quando infine si è saputo della reazione tedesca, qualcuno dei fuggiaschi chiedeva, se poteva fermarsi, offrendo il proprio lavoro, ancor valido, in cambio di un pagliericcio e di un po’ di cibo, nella speranza di poter presto riprendere il cammino verso casa. Tutti si pensava che questo periodo di confusione dovesse durare poco.
Primi arrivi di sfollati a Chiesiola La famiglia Mangiante
In quei giorni si presentò alla porta della mia canonica l’Ingegnere Mangiante Daniele di Lavagna, accompagnato dalla sua donna di servizio: Beccarelli Maria, per chiedermi se potevo accoglierlo per un mesetto, cioè fino a quando a questo caos non fosse seguito un po’ di calma, con il resto della famiglia, rimasta a Lavagna. Come si era ottimisti in quei giorni! In una circostanza come questa mi si chiedeva che cedessi una parte della mia canonica! Io non conoscevo nessuno dei due! Accettarli o no?
Maria aveva una zia, mia parrocchiana: una buona donna. E con questa garanzia, cioè la onestà e la bontà di una zia mi sono indotto a non negare quanto mi veniva chiesto, comprendendo, anche se non pienamente, il rischio a cui andavo incontro, perché il buon ingegnere mi confessò candidamente che era ricercato, perché, negli anni precedenti, senza pensare troppo alle conseguenze del suo gesto, aveva fatto parte della Milizia Fascista, ma solo trascinato da alcune circostanze di cui non era mai stato convinto. Dopo aver avuto la mia parola, che avrei aperto la mia porta alla sua famiglia, e dopo avermi promesso che, qualora mi fosse di disagio, avrebbe cercato altrove rifugio, l’ingegnere si portò all’abitazione della zia della Maria alle Galêre, in attesa che la stessa Maria, ritornando a Lavagna, conducesse a Chiesiola il resto della famiglia, cioè la signora Ester coi bambini: Cipriano di 7 anni ed Eugenio di 3 con la bambinaia Borzoni Giuseppina.
Mi permetto di soffermarmi su questa famiglia! Come ho detto, in un primo tempo ho visto nel loro ingresso in casa mia, un disturbo alla mia quiete. Abitavo da solo in canonica! Da circa tre anni ero senza donna di servizio; la mia unica sorella Angela si trovava a Casaliggio, presso mio zio Don Pietro Delchiappo, arciprete di quella parrocchia. Chi si abitua alla solitudine (e noto: alla solitudine di una canonica) non tanto facilmente tollera che lo si venga a turbare nel suo tran-tran sacerdotale, specialmente se ci sono in giro dei bambini piccoli che piangono (vedi Eugenio)! Allora non potevo neppure immaginare i pericoli e le traversie che avrei dovuto attraversare nei mesi seguenti.
Con tutto ciò al buon ingegnere ho detto un sì di cui in quel momento non ho colto tutte le conseguenze. La prudenza mi doveva consigliare di ripensarci su per non pentirmi di un passo affrettato e forse incauto, eppure credo che anche in questo caso, ci abbia messo lo zampino la Divina Provvidenza! Se il Signore, in quel momento, si serviva di me per porgere un aiuto urgente e necessario a chi veramente aveva bisogno, non mi sono mai pentito di aver agito come ho agito. La famiglia Mangiante per me é stata veramente la mano della provvidenza! E non solo per me, ma anche per la mia parrocchia… e non solo per la mia parrocchia.
Se non avessi avuto vicino in quei momenti di pericolo il caro ingegnere, in qualche circostanza avrei agito in modo da… non potermene neppure pentire. L’opera di mediazione e di assistenza della signora Ester, sia per me che per il paese, è stata una cosa che non potrò mai dimenticare; la sua premura per chi aveva bisogno di soccorso, di consiglio è risultato un vero tratto dalla Divina Provvidenza! Di questo sono buoni testimoni i partigiani che trovarono in lei che tentava (e ci riusciva) di supplire la buona mamma che essi avevano dovuto lasciare a casa. La cura, che aveva per loro, feriti e moralmente a terra, suscitava in chi ne era oggetto, una stima e una riconoscenza che non si è spenta con la fine della guerra!
Anche i paesani hanno sempre trovato in lei e nel marito delle persone sempre pronte a correre dove la loro opera era necessaria. Per esimersi da questi gesti di bontà non era motivo sufficiente il non conoscere chi aveva bisogno del loro aiuto. Essi si sono prestati con grave sacrificio e spesso con loro grave pericolo. Quando si avvicinava qualche rastrellamento o era in procinto qualche altro avvenimento che poteva interessare il paese, i parrocchiani dicevano: Speriamo che, anche questa volta, la signora della canonica (così era chiamata la signora Ester), ce la faccia. La mia riconoscenza per questa famiglia, anche se non sempre l’ho dimostrata, è stata ed è profonda e sentita. GRAZIE di quanto hanno fatto per me e per la mia parrocchia!
Momenti d incertezza attesa Gli sbandati dopo l’8 settembre 1943
Il caso dell’ingegnere Mangiante, che per potersi sentire più sicuro, si era rifugiato in montagna, non era singolo. In quei giorni, in cui erano ricercati, sia dai fascisti repubblichini, che dai tedeschi, tanto i… fascisti che avevano tradito la causa fascista, quanto coloro che erano fuggiti dall’esercito dopo l’otto settembre. Soprattutto coloro che non si erano presentati alle armi neppure in seguito ai proclami infuocati del generale Graziani, allora ministro della Guerra della Repubblica Sociale Italiana. Nei nostri paesetti, fuori della comodità delle strade, che quindi presentavano la possibilità di nascondersi con maggiore facilità che nei centri, si videro uomini e giovani, e in qualche caso, famiglie intere, che avevano abbandonato casa e tutto per ripararsi dalla ferocia con cui si presentavano le truppe tedesche e repubblichine.
A queste persone, pervenute da Bedonia, qualcuna anche dal Borgotarese, da Parma e dalla Liguria (fra i quali il fratello dell’ingegnere Mangiante: il dottor Giacomo con la famiglia), oltre che offrire, nelle proprie possibilità, ospitalità, si cercava di rinfrancarli con l’aiuto materiale e soprattutto morale. In un primo tempo, quando si trattava di dare un piatto di minestra, un pezzo di pane ed un pagliericcio agli sbandati, l’esiguità delle porzioni della carta annonaria non fermò la carità genuina della nostra gente che si esternava con apertura d’animo veramente cristiana. Quando invece si presentarono questi gruppi di persone estranee che mostravano la loro intenzione di volersi fermare non per poco, ma fino alla fine del conflitto, ecco che spuntò il tradizionale animo diffidente del montanaro. In questi casi l’opera del parroco era necessaria. Gli sfollati si presentavano a lui, dopo le prime ripulse da parte della gente del luogo, pregandolo che facesse opera di persuasione perché venissero ospitati.
Non era un compito facile!! Il parroco conosceva i suoi compaesani ed anche gli abitanti dei paesi vicini, ma i nuovi arrivati chi erano? Ci si poteva fidare delle loro assicurazioni che erano gente per bene? Qualcuno, per riuscire più facilmente ad ottenere l’appoggio del sacerdote, portava come argomento, addirittura una loro parentela, anche se lontana, con un sacerdote, assolutamente sconosciuto al sottoscritto. Il rischio a cui andava incontro il sacerdote in questi casi, non era da poco, perché la popolazione locale si fidava molto del sacerdote.
Tra l’altro non li si poteva lasciare su una strada! La cara Madonna di San Marco in questi casi mi ha veramente aiutato. Quelli che, da me raccomandati, sono stati accettati in casa da parrocchiani, sia di Chiesiola, che di Fornolo, Casalporino, Volpara, Selvola ed Anzola, non mi hanno fatto pentire del mio interessamento per loro. Anzi fra gli sfollati ed i loro ospitanti, è sorta un’amicizia che, anche dopo trent’anni, è ancora viva perché sorta da un gesto di carità, sgorgata in un momento di comune pericolo. In quei giorni le nostre chiesette erano molto frequentate, e se la devozione che si dimostrava, era un po’ data dalle circostanze, sono certo che ne hanno ricavato un bene spirituale vicendevole tanto gli abitanti del luogo, quanto gli sfollati.
Prime formazioni di ribelli a Chiesiola Moglia Gianni «Golico)
Fra coloro che l’otto settembre avevano preso la strada di casa, non intendendo condividere il destino della Repubblica Sociale Italiana, si trovava anche Moglia Gianni (Golico). Egli, benché di famiglia bedoniese, si considerava di Chiesiola, dopo che, qualche anno prima, aveva sposato la signorina Moglia Rina, parrocchiana di Chiesiola. Infatti con la moglie e la bambina Gabriella, si era portato presso i suoceri che abitavano nella «Montà», frazioncina di Chiesiola.
Lo incontravo spesso, ed un giorno mi parlò di gruppi di sbandati che, in altre zone, si erano riuniti in squadre, che intendevano opporsi al richiamo alle armi, e nello stesso tempo, anche all’azione dei fascisti e dei tedeschi. Egli, d’accordo con qualche altro amico, intendeva fare altrettanto nella zona del Ceno, località dove la guerriglia era possibile per l’asperità del luogo. Non avendo avuto la possibilità di potersi servire, come luogo di ritrovo, della casa del suocero, che non vedeva di buon occhio queste riunioni segrete, si rivolse a me per vedere se ero disposto ad accoglierlo con gli amici nella mia canonica.
Nella speranza che i miei ospiti di Lavagna non avessero nulla in contrario, acconsentii ben volentieri ad accontentarlo. Infatti dopo qualche giorno dal nostro colloquio, un gruppo di giovani ex-militari tennero la loro prima riunione in casa mia. Più tardi seppi che a Bedonia, il Moglia, precedentemente, si era trovato con altri amici per trattare di questo argomento ed insieme avevano deciso di riunirsi fuori del centro di Bedonia per poter agire più tranquillamente. La scelta della località cadde su Chiesiola dopo che avevo acconsentito ad aderire alloro movimento. Dopo le prime riunioni nella mia cucinetta, un giorno l’ingegnere Mangiante mi prese a tu per tu, e mi chiese, con gentilezza, quale era lo scopo delle riunioni notturne in canonica.
A dir il vero, avevo mancato verso di lui e la sua famiglia non mettendo la al corrente di quelle adunanze e del pericolo che con me correva anche la sua famiglia. Con schiettezza, conoscendo la lealtà e la franchezza dell’ingegnere, gli esposi il motivo di quei ritrovi. Egli sospettava qualche cosa del genere e mi dichiarò la preoccupazione per la sua famiglia. Era sfollato da Lavagna per sottrarsi ad un pericolo eventuale, ed era venuto a mettersi in un pericolo ora certo. Lo assicurai che, almeno per allora, di pericolo non ce n’era ancora, anzi, per mostrargli la verità di quanto gli dicevo, gli promisi che avrei chiesto ai ribelli (così si chiamavano allora) di permettergli di assistere alle nostre adunanze.
Potei vedere, dopo qualche ora, Moglia Gianni e gli proposi di invitare all’adunanza di quella stessa sera l’ingegnere. Gianni, che aveva già fatto conoscenza con l’ingegnere, accolse con gioia la mia proposta. Durante detta adunanza Gianni e gli altri presenti convinsero l’ingegnere della bontà della loro causa, per cui da allora in poi, fece parte dell’ancora esiguo gruppo dei ribelli, e mise a disposizione dei suoi nuovi amici le sue cognizioni tecniche, cognizioni che non poche volte sono state di grande utilità alla sorgente brigata dei partigiani. L’esiguo numero dei primi aumentò con l’adesione, oltre che di quelli del luogo, anche di coloro che dal di fuori, avevano cercato rifugio fra i monti. .
Per gli abitanti questo fatto faceva perdere al movimento per loro l’aspetto della clandestinità, e stava prendendo l’aspetto organizzativo ed aperto di cui si sentiva la necessità perché potesse veramente essere efficiente.
Questo nuovo aspetto dell’avvenimento poteva suscitare nell’animo dei montanari un sentimento di paura pensando alle conseguenze di cui potevano diventare protagonisti. Quella incertezza di una scelta e la paura che poteva allontanarli dal movimento partigiano non si manifestò, anzi compresero che il loro concorso, almeno indiretto, era necessario. Ecco che questo apporto si esternò in fatti concreti: in tutte le parrocchie della vallata erano pochissimi i giovani che non facevano parte dei ribelli; i ribelli trovarono sempre assistenza in ogni famiglia si presentassero. In qualche famiglia non passava giorno che non dovessero dare vitto e qualche volta anche alloggio a partigiani di passaggio.
Non poche sono state le famiglie che hanno ospitato partigiani per tutto il tempo della lotta clandestina, nascondendo vestiti, armi e munizioni con gravissimo loro pericolo specialmente nei periodi di rastrellamento. I buchi delle case di montagna erano nascondigli che non c’era fiuto di segugio tedesco o fascista che potesse scovarli. La canonica di Chiesiola era fra questi nascondigli, e se le cose nei momenti di trepidazione sono sempre andate bene, credo che la Madonna ci abbia messo la sua mano.
Meritavamo allora questa assistenza particolare? Forse no, ad ogni modo, in quei momenti anche i meno… cristiani pregavano veramente di cuore Aumentando continuamente il numero degli aderenti al movimento partigiano si dovette dividerli in squadre; squadre dislocate in diverse località della vallata, a capo delle quali era stato designato un caposquadra ed eventualmente vice caposquadra. Il compito di comandante generale era stato affidato a Gianni Moglia (Golico).
Le squadre erano dislocate a Casalporino (caposquadra: Dragotte), a Tomba (cap. Bill), a Costa d’Azetta (cap. Mario), a Volpara (Cap. Istriano), a Fontanin (Cap. Cosimo). Con queste squadre sparse un po’ dovunque non c’era la possibilità per loro di soddisfare ai doveri religiosi con regolarità, anche se lo desideravano. Noto che la quasi totalità degli allora detti ribelli, erano buoni cristiani, anche se poi, in seguito, vennero annoverati fra i partigiani di Brigate Garibaldi, Comunisti. Per potere dare loro la possibilità di vedere ogni tanto un sacerdote, mi recavo sovente, senza però un programma regolare, a visitare le diverse squadre.
Dopo le prime visite, che hanno recato una sorpresa nei giovani, e durante le quali non c’era quella confidenza che desideravo, una buona parte di essi apriva l’animo all’azione del sacerdote. Erano giovani, che in un primo tempo, pensavano che la loro volontaria accettazione a fare parte della brigata dovesse avere breve durata, invece, giorno per giorno, sembrava loro che la fine della guerra si allontanasse sempre di più. Con questi sentimenti accoglievano volentieri una parola di conforto; conforto per la lontananza dai propri cari che Qualcuno non aveva visto da parecchi mesi. Forse non tutti erano sinceri ed aperti col sacerdote, e da costoro egli veniva accolto quasi come un estraneo; per questo mi spiego la condotta non sempre buona di qualcuno. Però sono convinto ancora che se tutti i sacerdoti avessero accostato di più questi giovani, forse nessuno avrebbe commesso azioni di cui in seguito poteva essere biasimato.
Non è stato certo incoraggiante il gesto di quel parroco (che poi ho potuto accertare per vero), che ad un suo giovane, di animo e condotta buona, che si era recato a casa per visitare il padre ammalato, entrato in chiesa la domenica per ascoltare la santa messa, il sacerdote non volle iniziare il sacro rito finché il giovane non fosse uscito di chiesa, gratificandolo di titoli poco onorifici, per il semplice motivo che aveva aderito al movimento partigiano. Ma ce n’è voluto parecchio per quietare quel giovane e per spiegargli il perché del gesto del parroco… gesto che non ho capito allora, e non ho capito e potuto giustificare mai!
Il repubblichino Moglia Marco
Fra gli abitanti della vallata, che avevano aderito al partito fascista (al tempo del duce) vi era anche un mio parrocchiano: Moglia Marco. Egli era appartenuto alla Milizia Portuale di Zara ed aveva avuto una menzione onorevole per avere salvato la vita al suo superiore: il seniore Caruso. Trovatosi a casa, in licenza, quando scoppiò il fenomeno partigiano, credette più sicuro fermarsi a casa per la impossibilità, oltre che per il pericolo, di ritornare alla base. Il fatto di essere appartenuto alla Milizia non gli giovò, trovandosi in una località dove parecchi erano i partigiani, e dove, a pochi metri da casa sua, aveva addirittura la sede il comando. Per questo, venne avvertito che non si allontanasse di casa, perché, benché fosse un ottimo giovane, il comando temeva che potesse spiare e riferire notizie che riguardavano il movimento partigiano.
Disgraziatamente un giorno Marco dovette recarsi a Volpara per ragioni di famiglia. In tale località venne scorto da alcuni che facevano parte della squadra locale. Per questo fatto alcuni partigiani (non del posto), si accanirono contro di lui ed erano arrivati al punto di chiedere che venisse eliminato per togliere di mezzo, come dicevano essi, un pericolo permanente per la intera brigata. Mi c’è voluta tutta, per calmare gli animi, aiutato validamente dalla signora Mangiante, che aveva acquistato un certo ascendente sui ribelli per il suo altruismo e per il coraggio che dimostrava. Ci siamo fatti promettere da Marco che non sarebbe uscito dal paese se il comando non gliene avesse dato il permesso scritto.
I primi lanci alleati
Il comandante «Golico», tramite il Comando dei partigiani genovesi, era riuscito ad ottenere una serie di lanci nella nostra vallata. Il primo lancio ebbe luogo nella notte del 21 marzo 1944. Questi lanci erano preceduti da avvisi trasmessi da «La voce di Londra». La radio, che doveva ricevere questi messaggi era installata in canonica dopo essere stata sottratta ad una famiglia di fascisti di Santo Stefano d’Aveto. Ogni giorno dovevo sintonizzare la radio con l’onda trasmettitrice e riferire al comando. Ricordo che un pomeriggio (di lanci ne avevano già fatti, parecchi), ero intento ad ascoltare radio Londra quando fra gli altri messaggi, che a me non interessavano, sentii ben chiaro: «Promessi sposi».
Era il segnale per un lancio diretto alla nostra brigata. Di corsa uscii di casa per cercare Scarpa, ora intendente (aveva ceduto il comando a Bill), perché avvertisse gli interessati della trasmissione del messaggio e per preparare l’occorrente per il lancio. La brigata si era trasferita, per esercitazioni, nei pressi di Cornolo. Nei paraggi di Chiesiola c’era solamente lui con Resteghini Silvain, quindi mi pregò di andare con lui e Silvain per preparare i segnali necessari.
Come zona di lancio era stata scelta una località concava sul monte Orocco, situata tra il territorio delle parrocchie di Spora e Chiesiola. Ci trovammo tutti e tre sul posto, pronti ad accendere i fuochi-segnali. Ad un dato momento sentimmo il rumore di un aereo che si avvicinava. Sentii allora la voce di Scarpa che ci avvertiva di non fare nessun segnale, perché poteva essere un aereo tedesco, la cosiddetta Cicogna, perché non era ancora l’ora convenuta.
Infatti era veramente così. L’aereo fece due giri attorno all’Orocco avvolto nell’oscurità, e si allontanò dalla parte opposta da cui era venuto. Se avessimo acceso i falò sarebbe stato un disastro per noi quella notte, senza tener conto delle conseguenze che ne sarebbero derivate dopo, per la nostra imprudenza. Dopo circa mezz’ora del passaggio, ecco di nuovo il rumore di un altro aereo. Il rumore di questo secondo aereo era differente da quello del precedente. Scarpa gridò di accendere i fuochi. Eseguimmo l’ordine. Era un apparecchio inglese.
Infatti dopo due giri attorno ai nostri segnali si scorsero i paracaduti scendere pian piano. I primi caddero poco lontano dal luogo dove ci trovavamo, gli altri vennero portati dal vento verso l’abitato di Spora, per cui alcuni caddero addirittura presso alcune abitazioni di Pian di Boso, frazione di Spora. Una volta eseguito il lancio, ci portammo ancora in paese. Io rientrai in canonica, Scarpa e Silvain, invece, in piena notte, si portarono a Cornolo per avvertire la brigata dell’avvenuto lancio, perché un numero sufficiente di uomini si portasse sull’Orocco (circa 4 ore di mulattiera) per il recupero del materiale del lancio. Altri lanci sono stati effettuati sul monte Orocco. Alcuni però sono stati rimandati perché i messaggi erano stati captati dai tedeschi che, prima dell’orario stabilito, sorvolavano la zona dove il lancio doveva avvenire. Non poche volte si doveva aspettare una nuova trasmissione del medesimo messaggio per potere ottenere il lancio.
9 Aprile 1944 S. Pasqua Battaglia di Montevaccà
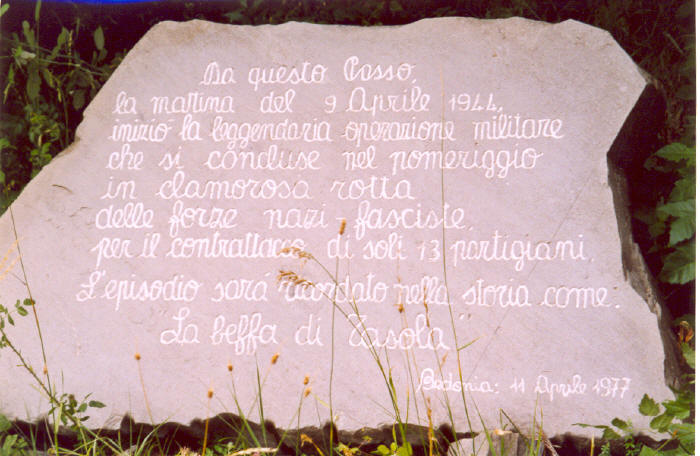

Il giorno che la pietà cristiana dedica alla pace ed alla fratellanza doveva segnare per la vallata del Ceno l’inizio di quel periodo che avrebbe lasciato dietro di sé distruzione, lagrime e morte. Fin dalle prime ore del mattino del giorno di Pasqua del 1944, 9 aprile, si sentiva già parlare di scontri armati. Sul mezzogiorno anche da Chiesiola si sentiva il crepitio delle armi automatiche. A Montevacà avveniva il primo scontro fra partigiani e tedeschi. Scontro accanito e sanguinoso fra tredici partigiani ed un centinaio di tedeschi.
I tedeschi e fascisti erano partiti da Bedonia e si volevano fare scudo della corriera, di Carpani, guidata dal nostro Lagasi Paolino. In un primo tempo Paolino ha cercato di evitare di prestarsi per un simile servizio, pericolosissimo per lui, poi, costretto dalla forza, dovette sedersi al volante. Giunti nei pressi del valico di Montevacà, i partigiani, che attendevano la colonna tedesca, aprirono il fuoco, ma, sopraffatti dal numero, dovettero ritirarsi verso Tasola, dove il combattimento continuò. .
L’autista, nella confusione del combattimento ed in mezzo ai proiettili che fischiavano da ogni parte, a malapena poté salvarsi con la fuga abbandonando l’automezzo. In tale circostanza ci furono nelle file dei partigiani un morto (Ruggeri Pietro di Porcigatone) e tre feriti (Libero, Battaglia e Pablo). I feriti vennero portati a Drusco, dove si trovavano alcune grotte ed in una di queste, non lontana dall’abitato, ma ben occultata dall’asperità del terreno, vennero ricoverati, curati ed assistiti dal Rev. Don Agostino Viviani, parroco di Drusco.
Siccome non sono mai riuscito da solo a raggiungere questi feriti per la perfetta mimetizzazione della località, che tra l’altro conoscevo abbastanza bene, finché essi sono stati costretti per le ferite a servirsi di questi inaccessibili ricoveri, mi sono dovuto fare accompagnare dal caro Don Viviani. I feriti erano impazienti di potere fare ritorno presto alloro posto di combattimento con uno spirito che, in certi momenti, credevo esagerato; ma che di fatto poi, si è dimostrato vivo e sincero. Erano tre giovani in gamba. Si dovette ripiegare a questi rifugi, per nulla comodi, almeno provvisoriamente, per non mettere in pericolo la popolazione, perché era logico pensare che i tedeschi sarebbero ritornati per compiere un rastrellamento, come di fatto avvenne di lì a poco.
Nadia Bertolotti ci racconta
NELLA STORIA DELLA SCUOLA DIT ARSOGNO LE PRIME BRIGATE NERE
Era l’inizio del 1944, tempi che per mangiare ci voleva la tessera. Mio nonno l’aveva a Miramonti. Il venerdì santo alle 9 di mattina andò a prendere la farina. Mentre Nino Forni stava pesando la sua razione, arrivarono i primi sintomi delle brigate nere. C’erano 8 macchine e 3 corriere con degli ostaggi presi su ad Albareto. Mio nonno si mise in cammino per venire a casa ma lo fermarono prigioniero. Sentirono una sparatoria: era la uccisione di Alice Scarsella. Ma i tedeschi (che erano con le camice nere) dicevano che erano attaccati dai partigiani e volevano portare mio nonno avanti nella loro macchina per scovare i partigiani. Piano piano lui ritornò in casa al Miramonti e si mise a parlare con un tedesco. Forni intanto levava del vino da una botte e ne bevvero 2 damigiane, poi si misero a bastonare i civili. Ne uccisero uno a Centocroci. Mio nonno poté tornare a casa alla notte di nascosto.
VENERDÌ SANTO 1944
Il giorno del venerdì santo del 1944 arrivò in paese una pattuglia del battaglione San Marco per un rastrellamento. Stavano cercando i partigiani che si nascondevano nei dintorni. Una ragazza di nome Alice Scarsella, vedendo i soldati, pensò di avvisare il fratello Giuseppe, perché si nascondesse. I soldati, vedendola attraversare il Vaiolo di corsa, le dissero di fermarsi. La ragazza forse non li sentì, forse pensò che era meglio rischiare e salvare il fratello, e proseguì. I militi del San Marco, credendo che fosse una staffetta dei partigiani, le spararono ed ella, colpita in pieno petto, morì. Lo stesso giorno spararono anche alla sorella e le sfiorarono i capelli: cadde svenuta e uno dei militi disse: – Sparagli ancora un colpo - E lascia perdere( non vedi che è morta? – rispose un altro. Così corsero dietro a suo fratello, ma si nascose nella macchia e non lo trovarono.
La madre, dal dolore morì di crepacuore.
I MONGOLI UBRIACHI
Una sera i mongoli erano nella Breva ubriachi. Penetrarono nella casa di una donna, la Rina. Quando arrivarono, gli uomini si nascosero e le donne rimasero impaurite. Uno disse che dovevano andare con loro; arrivò il capobanda e li portò via.
SCARSELLA ALICE
Tornolo 18-12-1914 Tornolo 7-4-1944 E’ la prima vittima civile della Resistenza di Tornolo e della Val Taro. Durante la Settimana Santa del ’44, l’Alta Val Taro viene investita da una combinata azione di fascisti e tedeschi partiti da Parma e dalla Liguria; viene investita la Val Gotra, il Passo Centocroci e le pendi ci del Penna. Nell’azione combinata che vede i primi scontri a Montevaccà e a Tasola, si ha per la prima volta un’azione di rastrellamento della popolazione civile, nel corso del quale vengono prelevati una ventina di ostaggi.
Scarsella Alice viene sorpresa dai fascisti, mentre sta accorrendo ad avvisare il fratello partigiano del gruppo « Centocroci » All’ alt dei fascisti, la ragazza non si ferma: i fascisti le sparano ed Alice viene uccisa.
BOMBARDAMENTI ALLEATI
E PRIME OPERAZIONI PARTIGIANE 1944
Conla caduta dell’apparecchio alleato sul M. Zatta a S. Maria Taro s’incominciò a sentire lo scoppio delle bombe, e a provare la sensazione di essere entrati nel vivo della guerra. Nel pomeriggio del giorno di carnevale, un aeroplano che volava a bassa quota, sganciò nei pressi di Pianlavagnolo tre bombe che con il loro scoppio, spaventarono non poco la popolazione. Durante la notte volava sempre a bassa quota, un aereo denominato « Pippo” (di giorno dormo di notte picchio) il quale sganciava bombe ovunque vedeva trapelare luci o fuochi. Una sera sul tardi sganciò anche a Vallombraia però fortunosamente come già a Pianlavagnolo, le bombe non causarono né vittime né danni. A provocare il bombardamento furono, molto probabilmente, le « braci» di un forno appena chiuso per il pane, nel momento in cui si rastrellano ancora accesi i ceppi e le ramaglie rimaste. La prima domenica di marzo arrivava da Chiavari un camioncino carico di merci varie e viaggiatori di fortuna. In località « Bilico» viene avvistato da un caccia, e dopo lungo mitragliamento fu colpito in pieno. Salvi miracolosamente nella cunetta sia l’autista che i passeggeri.
Sempre alla fine di febbraio un bombardiere alleato, colpito ed in avaria andò a cozzare contro la parete rocciosa del M. Penna vicino all’ Incisa in territorio di Amborzasco (GE). Si ritrovarono solo tre morti carbonizzati. Causa questi continui bombardamenti e mitragliamenti la popolazione non era più sicura di viaggiare a piedi o con mezzi di trasporto, perché era molto facile essere presi di mira dai caccia alleati. A seguito di questi fatti in molte parrocchie vennero sospese tutte le processioni e proibite le riunioni all’aperto. Le prime operazioni dei Patrioti ebbero per obiettivo le caserme dei C.C., che ci procuravano le armi necessarie a combattere l’invasore. Una sera di Febbraio alle ore 19 un gruppo di patrioti assaltò quella di S. Maria Taro, ma l’operazione fallì. Al riguardo sempre Don Celso Mori precisa che: « La caserma era stata preparata all’assedio: nell’interno della porta d’ingresso era stato costruito un muro di difesa che permetteva a stento l’apertura di un solo battente della porta. Ogni finestra poi era stata chiusa per metà da un muro con feritoia e per l’altra metà da robusta rete metallica. Alla prima intimazione di resa fatta dai partigiani ai carabinieri partirono alcuni colpi sia dall’una che dall’altra parte per cui rimasero colpiti un partigiano e un carabiniere. I due feriti, a seguito di complicazioni, trovarono la morte. I partigiani dovendo soccorrere il loro ferito desistettero per quella sera dall’assedio. Inseguito a quest’attentato, venne mandato da Parma, di rinforzo alla Caserma dei Carabinieri un presidio di circa 10 militi fascisti al comando di un sergente. Ad Alpe era stato costruito coll’inizio della guerra, sul m. Orocco, un osservatorio antiaereo, il quale era collegato con Sestri Levante a mezzo di telefono.
PRIME SCORRIBANDE
Con la primavera il gruppo « Centocroci» Beretta si sposta a Setterone in Comune di Bedonia e forte di 70 uomini comandati da « Richetto» decide l’attacco alla casermetta di Alpe, presidiata dai fascisti, per il giorno giovedì 23 marzo ’44. Il piano predisposto prevedeva un attacco diretto alla caserma che aveva funzioni di osservatorio antiaereo. All’attacco erano impegnati 15 uomini guidati dello stesso comandante mentre gli altri partigiani avevano funzioni di copertura per impedire arrivi di rinforzi dal comando di Sestri Levante, a cui la caserma era collegata per telefono e via radio.
Quel giovedì ad Alpe era gran festa per la celebrazione della chiusura delle 40 ore e gli abitanti gremivano la chiesa per la Messa-grande. Quando si sparse la voce dell’arrivo dei partigiani, l’officiante fermò il rito e dopo un attimo di perplessità! invitò tutti i fedeli a riunirsi in preghiera e recitare il s. rosario. La casermetta dei militi era situata quasi al centro del paese e non si differenziava nelle strutture, dalle altre case. Nel circondarla Richetto si avvide che la porta era aperta e con decisione entrò seguito dal Tenente Mario e dai due partigiani Elio e Leone. Segue un profondo silenzio di attesa e d’incertezze poi, con un sospiro, si vede il comandante del presidio, semplice caporalmaggiore, arrendersi uscendo con le mani alzate, Leone viene lasciato a guardia del prigioniero, mentre Richetto e gli altri salgono al piano superiore per prelevare i militi. .
La porta è sprangata dall’interno, all’intimazione di resa nessuno risponde, allora Elio, spara una raffica di « Sten » contro la serratura. Al rumore degli spari il prigioniero di sotto in cucina, impaurito, cerca di dare una spinta alla guardia e fuggire, ma Leone è pronto e lo stende con un colpo di moschetto. Dopo poco Richetto scende con i sei uomini del presidio fatti prigionieri. . Caricati i muli con tutte le armi e il materiale vario reperito nella caserma, per interessamento anche del parroco, vengono lasciati liberi i sei militi e la colonna dei partigiani parte per rientrare a Cento Croci. Venerdì 24, come previsto, arrivano i rinforzi fascisti da Chiavari e per prima cosa prelevano Don Cardinali Giuseppe il parroco, per fucilarlo sentenziando: «Meglio fucilare un prete che sterminare la popolazione ». Successivamente però ritornarono a più miti consigli; prelevano quattro uomini robusti per trasportare il loro morto e una decina di donne come ostaggio per mettere al riparo la colonna da eventuali nuovi attacchi dei « ribelli». Di passaggio a S. Maria si fermarono e mostrarono il morto ai militi fascisti fra continue sparatorie e minacce alla popolazione civile.
CON I TRENTA DELL’ISTRIANO SUL M. NERO ALLA «TANA DELLE VOLPI» Aprile 1944
Tre baite all’uso carbonaio, poste su una radura in falsopiano e fatte di tronchi di faggio, ai margini di una foresta di pino-mugo sempre verde, con un’aria fresca, umida e olezzante di resinose e mentastri, a quota m. 1.400, questo era il nuovo rifugio del distaccamento dell’lstriano, battezzato da Carlo Squeri «Venor », molto eufemisticamente «Tana delle Volpi ». L’avevamo costruita in Aprile, con l’ultima neve ancora alta, grazie all’abilità e indispensabile aiuto di alcuni carbonai veneti « Brusamolin » veri maestri di carpenteria, ugualmente baraccati appena più sotto sul sentiero-mulattiera che saliva da Selvola verso il m. Zoallo.
Pierino Moglia « Pedro» di Cese vice-comandante, aveva procurato la carta catramata per il tetto, le stufe e la paglia per il letto. Si dormiva su due ripiani a castello, ottenuti con piccoli tronchi su cui era stato steso un letto di paglia, vecchie stufe montanare in ghisa funzionanti a legna erano tenute accese in continuità, durante la notte provvedevano i patrioti in turno di guardia. Fuori appese ad un albero, facevano mostra di sé, le mezzene di mucca macellata sul posto. Chi arrivava da lontano, di pattuglia o di ritorno dal prelievo-vettovagliamento con zaino ripieno di: sale, tabacco, grasso, conserva e pane, non trovava di meglio per calmare la fame, di una genuina bistecca fatta sulla brace con qualche tozzo di pane raffermo, un pizzico di sale e pura acqua di fonte in abbondanza. I locali più pratici, ogni tanto, disponevano di qualche borraccia di buon sidro di mele prodotto a Selvola o Volpara.
Da lassù, in quell’ambiente primitivo ma tanto salubre, si viveva fuori dal mondo, sempre all’erta, dominando a raggera su tre vallate: Val Ceno che ci lasciava una certa tranquillità per i continui collegamenti con Drusco, Selvola e Volpara; Valnure che pattugliavamo in continuità di notte fino a Pertuso, Rompeggio e Selva di Gambero, mentre veniva trascurata di più la Val d’Aveto, confidando molto sulla distanza e sulle asperità naturali che ci dividevano da eventuali puntate fasciste. Non per sogni di gloria, ma. . . dar maggior lustro a quel gruppo di ardimentosi vuol dire fare storia e ricordare un gruppo che nel Piacentino e nel Parmense diede origine a numerose brigate partigiane; ugualmente si forgiarono a quella scuola molti eroici combattenti e uomini politici che calcarono la scena amministrativa del dopo guerra.
Ricorderò come fulgido esempio, Guerci, Ferdinando « Caio » che ci aveva raggiunto a Casalporino inviato dal Comitato di Parma. Fuggì da Verona alla vigilia della partenza per la Germania con un gruppo di amici alpini parmigiani; trascinatore e dotato di un carisma naturale, lui caporale, era stato subito riconosciuto come capo e al rifugio « Tane delle Volpi» aveva formato la sua banda detta dei « gorillini ». Per essere ammessi, bisognava saltare da un «mugo» all’altro almeno tre volte di seguito senza toccare terra, emettendo alla fine il classico urlo gutturale e battendosi il petto.
L’unico suo cruccio, fu quando una sera scendendo a « morosa » verso Rompeggio riuscì a disarmare un forestale suo rivale in amore, mentre nottetempo lo stava accompagnando su in distaccamento, riceveva uno spintone verso la ripida scarpata e il forestale tornava «uccel di bosco ». Figlio del popolo d’oltretorrente, vero monello, erede delle barricate, fu il compagno di molte battaglie, sprezzante del pericolo altruista con i compagni, la sua scomparsa lasciò un gran vuoto nelle file partigiane. La ricorderemo, pubblicando la motivazione della medaglia d’oro al valor militare concessa alla memoria.
ELENCO PARTIGIANI DISTACCAMENTO
ISTRIANO – Aprile-Maggio 1944
TANA DELLE VOLPI – M. NERO
POLDRUGO ERNESTO -« Istriano» sottufficiale di marina di Pola,
P.C. comandante;
.
SQUERI CARLO«Venor» universitario di legge di Bedonia – Commissario; poi avvocato e Deputato al Parlamento D.C., Sindaco di S. Donato Milanese;
BALDASSI VINCENZO. «Bragadin» studente liceale di Parma, Commissario, poi Sindaco di Parma e Deputato al Parlamento P .C.;
GUERCI FERDINANDO «Caio» operaio di Parma, V. Comandante Brigata, caduto a Farini Valnure, medaglia d’oro al V.M.;
MOGLIA PIETRO – «Pedro» commerciante legna e carbone di Cese, Bedonia, Vice comandante Brigata;
SIGNORINI GIANNI ANTONIO Fanfulla» studente universitario di Pieve di Campi! Albareto, poi Vice Comandante I Brigata Beretta;
DEL NINNO RAFFAELE – «Ralf» studente liceale di Parma, Vice Comandante Brigata, poi laureato in medicina;
MUSA FERDINANDO – «Spartaco» studente tecnica di Casalporino di Bedonia, Vice Intendente Brigata poi ragioniere;
FERRARI FERRUCCIO -« Ciccio » studente liceale di Parma, Intendente Btg., Sindaco D.C. di Tornolo;
DERLINDATI ATTILIO – «Mongolo» Universitario in Economia di Ozzano Taro, caduto.
CREDALI PAOLO – «Ivan» studente liceale di Parma, invalido, giornalista;
BERTELLI DOMINGO -« Bandolero» studente liceale di Bedonia; «Spezia» meccanico dell’arsenale;
AMOROSO SANTE «Klim» studente liceale di Parma, figlio di generale decorato di medaglia d’oro al V.M. in Etiopia;
GHILLANI OTELLO – «Pablo» operaio di Parma, caduto medaglia d’argento V.M.;
SALVI MARIO – «Tancredi» studente di Anzola, poi maresciallo P.S. Milano;
MARIANI FRANCO Scorpione» studente di La Spezia, ragioniere. –
BERTI DANILO «Danilo» studente di Anzola.
CAPPELLAZZI CARLO «Ten. Monti» barbiere, perseguitato politico di Parma;
MERUSI ETTORE «Zio» idraulico di Via XX Marzo a Parma;
BIANCHINI DANILO – «Firenze» studente di Firenze, poi commerciante Chiavari;
BECCARELLI DANILO – «Athos» fratello di «Rata» Chiesola Bedonia;
ELMARE LINO – «Aramis» forestale di Roncole Bedonia;
SMANI OTTO – «Villa» carbonaio veneto;
PESSINI TRANQUILLO – «Camillo Testarossa» contadino di Tarsogno;
BOSELLI ALDO – «Aldo» contadino di Volpara Bedonia;
MONTEVERDI DOMENICO – «Dencin» mulattiere di Remezzano;
ROSSI GIUSEPPE «Teston» studente di Isola di Compiano;
CORTELAZZO GIULIO – mulattiere di Selvola, staffetta e addetto ai collegamenti. .
SABOTATORI AGGREGATI A VOLPARA
SIMON ATTILIO «Gobbo» friulano paracadutista della « Nembo» missione Cap. Bernini a Spora;
GRIETTI – «Cellini» piemontese di Pinerolo della « Nembo» missione Cap. Bernini;
LAGORIO SERAFINO – «Carabiniere» di Giaiette (Borzonasca).
PRESA DI FERRIERE .
20 Maggio 1944
Dopo uno sbandamento comprensibile conseguente allo scontro di Monte-Vaccà (passato dalla cronaca alla storia come la battaglia di Pasqua del ’44) alcuni gruppi di patrioti si staccarono dal M. Penna e autonomamente si trasferirono in altre zone operative. La parola d’ordine, in quel tempo, era di abbandonare i paesi con trasferimenti in periferia, lontano dalle strade di accesso, cercando accantonamenti possibilmente isolati, senza coinvolgere la popolazione locale che viveva sotto l’incubo delle spie fasciste e pagava l’omertà e la solidarietà con i « ribelli» subendo continue violenze e intimidazioni di ogni genere.
La dimostrazione che sotto la cenere e una diffusa ma apparente quiete generale, fosse ancora vivo il fuoco ardente della libertà, fu data dalla popolazione di Bedonia in occasione dei funerali dei patrioti Ruggeri Pietro e John Harrison del gruppo « Penna », con una partecipazione plebiscitaria di popolo che ricoprì di fiori le due tombe. Il gruppo dell’Istriano, fedele agli ordini impartiti, si trasferiva con una trentina di ribelli da Volpara alla foresta del Monte Nero, accasermando il distaccamento in due baracche da carbonai, con funzioni da dormitori, oltre ad una baita più piccola attrezzata a cucina e magazzino. Da questa località impervia, ma dominante su tre vallate: VaI Ceno, VaI Nure e VaI d’Aveto; l’Istriano darà il via alla ripresa della guerriglia. Il martedì 9 di Maggio, giorno di mercato, vestito in borghese e accompagnato da Moglia Pierino (Pedro) e da una staffetta di Gambero, scende a Ferriere in Val Nure mescolandosi ai contadini e mercanti convenuti per la fiera, studia un piano di attacco alla caserma dei C.C. e dei militi G.N.R. accantonati nei locali del Dopolavoro.
Al suo rientro in distaccamento, discutiamo assieme i dettagli fino a tarda notte. La data del piano di attacco viene fissata senza indugi per la domenica successiva 21 Maggio esattamente alle ore 10,15 quando il maresciallo comandante la caserma dei C.C. si sarebbe recato a messa grande, accompagnato dalla famiglia. Così fu, partimmo dal rifugio del M. Nero. che albeggiava scendendo in fila indiana verso Pertuso, di qui divisi in tre squadre con compiti diversi confluimmo a Ferriere di nascosto entrando in paese da più parti. Il gruppo che doveva assaltare la caserma dei C.C. aveva inviato in avanscoperta Camillo . . . (Testarossa) armato di una pistola a tamburo con munizioni a spillo che non sparavano, oltre a una «marassa » per tagliare i fili del telefono, su un palo di fianco alla caserma.
La mossa era stata ideata da Pedro, in quanto il « testarossa » era stato prelevato e processato per vari reati contro il patrimonio, atti di brigantaggio commessi sotto il nome dei partigiani e pertanto condannato dal Comando alla fucilazione. Alcuni conoscenti e partigiani locali, si erano lasciati impietosire dai piagnistei e dai continui giuramenti del Camillo ottenendo il rinvio « sine die » dell’esecuzione. Se a Ferriere gli fosse andata bene, passando indenne sotto lo sguardo nemico, avrebbe salvato la pelle, rendendo un grosso servizio ai patrioti. Tutto andò per il meglio anche perché l’unico carabiniere rimasto in caserma, come piantone, era di Compiano e alla intimazione della resa apriva la porta chiedendo come unica… contropartita, la libertà di mettersi in borghese e rientrare con noi al paese natìo.
In maniera del tutto diversa si comportarono i militi della G.N.R., i quali forti di 18 uomini con in dotazione un fucile mitragliatore e molto bene trincerati dietro sacchetti di sabbia alle finestre, resistettero ad oltranza, infischiandosene della nostra sparatoria fatta con gli «sten» da oltre il ponte, dietro il parapetto del fiume. Era mezzogiorno quando l’Istriano constatato che il nostro munizionamento, dopo due ore di battaglia stava per finire, decise l’ultima mossa che doveva preludere allo sganciamento. Mi chiamò come « sabotatore » ordinandomi di preparare una carica di dinamite. Quindi girando all’interno del paese assieme a due patrioti di copertura ci portammo sotto la caserma, ed a un segnale convenuto tutti i partigiani aprirono un fuoco incrociato contro le finestre mentre io collocavo la carica composta da tre stecche di dinamite al centro del portone d’ingresso.
Alcune bombe a mano « sipe» lanciate dall’Istriano in appoggio, scardinarono il portone e fecero volare le finestre, costringendo il comandante ferito a chiedere la resa con la chiamata urgente di un prete. L’Istriano solitamente molto duro, in quel frangente fu ben felice di aderire, concedendo salva la vita a tutti i militi e accontentandosi delle armi e scorte. Per trasportare tutto il materiale conquistato nelle due caserme e il vettovagliamento prelevato al Consorzio Agrario locale, furono necessari ben 24 muli. In serata risalivamo la strada di Rompeggio, Pertuso su verso lo Zovallo e il rifugio del M. Nero stanchissimi, ma con il cuore pieno di tanta felicità e rinnovata fiducia nella lotta per la libertà.
ALTRE TESTIMONIANZE E CONFERME
Sulla presa di Ferriere, Giacomo Vietti nel suo volume « L’Alta VaI Taro nella Resistenza» scrive: Dopo una breve pausa che consente alle formazioni partigiane di riorganizzarsi, la guerriglia riprende ed è l’Istriano che partendo dal suo rifugio di Volpara, il 20 maggio attacca le caserme della milizia e dei carabinieri di Ferriere costringendole alla resa dopo varie ore di fuoco.
Ingente il bottino di guerra; ventiquattro muli sono impiegati a trasportarlo al suo rifugio sul monte Nero. E’ questo il primo episodio di una lunga battaglia, che porterà gli uomini dell’Istriano a liberare tutta la Val Nure fino a Bettola. Di tutte queste vicende che hanno interessato l’alta ValTaro, per tutta la settimana la « Gazzetta di Parma» dà una breve e di storta versione, certamente non ricordandosi dell’impegno preso dal Federale di Parma Pino Romualdi e delle sue famose parole: « Sarebbe veramente imbecille che ci facessimo fregare dai nostri ribelli ».
RASTRELLAMENTO MAGGIO 1944

Lunedì 22 maggio, completato l’inventario del materiale conquistato a Ferriere e occultato nei vari depositi, l’lstriano mi concede una settimana di licenza premio. Parto per Volpara, dove avevo un punto di appoggio presso i Botti detti « Pesse » bisavoli materni. Cambiato di biancheria riparto per Tornolo con l’intenzione di arrivare in famiglia con il buio, quando nessuno mi avrebbe più potuto riconoscere. Arrivato al passo del Segalino incrocio varie persone che fuggivano da Bedonia, seguite da Bill e da tutto il suo gruppo che ci raccontano di una colonna interminabile di camion tedeschi risalenti da Borgotaro preannuncianti un grosso rastrellamento. Nella ormai chiara notte, si sente il rumore continuo dei motori sulla carrozzabile ed è visibile la fila dei lumicini che salita la Costa scendono verso Piane di Carniglia mentre in lontananza continuano ancora a salire dalla Bertorella verso Bedonia. Li per li resto indeciso sul da farsi, poi incontro un vecchio amico Brunetto Ferrari di Parma e assieme ci accodiamo al gruppo di « Firpo » con distaccamento sopra Montarsiccio che avendo appena smontato la cucina e caricate tutte le salmerie su tre muli, seguiva la colonna su per il crinale verso l’Orocco.
All’alba del 23 maggio ci ritroviamo tutti nello spiazzo della casermetta – forestale al M. Penna; sparano da tutti i lati, un velivolo da ricognizione « Cicogna» ci spia dall’alto, si vede nitidamente il pilota e l’osservatore dietro con un binocolo. Vorremmo sparargli qualche raffica di mitragliatore, ma l’ordine è di non farci localizzare e nasconderci il più possibile. Alle ore 9 constatato che forti colonne nemiche convergevano a raggera da tutte le strade verso il Penna, i comandanti riuniti decidono lo sganciamento e consigliano di dividersi in piccoli gruppi per meglio passare fra le maglie del rastrellamento. Io mi ritrovo solo con Monteverdi (Nencin) di Romezzano e a Gandi Gino (Bambin) di Tornolo, mulattieri che ancora si trascinavano dietro 4 muli. Prima mossa saliamo alla Nave, faccio nascondere i basti in un anfratto sotto un roccione e liberiamo i muli affamati al pascolo, poi saliamo sul contrafforte lato est, passando di fianco alla grotta del ghiaccio. Qui «Nencin» vedendo tedeschi e fascisti per ogni dove, decide di andare giù verso casa, mentre io e « Bambin » scendiamo verso i prati di Maria Luigia, dove alcuni carbonai veneti, di sua conoscenza, stavano facendo il carbone. Questi come ci vedono arrivare, fanno cenno di affrettarci perché ci vorrebbero nascondere in alcune carbonaie che stavano costruendo; «Bambin» accetta, io preso da una paura maledetta, mi sento come un attacco di « claustrofobia » e fuggo nuovamente verso la macchia.
Verso le ore 11, arriva una colonna di tedeschi che sale subito alle baracche dei carbonai catturando immediatamente « Bambin » che in panni borghesi e disarmato si fa passare per carbonaio. Egli verrà poi tradotto a Parma in S. Francesco e, quindi, deportato in Germania da dove avrà la fortuna di rientrare a Tornolo finita la guerra. . Mentre nascosto fra due roccioni osservavo la scena con il cuore in gola, vidi l’ufficiale comandante che munito di cannocchiale saliva su un mucchio di ramagli a sotto sentiero. Con il suo peso ne provocava un rialzamento al basso verso valle, scoprendo un partigiano nascosto. Solo alcune settimane dopo venni a sapere che si trattava dell’amico « Bisco ». Salvi Mario di Anzola. Molto buffo il particolare che liberatosi della divisa di panno inglese per la paura di essere catturato, aveva tenuto le mutande di colore rosso, fatte nei paracaduti, le quali erano ben visibili in lontananza per chi come me si trovava al di sotto ma coperto dalla ramaglia alla vista dei tedeschi che vi salivano sopra come pulpito di guardia.
Dopo aver vagato ancora verso Setterone e Codorso alla sera del 23 Maggio assisto alla preparazione del campo dei fascisti nel pianoro dirimpetto al paese. Ritorna la « cicogna» e lancia un pacco con fettuccia colorata ai rastrellatori. Visto che i nazifascisti si apprestavano a raggrupparsi per passare la notte, mi unisco a tre partigiani del gruppo « Berretta » e assieme scendiamo verso Pontestrambo, intercettati da una pattuglia sulla strada, risaliamo verso Alpe, passiamo a Bruschi di Sopra e qui di fronte alla offerta di un minestrone fumante sembravano finire tutti i nostri guai. A notte fonda attraversiamo il Taro, risaliamo per il rio di « Catto » e in una baracca-cascina che conoscevo, sopra le rocche di Fopiano, acceso un buon fuoco ristoratore per asciugarci passiamo la: notte. Al mattino del 24 ci risvegliamo ormai rincuorati e fuori dalla cerchia del rastrellamento, restiamo però inebetiti vendendo di fronte esplodere la furia dei fascisti che incendiano Bruschi di Sotto da cui si alzano colonne di fumo nero che salgono anche da Alpe e Setterone. Il giorno dopo avrà fine il più grosso rastrellamento della Valtaro, forse meno cruento come perdite umane di quello del Luglio ’44, ma certamente con maggior impiego di armi, uomini e mezzi anche blindati e con l’appoggio della ricognizione aerea.
(Anche Don Celso Mori così ci tramanda gli avvenimenti)
I RASTRELLAMENTI NAZI FASCISTI
I tanto temuti rastrellamenti barbari ed inumani, operati dalle truppe nazi-fasciste, si scatenarono per ben quattro volte, come furioso temporale, sopra questa nostra alta Valle del Taro. Anche la nostra parrocchia quindi fu invasa dalle truppe tedesche e fasciste come un tempo le orde barbariche di Attila e di Alarico invasero la nostra bella Italia, uccidendo e deportando uomini, maltrattando ed ingiuriando donne, saccheggiando e bruciando case e cascine, asportandone masserizie e bestiame. La descrizione che il Manzoni fa nel suo romanzo «I promessi sposi» del passaggio dei lanzichenecchi attraverso il territorio milanese, la si può benissimo adattare, senza nulla togliere, al passaggio dei tedeschi, attraverso il territorio di questa nostra parrocchia. La desolazione e il terrore regnava nell’animo di questi tranquilli abitanti, specialmente negli uomini, che già tanto temevano la ferocia degli aguzzini nazi-fascisti.
S. Maria era trasformata in un vero quartier generale. A questo rastrellamento vi parteciparono circa otto mila uomini, ben armati, equipaggiati ed appoggiati dall’aviazione. La zona di operazione era il monte Penna, creduto la roccaforte dei partigiani. Tutte le direttrici di accesso al sistema montagnoso del Penna, erano battute da truppe tedesche ed italiane, provenienti dal Val Taro, Vai Ceno e Val d’Aveto. I paesi situati attorno al Penna furono setacciati e la zona venne rastrellata passo a passo. Tutti i cespugli, le grotte furono bersaglio dei mitra e moschetti, oltre bombe a mano e perfino la vetta fu centrata da un colpo di cannone. Tutti gli uomini trovati fuori casa e i giovani che avevano obblighi di leva, vennero arrestati e condotti nella segheria, dove rimasero per circa una settimana. Vennero più volte interrogati dalle S.S. le quali dopo aver assunto informazioni dalla locale Caserma dei Carabinieri, lasciarono liberi quelli che risultarono non appartenenti a bande armate partigiane o non aventi obblighi militari, mentre tutti gli altri furono deportati in Germania.
Il risultato di questa operazione in grande stile fu completamente negativo; i partigiani riuscirono in tempo a spostarsi in altre zone e quelli rimasti si nascosero; nessun partigiano quindi venne arrestato o ucciso sul M. Penna. La Madonna del Penna con la sua grandiosa statua vegliava, quale madre amorosa, sopra i suoi figli. Durante questo primo rastrellamento vi fu, è vero, un morto, ma fu un giovane fascista, allievo ufficiale della scuola di Lucca, ucciso per errore, sopra la frazione Squeri, da un reparto di altri soldati repubblichini. A Bedonia invece vi fu un vero scontro tra partigiani e tedeschi e vi rimasero alcuni tedeschi feriti e un partigiano morto. I giovani delle classi di leva del 1922-1925 che si trovavano a casa con un foglio di esonero, perché adibiti a lavori forestali, furono chiamati a ripresentarsi al comando tedesco, pena rappresaglia contro le famiglie. Il federale fascista Spiotta fece annullare gli esoneri e arrestare come antifascista il Sig. Primo Guglielminetti, titolare dell’azienda boschiva, lo fece torturare dalle S.S. e quindi deportato in Germania nel famoso campo di Mathausen dove venne più tardi eliminato. I giovani rastrellati, quando compresero che le autorità non ritenevano più valido il regolare esonero in loro possesso, si diedero da fare e molti scapparono da Parma, altri da Milano, per vie e con sistemi; diversi, si resero uccel di bosco, rientrando tutti a S. Maria del Taro.
COME IL RASTRELLAMENTO DI MAGGIO IN ALTA VAL CENO VIENE RIEVOCATO DA MUSA NANDO « SPARTACO»
Nel Distaccamento di « Messina », dislocato a Costa D’Azzetta, da diversi giorni fervevano i preparativi per la distruzione del ponte ferroviario di Ostia Parmense, detto « Il parabolico ». Diversi elementi della squadra di specialisti sabotatori si erano ripartiti i compiti. Chi addestrava un gruppetto ad azioni di commando, chi preparava le cariche di tritolo per tranciare il ponte, l’intendenza accantonava i viveri necessari per il viaggio di andata e ritorno. Il comando e il capitano dei sabotatori studiavano le modalità dell’ attacco: eliminazione silenziosa delle sentinelle tedesche con armi bianche minamento del ponte con cariche di tritolo da fissarsi alle parti metalliche a mezzo di calamite, collegamento delle varie cariche con miccia detonante in modo che un unico detonatore provocasse la contemporanea deflagrazione di tutte le cariche e la caduta del ponte nel greto del Taro. In tal modo si sarebbe interrotta una arteria di rifornimento per i tedeschi, di importanza primaria. Gli alleati avevano tentato ripetutamente la ” distruzione del ponte con attacchi aerei, risultati infruttuosi soprattutto a causa della particolare conformazione della zona.
Quando ormai tutti i particolari erano stati definiti e i preparativi ultimati, verso le nove di sera arriva una staffetta da Anzola, che ci informa concitatamente che un forte contingente di tedeschi autotrasportati era giunto ad Anzola. Dal numero degli automezzi segnalati viene fatto un calcolo approssimativo della forza: troppa per una puntata dimostrativa. Il distaccamento si riunisce e discute animatamente: parecchi sono del parere che i tedeschi non si sarebbero mossi fino all’alba, sia per la mancanza di conoscenza della zona che per il buio fitto e la pioggia che cadeva. Alla fine « Messina» decide di sgomberare i locali occupati dal distaccamento, nascondere tutto l’esplosivo preparato per il ponte e di eliminare ogni traccia di presenza partigiana, sia per ostacolare le ricerche dei tedeschi che per evitare rappresaglie verso le famiglie che davano ospitalità al distaccamento. Fra i mugugni per le prospettive di una notte fredda e piovosa da passare all’addiaccio, il distaccamento si arrampica su verso la vecchia caserma del Penna dove trascorre la notte. All’alba si dirige verso la caserma della forestale, all’Incisa: all’interno viene acceso il fuoco per asciugarsi un po’ e viene preparato qualcosa per mangiare. Dopo poco, per la stanchezza ed il tepore del fuoco, molti dormono come marmotte. Tuttavia la caserma, se dava riparo dal maltempo, non dava certo, sicurezza: sarebbe stato il primo posto dove i tedeschi ci avrebbero cercato e trovato, aiutati anche dal fumo che saliva dal camino. Viene perciò impartito l’ordine di sgomberare e spegnere il fuoco. Ci addentriamo nella pineta come nell’unico posto dove il fogliame degli abeti potevano nascondersi ad una eventuale ricognizione aerea. Dopo circa un’ora, passa una « Cicogna» che gira lentamente intorno alla vetta del Penna: ci eravamo sganciati in tempo!
Pur dubitando che i tedeschi si sarebbero spinti fin lassù, vengono mandate fuori diverse pattuglie per segnalare i movimenti del nemico. Intanto il distaccamento si attesta sullo sperone del Chiodo, da dove si poteva controllare visivamente un’ampia zona nei due versanti. Parto di pattuglia, insieme ad un siciliano. Ci dirigiamo verso la costa di Romezzano, guardiamo attentamente col binocolo a valle ma non notiamo nulla di insolito e non sentiamo spari. Scendiamo per la Sella, lungo la mulattiera che porta a Cese senza notare niente di nuovo e arriviamo poco distante da Cese, nei pressi della « Macchia Grande ». Li troviamo i figli di Gardini che pascolavano il bestiame e chiediamo se avevano visto dei tedeschi. « Stanno arrivando: sono dentro nella macchia» ci rispondono. Ci portiamo di corsa verso un’altura soprastante e ci nascondiamo. Dopo poco vediamo spuntare due pattuglie, una per versante e, dietro, il grosso: forse un centinaio di uomini. Allora, col fiato che ci consentivano i vent’anni, corriamo verso il crinale per avvisare il distaccamento. Quando siamo per giungere al crinale, notiamo nel fango le orme caratteristiche degli stivaletti tedeschi col ferro di cavallo nei tacchi: provengono da un sentiero che sale da Romezzano e ci precedono verso il passo di Villa Neri. Abbandoniamo la mulattiera e avanziamo verso il crinale al coperto nel bosco. Sul crinale notiamo quattro tedeschi sudati (si vedeva dalle camicie bagnate), seduti su un tronco, che interrogavano un carbonaio. Ci erano di spalle e sarebbero stati un bersaglio facile e a portata degli Sten. Noi però ci preoccupavamo di non farci individuare per poter raggiungere il distaccamento ed evitare una sorpresa. Strisciamo cautamente sul terreno per riportarci dentro nel bosco. All’improvviso sentiamo urla in tedesco e contemporaneamente un rabbioso crepitio di machine-pistole. Mentre con dei salti da impala ci infiliamo nel bosco, ci scoppia vicinissima una bomba a mano: i tedeschi ci avevano preceduti sulla strada verso il Chiodo! Tutt’intorno si scatena una fitta sparatoria. Ormai quelli del Chiodo avevano capito bene la situazione: le informazioni che potevamo portare noi, a parte l’impossibilità di farlo, erano superate.
Mentre scendiamo per una macchia ripida e folta per nasconderei in un canalone pieno di roccioni, sentiamo poco sotto una forte esplosione. Abbiamo la netta sensazione di essere in trappola. Tentiamo una via di scampo a mezza costa e dopo qualche centinaio di metri scendiamo nel burrone. Mi accorgo allora che mi manca una bomba a mano dalla cintura, quasi certamente quella che, rotolando, era esplosa poco prima! Ma nemmeno nel crepaccio dove ci eravamo infilati riusciamo a trovare un attimo di quiete. Dopo qualche minuto i tedeschi cominciano a battere il canale coi mortai da 81, sparando da Romezzano. Alcuni colpi cadono vicinissimi. Pensiamo che ci abbiano individuati e che sparino a noi. Finalmente cessa il bombardamento. Dopo qualche ora sentiamo sparare verso Costa D’Azzetta e sentiamo delle grida. Sapremo dopo che i tedeschi avevano ucciso una ragazza e ferito un uomo che sorvegliavano il bestiame al pascolo. Verso mezzogiorno vediamo una colonna di fumo in alzarsi da Romezzano. Saliamo su un’altura e vediamo che la casa di « Messina» era stata data alle fiamme. Ritorniamo nel crepaccio e attendiamo. Ogni tanto si sentivano sporadiche raffiche qua e là.
All’improvviso sentiamo un cane che abbaia e scende nella nostra direzione. Ci viene in mente che in certi casi i tedeschi usavano cani poliziotto per stanare i partigiani. Il cane scende sempre più verso di noi. Allora, convinti che il cane seguisse noi, ci prepariamo a vendere cara la pelle. Nascondo in fretta i pochi soldi che avevo addosso e che erano la cassa del distaccamento insieme al taccuino della contabilità dove erano segnati nomi di fornitori e di creditori. Poi con lo sten in pugno attendiamo l’arrivo dei tedeschi. All’improvviso vediamo passare in un piccolo sentiero una lepre e poco dopo il cane che la seguiva braccando. . . Mi limito alla cronaca dei fatti e tralascio la descrizione dei sentimenti. Verso sera sentiamo parlottare in tedesco e vediamo una decina di crucchi fermarsi su un costone, a qualche centinaio di metri da noi. Vedo col binocolo che stanno piazzando una mitragliera e scrutano in giro col cannocchiale. Poi accendono il fuoco per scaldarsi il rancio. Scende la notte ma i crucchi non si muovono. La fame ci tormenta più del freddo. Ogni. tanto lanciano dei razzi di segnalazione e dei bengala. Giudichiamo sia il caso di non muoversi e passiamo la notte sul posto. I faggi e le altre latifoglie non avevano ancora il fogliame: era quindi molto difficile muoversi al coperto e farsi scoprire significava lasciarci la pelle. Passiamo sul posto anche il giorno successivo, ossessionati dalla fame e dal pensiero delle famiglie e degli amici forzatamente rimasti nei paesi in mano ai tedeschi. Rischiare di avvicinarci ai paesi per cercare qualcosa da mangiare poteva significare cadere fra le grinfie dei tedeschi. Scende la notte. La fame e l’assoluta mancanza di notizie ci tormentano. Alla fine decidiamo fosse meglio morire di piombo piuttosto che di fame. Aggiriamo la postazione nottetempo, approfittando del cielo sereno che consentiva una modesta visibilità e ci dirigiamo verso Volpara. Ci dirigiamo verso la casa dello « Storto» che si trova isolata dal paese. Il paese era immerso in un silenzio di tomba. Con grande cautela ci avviciniamo alla casa strisciando in mezzo a un campo di grano, ci accertiamo che non vi siano tedeschi e poi chiamiamo il padrone di casa che scende e ci fa entrare. Dopo aver sentito le notizie di cui era al corrente chiediamo qualcosa per sfamarsi. Non potrò mai scordare le due pagnotte casalinghe e la frittata, sparite in pochi minuti. . .
Ci ritiriamo a fare una dormita in un fienile isolato, mentre il padrone di casa faceva da sentinella. Non passa molto tempo che ci sveglia: i tedeschi stanno salendo da Anzola, dicono che sono anche a S. Stefano e a S. Maria del Taro. Significa che hanno circondato da tre lati il punto che ritenevamo più sicuro, il Penna. A Travaglini dicono che hanno ucciso un giovane partigiano che era sceso in paese a cercare da mangiare. Un altro che saliva l’Orocco a Cavallo è stato centrato da una mitragliera. Del nostro gruppo sul Penna nessuna notizia. Il terzo giorno un amico viene ad informarci nella caverna della « Piana dei tassi» che i tedeschi sono scesi ad Anzola e sono ripartiti senza prigionieri. Il Gruppo Penna era riuscito a sparpagliarsi ed era uscito indenne dal rastrellamento che, per le forze impegnate dal nemico, si può considerare il più temibile dei parecchi subiti dai partigiani nell’Alta Val Ceno.
Musa Nando « Spartaco>>

Ufficiali inglesi sbandati anche a Chiesiola
VIII .
Nel 1944 per circa due mesi si è trovato nel territorio affidato alla brigata «Monte Penna» un ufficiale inglese, che era sfuggito ad un inseguimento di tedeschi. I partigiani lo avevano affidato alla famiglia Moglia Andrea che, dietro raccomandazione della signora Mangiante, gli aveva dato ricetto in un nascondiglio in casa loro. Spesso veniva in canonica per ascoltare la trasmissione della radio in lingua inglese, e così tenersi al corrente di come le cose andavano nel suo paese. Venne poi, su sua richiesta, trasferito in altra località. Non ho mai saputo come si chiamasse, né dove fosse andato a finire. So soltanto che se ne andò senza neppure dire un grazie alla famiglia che l’aveva per tanto tempo e con proprio rischio ospitato.
Rastrellamento del 22 maggio 44
Nei giorni 22-25 maggio 1944 abbiamo avuto un rastrellamento compiuto da truppe tedesche guidate da fascisti. Alcuni di costoro erano vestiti come i tedeschi. Erano arrivati, già visti dagli osservatori partigiani fin dal giorno prima, ad Anzola con ben trentasette automezzi e munizioni. I partigiani, inferiori per numero, ebbero appena il tempo per ritirarsi, e la popolazione inerme, dovette subire questa invasione per ben quattro giorni. Ogni casa di Anzola, Chiesiola, Casalporino, Spora e Romezzano era la loro, dove entravano, rovistavano nei più remoti buchi, comandavano e si doveva ubbidire con sollecitudine.
Credo che l’unica casa che non ha subito angherie sia stata la mia canonica, e questo forse per il fatto che ivi era stato ospitato un tenente tedesco, ufficiale di stato maggiore, che comandava l’operazione, oltre che per la premura dimostrata verso questo ufficiale dalla signora Mangiante, che dalla Maria e dalla Giuseppina. Con questo ufficiale, nella mia canonica si erano fissati altri tre ufficiali tedeschi, e si servivano, in quei giorni, della cucina del sig. ingegnere come ritrovo per i loro raduni. Questi miei non graditi ospiti, di notte, si ritiravano in una casa vicina per riposarsi. L’ingegnere non si trovava a Chiesiola in quei giorni, ma, sotto mentite spoglie, si era portato nei pressi di Lavagna per poter sentire dal fratello Dottor Giacomo, cosa si pensasse di lui in riviera. Il secondo giorno mi accorsi che c’era qualcosa che non andava fra i miei ospiti tedeschi. Venni a sapere da un tenente della Milizia che la parrocchia di Romezzano stava per passare un brutto quarto d’ora.
Un gruppo di tedeschi e fascisti si era presentato al parroco di Romezzano chiedendo se conoscesse dei partigiani, e se poteva dire dove si trovassero. Il buon Don Rocco, dapprima si spaventò di quella visita e maggiormente si impressionò per le domande rivoltegli. Il suo atteggiamento venne interpretato come una sua connivenza coi partigiani, per cui gli vennero rivolte minacce a seguito delle sue risposte negative. In ultimo, nella speranza che lo lasciassero quieto, rivelò che non solo aveva visto i partigiani, ma uno dei capi era addirittura suo parrocchiano, come del resto era vero, e si trattava di Monteverdi Albino (Mario), e ne indicò la casa a pochi metri dalla canonica. Non c’è voluto altro per fare passare tutto il paese come un covo di ribelli, e passare subito alla determinazione di compiere un’epurazione fra la popolazione e la relativa distruzione del paese.
Anche nella parrocchia di Spora, dove si trovava un gruppo di militi, che dipendevano dall’ufficiale che si trovava a Romezzano, vennero trovate in una cascina alcune armi, ivi abbandonate inavvertitamente dai partigiani fuggiti. È stato sufficiente questo fatto perché al paese di Spora fosse decretata la fine già decisa a Romezzano. In un frangente di questa portata è stata determinante l’intervento del piccolo, ma energico Don Davide Mantegari, parroco di Spora. Egli si presentò all’ufficiale con un coraggio, di cui non lo conoscevo capace, e mise in pericolo la propria vita per salvare le due parrocchie. L’ufficiale fascista che si era accampato coi suoi militi a Romezzano, non aveva l’autorizzazione di compiere un’azione simile di rappresaglia senza aver prima ottenuto il benestare dell’ufficiale tedesco di stato maggiore che si trovava a Chiesiola, nella mia canonica; e questo benché l’ufficiale di Romezzano fosse un capitano (fascista), e quello di Chiesiola in vece un semplice tenente (tedesco).
Precisamente questo ultimo ufficiale mi mise al corrente della faccenda, chiedendomi consiglio. Aiutato dalla signora Ester, c’è voluta tutta la nostra opera di persuasione per fare comprendere che, se purtroppo era vero quanto il parroco di Romezzano aveva detto sul conto del partigiano Mario, la popolazione però della parrocchia non c’entrava per nulla, se non che qualche volta, erano costretti a rifocillare i ribelli, anche se non consenzienti. A questo punto giunse a Chiesiola a dare mano forte per la salvezza delle due parrocchie il parroco di Spora Don Davide Mantegari, accompagnato dal chierico Monteverdi Davide, di Romezzano.
Egli espose, con chiarezza, all’ufficiale di Stato Maggiore lo stato delle cose e le conseguenze, anche per loro, di un gesto come quello di cui si veniva a chiedere l’autorizzazione a procedere. Il permesso non venne dato. Poveri Italiani Fascisti, che in tutto dovevano dipendere da un semplice cenno di un ufficiale tedesco! A che cosa eravamo ridotti e quanto poco eravamo stimati, noi italiani, perfino in casa nostra, da questi nostri… alleati! Chi era sceso da Romezzano per ottenere l’autorizzazione di distruggere i due paesi, dovette ritornare a Romezzano col solo permesso di incendiare la casa di Mario senza permettere che venisse asportato alcunché, né masserizie, né mobili.
Il padre di Mario, ormai anziano, dovette assistere, immobile e impotente, alla distruzione di quanto possedeva. Non avendo ottenuto quanto desideravano i fascisti si sfogarono nei riguardi del povero don Rocco, che malmenarono in modo tale che, in seguito, dovette essere ricoverato in manicomio. Al termine di questo rastrellamento, che durò quattro giorni, al pomeriggio dell’ultimo giorno, gli ufficiali si erano riuniti, prima della partenza, vicino alla chiesa di Chiesiola. Ad un certo momento mi si presenta in canonica un tenente della Milizia, chiedendomi gentilmente se potevo mettere a disposizione del gruppo degli ufficiali una stanza, perché, prima di partire, dovevano stendere il rapporto del rastrellamento di quei giorni.
Non potendone fare a meno, misi a loro disposizione la mia cucinetta dove si trovava un tavolo, una panca e due sedie con un armadio. Ecco in che cosa consisteva il lussuoso arredamento del parroco di Chiesiola! Il tenente richiedente mi ringraziò ed invitò il gruppo degli ufficiali ad accomodarsi. Appena entrati in cucina e messi due militari alla porta interna ed esterna della stessa, mi trovai nel corridoio che dalla cucina portava sul piazzale della Chiesa. Solo allora mi accorsi della enormità che avevo commesso in tutti quei giorni ed in quale grave pericolo mi trovavo con i miei ospiti e l’intera brigata dei partigiani.
Sull’armadio, non nascosta, avevo messa la mia rivoltella carica. Nel cassetto del tavolo, di cui si servivano i miei non graditi ospiti, si trovava una somma che si aggirava sulle 200.000 lire (le famose 500 lire rosse), frutto di un lancio inglese, effettuato da poco tempo, e con questo denaro, l’elenco, però non aggiornato, di tutti i partigiani della brigata coi relativi indirizzi, nomi di battaglia e luogo di dislocamento. Per me quelli sono stati tre quarti d’ora d’inferno!!! Non pensavo tanto a me, ma soprattutto a coloro la cui vita dipendeva dalla disgraziata possibilità che qualcuno di quelli che occupavano la mia cucina aprisse il cassetto del mio tavolo e vi curiosasse dentro.
Ad un certo momento vidi aprirsi la porta della cucina ed uscire il tenente che avevo visto per primo, mi si avvicina e mi dice che il capitano (fascista) desiderava vedermi e ringraziarmi per l’ospitalità ricevuta. Per me quelle parole sono risuonate come un preavviso di un lungo interrogatorio ed una logica successiva condanna. Non so con che faccia entrai in cucina. Al mio apparire, il capitano mi si fece incontro con la mano tesa, mi strinse la mia e mi ringraziò. Che cosa disse non lo ricordo, perché in quel momento capivo… poco…
A questo punto il tenente, che mi aveva introdotto in cucina, mi si avvicinò e mi disse, sottovoce: Non vuoi offrire un bicchiere al capitano? Era un ordine o un invito? A questo punto pregai i presenti ad accettare un bicchiere di vino; mi recai in cantina, presi una bottiglia ed offrii da bere ai miei ospiti, sempre nel timore che questa fosse tutta una messa in scena per poi aprirmi in faccia il cassetto del tavolo. Quale sospiro trassi quando vidi, uno dopo l’altro, gli ufficiali fascisti e tedeschi uscire dalla cucina e dalla casa, e dare l’ordine di partenza. Mi fermai sulla soglia della porta di casa e non mi mossi finché non vidi l’ultimo militare passare il piccolo valico che gli toglieva la vista della mia chiesa e della canonica.
Ero imbambolato, quando il piccolo Eugenio mi si avvicinò e mi destò dal mio sogno per riportarmi alla realtà. Terminato questo rastrellamento, dopo qualche giorno rividi, nella mia canonica Scarpa, comandante, Mario, Bill, Istriano, Falco e l’ingegnere. Il fatto di Romezzano aveva eccitato gli animi. Chi minacciava rappresaglie nei riguardi del Parroco, chi faceva dei preti della vallata tutto un fascio! Su questo argomento non avevo nulla da temere personalmente, per cui potevo farmi forte nel portare, a difesa dei parroci del luogo, il contegno tenuto in questa circostanza dal caro ed intrepido don Davide Mentegari.
Calmare gli animi così scossi e il cercare di farli ragionare non è stata cosa da poco. In questo sono stato validamente aiutato dalla signora Ester in cui i partigiani riponevano grande fiducia. Mario (di Romezzano, che era stato il maggiormente colpito durante il rastrellamento) era profondamente irritato, ma soprattutto amareggiato per il fatto che causa del suo male fosse stato, purtroppo, il proprio parroco. A sua lode posso dire che il suo contegno, giustamente irritato, ma meno agitato rispetto a quello degli altri, mi aiutò a calmare in modo particolare qualcuno, in modo che il povero don Rocco non ebbe seri guai per la condotta tenuta nella visita dei fascisti.
Durante questo primo incontro dopo questo burrascoso rastrellamento, concluso a questo modo questo argomento, raccontai loro con sincerità e schiettezza la mia grave imprudenza commessa quando gli invasori si erano serviti del tavolo della mia cucina. In un primo tempo rimasero meravigliati della mia sincerità, e questo fece su loro più effetto del pericolo che essi stessi con me avevano corso. Li pregai di portare in luogo più sicuro, ed in casa di uno più cauto di me, il materiale che si trovava ancora nel cassetto del tavolo. Essi all’unanimità hanno insistito perché conservassi tutto io, in luogo più sicuro. Li ringraziai della loro fiducia, ma insistetti perché mi accontentassero, anche per il pericolo che, con noi tutti, avevano passato i miei ospiti di Lavagna.
Infine essi cedettero e portarono denaro e registri a Tomba.
STEFANO BERTOLOTTI – primo caduto Tornolese
Il fatidico lunedì 22 Maggio 1944 Stefano Bertolotti lascia la sua Breila (Frazione di Tarsogno) e seguendo amici partigiani sale a Pontestrambo per arruolarsi nel Corpo Volontari della Libertà Cento croci – Berretta con il Comandante Richetto. Nello stesso giorno alcuni partigiani di Gotra di Albareto che erano partiti per una breve licenza, rientrano trafelati dalla Costa Belvedere, chiedendo rinforzi per attaccare una camionetta corazzata tedesca giunta inaspettata e tutta sola nel garage di Carpani a Bedonia. Un camioncino carica una trentina di partigiani volontari e parte subito per Bedonia. Al bivio di Tornolo il gruppo si divide in due squadre: una al comando dello stesso Richetto scende verso Borio e corre a tagliare la ritirata sulla strada di Borgotaro, l’altra, in cui si era inserita la matricola Bertolotti, scende dal Belvedere verso Bedonia. Richetto risalendo la provinciale all’entrata dell’abitato si scontra con un tedesco che all’intimazione di resa, risponde sparando con una pistola « mauser » e viene fatto fuori.
I tedeschi che erano nell’autorimessa, sentendo la sparatoria, saltano sulla camionetta corazzata e salgono in direzione del Belvedere, velocissimi, verso la postazione dell’altro nostro gruppo. Sotto le raffiche del mitragliatore di Riccoboni « Ubaldo » la camionetta procede zigzagando per terminare capovolta nella cunetta. I due tedeschi che l’occupavano cominciano un’intensa sparatoria contro i nostri e Stefano Bertolotti che fa fuoco da dietro una siepe di rovi viene mortalmente colpito in pieno volto. Ai compagni subito accorsi non rimane che raccogliere le sue ultime parole: – vendicatemi -. Stefano Bertolotti sarà il primo caduto in battaglia della « Centocroci» e del Comune di Tornolo. I due tedeschi si arresero; uno ferito gravemente morì il giorno dopo, mentre il loro capitano comandante riuscì a fuggire da Bedonia e a ricongiungersi con la colonna che saliva da Borgotaro per il rastrellamento. I partigiani rientrano alla base di Setterone.
L ‘AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TORNOLO
NEL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI STEFANO BERTOLOTTI
Ricorderà quel suo primo eroico caduto dedicandogli la strada che scende dalla nazionale del Centocroci alla sua natìa Breila. Queste le parole del Sindaco, pronunciate per l’occasione alla presenza di numerose autorità, fra cui il Senatore Benigno Zaccagnini e il Dr. Lauro Grossi Sindaco di Parma. « Cari amici, Autorità civili e militari, Signore e Signori, l’iniziativa dell’ Amministrazione Comunale d Tornolo di celebrare la ricorrenza del Quarantesimo Anniversario della Liberazione ricordando la morte di Bertolotti Stefano « Sfaraia» caduto a 26 anni vittima della politica fascista, vuole, anzitutto rendere omaggio ed esprimere riconoscenza all’uomo che testimoniò con l’estremo sacrificio della sua vita, la fedeltà alla causa della libertà e agli ideali della democrazia.
La cerimonia odierna vuole poi ricordare a tutti gli italiani, e specialmente ai giovani che non hanno conosciuto le lotte cruente per la libertà, di che lacrime essa grondò e di che sangue sia la conquista del regime di democrazia di cui tutti oggi godiamo. Per i partigiani di allora, si tratta di rinnovare, oggi solennemente l’impegno di fedeltà agli ideali per i quali Stefano fece olocausto della vita. Nato a Tarsogno il 3-12-1918 era destino che nello stesso giorno dell’arruolamento nel corpo dei volontari per la libertà, immolasse la sua esistenza per quell’ideale di antifascismo in cui aveva sempre creduto e per libera scelta aderito.
Scrivendo di lui nella celebrazione del suo sacrificio si può dire: Ecco un nome che resterà: un nome che è assurto a segnacolo di riscossa ideale, un nome che già è oggi, e più lo sarà domani, faro di luce purissima liberatrice e rivendicatrice allo stesso tempo. La nostra presenza qui, conferma che il partigiano « Sfaraia » non si era ingannato e la sua scelta fu una scelta altruistica e di libertà per tutti. Volendo lasciare un epigrafe per i posteri incideremmo: «Spendere la vita per un ideale non è morire per la gloria, ma vivere per l’eternità ».
Tarsogno,4-4-1985.
Ferruccio Ferrari
Sindaco di Tornolo
Segue una candida poesia a lui dedicata da un turista.
a Sfaraia
Per te,
partigiano Sfaraia,
la lunga stagione della paura
durò lo spazio di un giorno.
Volevi uscire
dal tunnel della dittatura
per sentire il profumo della libertà
sui tuoi monti.
Come l’esistenza estemporanea
delle effemeridi
mano nemica.
spezzò dall’alba al tramonto
il tuo sogno
Sei vissuto
ugualmente
nel clima eroico di quei giorni
preludio ad una stagione
nuova.
E moristi giovane
perché caro alla Resistenza,
esempio di purezza ideale
votato al grande olocausto.
Ora una strada sassosa,
nel tuo paese,
reca inciso il tuo nome.
Onore, per sempre,
a te, Sfaraia!
Tarsogno, 4-8-1985
Carlo Drapkind
I PARTIGIANI RITORNANO IN PAESE
Dopo alcuni giorni dalla scomparsa delle truppe Nazi-fasciste, riapparvero in paese i partigiani. In quel tempo un reparto fascista lasciato di rinforzo alla caserma dei carabinieri, temendo di essere attaccato e prelevato dai partigiani, abbandonò alla chetichella S. Maria del Taro. A presidio della caserma rimase un brigadiere con alcuni carabinieri. La caserma veniva poi attaccata da una squadra di partigiani della « Berretta », provenienti da Bedonia, non trovarono alcuna resistenza, i carabinieri consegnarono le armi e alcuni si unirono ai « Liberatori ».
Proseguendo sull’entusiasmo della facile vittoria ottenuta, puntarono su Borzonasca, con la segreta speranza di nuovi e più proficui successi. Purtroppo però il lungo combattimento protrattosi per ore, permise l’arrivo di nuovi rinforzi da Chiavari e i partigiani fatti segno anche da colpi di fucile sparati dalle finestre di abitazioni private, dovettero abbandonare il paese sganciandosi in tutta fretta. A S. Maria un distaccamento del gruppo BILL di Bedonia si sistemò nella locale caserma, bruciò tutto l’archivio con documenti e registri, arruolando nel corpo volontari della libertà almeno una quindicina di patrioti locali. L’attività principale dei partigiani fu quella d’impedire e ritardare il più possibile il movimento delle truppe Nazi-fasciste, interrompendone le vie di comunicazioni, dopo averne abbattuto ponti e strade. Il 14 giugno veniva interrotta la strada di Montemoggio, facendo brillare mine già predisposte dai tedeschi. Questa ed altre azioni furono possibili grazie all’aiuto del « Carabiniere» Lagorio Serafino di Giaiette già inserito nel comando tedesco e a noi direttamente collegato. Di seguito venivano fatti saltare i ponti di Isola di Borgonuovo, del canale della Malanotte e quello di Pelosa. Così S. Maria venne completamente isolata sia nei suoi collegamenti viari di Chiavari che verso Bedonia. Vennero pure interrotte le linee telegrafiche e telefoniche, la posta arrivava raramente e con mesi di ritardo. Unici mezzi di trasporto erano le bestie da soma, le biciclette e il più comune. . . cavallo di S. Francesco. Andare a piedi a Chiavari era divenuta una cosa di ordinaria amministrazione, così pure a Bedonia e Borgotaro; arrivare però a Parma e a Piacenza, come fece più volte l’arciprete, attraversando i monti, restava comunque un’avventura sempre irta di imprevisti.
Eravamo tornati ai vecchi tempi dei nostri progenitori, quando tutti andavano a piedi. . Il 24 giugno, verso le ore 2 cadde; nella notte, un altro quadrimotore Alleato, alle pendici del M. Zatta proprio sopra il canale della Malanotte. Nella caduta s’incendiò, sprigionando alte fiamme che furono viste da tutte le frazioni attorno. Questa volta però l’aereo non era un bombardiere, ma solo di quelli da carico addetti ai lanci partigiani. Di nazionalità inglese con un carico di: armi, munizioni, vestiario, generi alimentari tabacco, medicinali e molto denaro. Gli otto membri dell’equipaggio trovarono una morte istantanea nello schianto contro la montagna, mentre il carico fu quasi completamente recuperato. Le otto salme furono ricomposte, raccogliendole fra i rottami, dalla popolazione Tarese e senza poterle identificare, seppellite cristianamente nel cimitero locale. Don Celso Mori celebrò la S. Messa e fece i funerali religiosi, presente tutta la popolazione della parrocchia che coprì letteralmente le otto bare di fiori. Una folta schiera di partigiani in armi prestarono per l’occasione servizio d’onore. Dopo la Liberazione le salme furono riesumate per ordine degli Alleati e trasportate a Genova.
Questa manifestazione corale e spontanea di popolo non poteva passare inosservata alla fitta rete di spie fasciste, provocando successive minacce e intimidazioni al parroco che adempiendo ad un preciso dovere, non poteva negare il funerale a delle povere vittime innocenti. Ai primi del mese di luglio i partigiani prelevarono a Montemoggio un genovese, Brusamonti Camillo e la figlia Rosina Giulia, ritenuti spie fasciste, vennero portati prigionieri in caserma a S. Maria. Dopo un sommario processo, e dopo aver ascoltato alcuni abitanti che li accusavano apertamente di spionaggio a favore dei fascisti di Chiavari, furono condannati alla fucilazione. La sentenza venne subito eseguita in località Barche lungo la vecchia strada comunale che sale al passo del Bocco e seppelliti a fior di terra senza nemmeno concedere l’assistenza religiosa.
Purtroppo le esecuzioni capitali sommarie tipo queste erano in quel tempo, assai comuni. Ci limiteremo ad elencarne alcune che ebbero luogo nel circondario e di cui si ebbe conoscenza. Il 5 maggio, partigiani in transito fucilarono sul monte Ghiffi un ex carabiniere. Il 7 maggio fucilarono nei prati di Codorso, Baldini Luigi figlio di una certa Botti Maria di Chiavari, già conosciuto perché la famiglia era sfollata a S. Maria Taro. I famigliari nel loro dolore raccontarono poi, che il figlio, già appartenente al famigerato Btg. S. Marco, era venuto in licenza, non per fare la spia ma aveva espresso la volontà di entrare nelle formazioni partigiane. Altre fucilazioni o esecuzioni sommarie ebbero luogo anche nei pressi di Casonetti, Streppeto, M. Penna e Casa Brina di Casale. Di quest’ultimo fatto ne faremo più avanti un racconto a parte con maggiori particolari.
Dai movimenti e dall’intensa attività partigiana si poteva desumere che stava preparandosi un altro rastrellamento, forse preponderante e in forza come quello già subito in maggio, ma nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe arrivato così repentino, inumano e tanto barbaramente tragico per tutte le popolazioni delle nostre valli.
Galli Peppino cortese ma con una personalità scomoda
Prima che incominciasse la guerra, spesso nella vallata per i suoi affari, si vedeva Galli Peppino di Bedonia. Era conosciuto da molti, ed era cortese con tutti. Questa sua abitudine di frequentare la vallata, egli la continuò anche durante gli anni di guerra e quelli dell’inizio della guerriglia dei partigiani. Dopo il primo rastrellamento, riflettendo sul modo con cui era stato condotto dai tedeschi, a non pochi era venuto il sospetto che fossero stati messi al corrente di tanti particolari da qualcuno che conosceva bene la vallata.
Il sospetto cadde su Peppino Galli, che tra l’altro, quando ritornava a casa dai suoi viaggi in ValCeno, raccontava ingenuamente quanto ivi succedeva. Tra l’altro il sospetto si rese più grave per il fatto che un suo fratello, Arnaldo, era segretario politico fascista a Tornolo. In un ambiente, come quello partigiano, in cui, specialmente agli inizi, si diffidava di tutti e di tutto, il sospetto della soffiata del Galli divenne, nella mente dei capi, una realtà, per cui decisero di toglierlo di mezzo per dare una lezione e togliere la possibilità di un pericolo futuro.
Galli Peppino venne preso per la prima volta in cui, con somma ingenuità, si presentò in vallata e venne condotto a Volpara dove si trovava la squadra comandata allora da Rossi Mario (D’Artagnan) di Bedonia, alle cui cure, gli si era detto, sarebbe stato affidato d’or innanzi, perché a Bedonia c’era del pericolo per lui. . D’Artagnan invece aveva ricevuto l’ordine di farlo fuori. Costui eseguì l’ordine sulla strada che da Volpara porta a Santo Stefano d’Aveto e lasciò il cadavere nascosto in una macchia di faggio. Di tutto questo nessuno degli estranei ai partigiani, “neppure il sottoscritto, era stato messo al corrente.
Un giorno, un pastorello di Volpara scoprì il cadavere del Galli, esposto al caldo d’agosto già da qualche giorno, e spaventato ne parlò coi suoi genitori. Essi imposero al figlio di non parlarne con nessuno per non avere noie, e vennero a Chiesiola per parlarne con me. Mi recai a Volpara e chiesi di parlare con D’Artagnan. Questi era un tipo che conoscevo, per essere stato in seminario con me, benché fosse più giovane di qualche anno. Era un po’ prepotente e menefreghista, non volle darmi né spiegazioni, non del fatto di cui non potevo interessarmi perché (così mi diceva lui) aveva eseguito un ordine superiore, ma perché non aveva provveduto ad avvertirmi, prima dell’esecuzione, per procedere poi alla sepoltura cristiana della salma.
In un primo tempo non volle neppure indicarmi dove si trovasse il cadavere, ma davanti alle mie ferme ed energiche osservazioni che non potevo permettere che si lasciasse un cadavere senza sepoltura cristiana, dovette piegarsi ai miei ragionamenti ed alle mie (forse irrealizzabili) minacce di denuncia. Permise che gli abitanti di Volpara recuperassero la salma del povero Peppino Galli, ucciso per la sua ingenuità che forse per il male che poteva avere fatto. Si celebrò la funzione funebre a Casalporino e si seppellì la salma nel vicino cimitero. Erano pochi i presenti a detta funzione per timore di essere stimati dai partigiani conniventi col defunto. Non sono mai riuscito ad avere dal comandante una prova sicura della colpevolezza da parte del Galli.
GALLI ARNALDO,
SEGRETARIO POLITICO FASCISTA A TORNOLO
Di Galli Arnaldo si sapeva molto, quotidianamente veniva da Bedonia in municipio a Tornolo, quale dirigente della sezione Annonaria. Fattosi nominare anche segretario politico fascista, repubblichino ricopriva un posto ormai scomodo che i locali avevano volutamente lasciato vacante, si mise a fare una intensa propaganda politica cercando anche nuovi proseliti fra i giovani. Rivedo Arnaldo nell’adempimento delle sue funzioni, invitare con una ingenuità, che ancora oggi fa sorridere noi giovani a presentarci alle armi, aderendo alla Repubblica Sociale per riscattare, egli diceva, l’onta del tradimento Badogliano verso l’alleato tedesco.
Viaggiava sempre con sotto il braccio o attaccata alla bicicletta, una borsa in pelle nera, dove, oltre a documenti d’ufficio, teneva volantini di propaganda fascista, tessere e timbro della sezione di Tornolo e una rivoltella di tipo « Beretta» 6,35 di cui peraltro, non se ne sarebbe mai potuto servire. Quando il movimento partigiano, cominciò a far parlare di sè e ci furono le prime sporadiche apparizioni dei banditi, andava ripetendo in giro continuamente che lui era una persona onesta, che in coscienza, stimava giusto ciò che aveva fatto e suo unico scopo era sempre stato quello di salvaguardare la nostra zona dalle deportazioni e dalle rappresaglie dei camerati tedeschi, oltre a coprire le spalle ai nostri militari al fronte che non potevano rientrare.
Una notte un gruppo di amici partigiani, viene a prelevare la cassaforte dell’ufficio postale di Tornolo, azione assai comune in quei tempi onde sostenere lo sforzo organizzativo e costitutivo dei primi nuclei ribelli. Verrà poi trasportata nella piazzola davanti al cimitero e aperta con una raffica di « sten ». Il signor Scarsella Luigi ufficiale postale, persona molto equilibrata ma altrettanto pavida e ligio alle leggi, provò una fifa maledetta ed aderendo alle sollecitazioni della moglie, bedoniese di nascita, iniziò a scendere ogni sera a Bedonia, dove secondo lui, pernottando in luogo più tranquillo e sicuro. . . Invece il Galli, cominciava ad avere timore dei bedoniesi e avrebbe preferito un posto più tranquillo e ospitale presso gli amici tornolesi. Fu così che mio nonno Scarsella Giuseppe, per intercezione del nipote Gigetto, accettò di ospitare saltuariamente il Galli per dormire, nella nostra casa dei Lusardi a Tornolo. Una volta mi ricordo, venne per una settimana di seguito, arrivava di notte, saliva le scale per il letto di sopra, mai entrando nel cucinone, dove ogni sera si davano convegno per lunghe veglie molti giovani, si giocava a carte ascoltando radio Londra.
Sapeva benissimo che ero renitente alla leva, sospettava che quando mi assentavo anche per più giorni, con la scusa di andare a trovare i parenti del Baresasco, mi recassi invece per missioni con i « ribelli banditi » però per Tornolo e a noi in particolare, non risulta che avesse mai fatto la spia. Anzi a onore del vero, una mattina a colazione, che, era ancora buio, mi fece firmare una cartolina militare, indirizzata ai miei genitori, datata da Verona, e dove assieme ai saluti e convenevoli, scrivevo che ero in partenza per l’addestramento in Germania, raccomandando ai miei genitori che se fossero stati disturbati di richieste sul mio conto, sostenessero quella tesi e mostrassero quel documento. La cartolina arrivò a Tornolo, molto tempo dopo, quando ormai del Galli Arnaldo, prelevato dai « ribelli », si erano perse le tracce.
Don Domenico Della Casa, nello ricordare a posteriori questo episodio, ancora conturbante, fece un po’ di confusione fra i due fratelli Galli; quello ritrovato sepolto ai piedi del M. Tomarlo non era Peppino, come risultato dal suo scritto, bensì Arnaldo segretario fascista repubblichino di Tornolo. Peppino Galli invece, prelevato in Bedonia, da partigiani distaccati a Tomba, venne ucciso da una raffica di Sten sparatagli alle spalle, mentre si dice, tentava di fuggire. Abbandonato sul posto, presso la Cappelletta del passo sul M. Segalino, si riprese e ritrovò la forza di alzarsi e andare alla vicina osteria di Molinari Silvio. I partigiani però ritornarono sul posto per recuperare la salma e ripreso mentre lo stavano medicando, lo eliminarono definitivamente con il classico colpo di rivoltella alla nuca. II cadavere fu poi gettato in un precipizio del Rio Costagneù che scende dal Segalino verso il torrente Ceno.
NUOVAMENTE A VOLPARA CON «SCARPA»

Volpara giugno 1944 : Ciccio Miccia – Quadrato
Dopo il rastrellamento del maggio « ’44» i comandanti partigiani sono costretti a rivedere i loro piani tattici. Emergono carenze nei collegamenti e nell’informazione. Molti fra i comandanti però si rifiutano di riconoscere gli errori commessi, si rifugiano nelle gelosie personalistiche, con il risultato che ogni gruppo si sente autonomo. Così l’Istriano sollecitato dalle offerte provenienti dal Piacentino scende verso Ferriere in Val Nure e aderisce alle formazioni garibaldine che in quel periodo erano indiscutibilmente le meglio organizzate. Gianni Moglia « Golico » non accetta l’unione con Alfredo Moglia « Bill » ma rifonda a Volpara il gruppo Penna e prende per se un nuovo nome di battaglia « SCARPA».
Questo gruppo si rafforza con l’adesione di nuove leve locali, con gente proveniente da Bedonia che entra nel movimento partigiano dopo un periodo di cauto attendismo. Quella di Volpara 44 fu una estate di relativa calma che consentì un rinnovamento dei quadri e un rafforzamento dello spirito combattivo. Tuttavia furono compiute anche azioni di sabotaggio un poco ovunque, contro ponti, linee elettriche, strade di comunicazione eccetera, seguendo una efficace tattica ispirata al sistema « colpire e sparire ».
In luglio dopo la battaglia di Pelosa il nostro raggruppamento, sfuggendo al rastrellamento in corso in Valtaro, scende in Val d’Aveto e prenderà il nome di 57 Brig. Garibaldi «Cichero» ingrossando così la Divisione Bisagno. La brigata si formò con la riunione a Bill, Commissario Dodo Braga « Rolando », Intendente «Scarpa» e l’arrivo di nuovi parmigiani come Ernesto Braga « Stefano», Rastelli «Annibale» Copercini « Pino» assumendo così le caratteristiche di una vera formazione militare organizzata. Di quel periodo ricorderò l’arrivo del tenente di artiglieria alpina REDOANO MARCO « Cengia » nato a Genova il 29 luglio 1917, laureato in Ingegneria già dipendente dalla Terni e appartenente al SIM (Servizio d’informazione militare). Persona molto colta, dopo 1’8 Settembre ’43, come la quasi totalità degli appartenenti al glorioso corpo degli alpini, non esitava a scegliere la via del riscatto e della libertà, contro l’odiosa occupazione nazista e l’opprimente dittatura fascista. Fuggito dall’ospedale militare di Verona, dove si trovava ricoverato, raggiunge la zona di Boves (Cuneo) dove si unisce alle prime formazioni di resistenza ivi costituite. Quando all’inizio dell’inverno il suo gruppo si sbanda temporaneamente, raggiunge la sua abitazione a Genova e subito prende contatto con il movimento clandestino con cui opera sino al maggio del 1944 data in cui viene inviato in montagna nella zona di S. Stefano d’Aveto. Fù lì che c’incontriamo, mi segue a Volpara e decide di entrare a far parte del « Gruppo Penna» con Scarpa. .
In Luglio, ancora in fase di sganciamento in Valtaro dal rastrellamento seguito alla battaglia di Pelosa, scende inaspettata a Piana del Principe la missione «Nembo» (dipendente della V’ Armata Americana). Il comandante tenente Emilio Lombardi « Roberto» di origine piacentino – ligure era un vecchio compagno di scuola di Marco, così « Cengia » seguirà la missione come ufficiale di collegamento, prima nel Piacentino, poi nel Parmense presso la 31′ Brigata Garibaldi.
Va anche ricordato che la missione del Ten. Roberto, arrivò quando meno la si aspettava, nel bel mezzo di uno sganciamento in corso, anzi lo stesso comandante «Bill» inizialmente non volle prendere sul serio quei temerari paracadutisti arrivati improvvisamente e tutti componenti del ricostituito esercito Italiano. Per dimostrare la loro sicura identità furono posti di fronte ad un preciso « aut aut » o far arrivare un lancio entro dieci giorni o essere dichiarati spie fasciste, lanciate dai tedeschi per infiltrarsi nelle nostre linee. La posizione venne ben presto chiarita e il Ten. Roberto poté continuare la sua missione assieme al Ten. Cengia come ho già avuto modo di raccontare più dettagliatamente. A questo punto però mi preme inserire l’unito racconto dell’amico Musa Nando « Spartaco » che come Vice Intendente di Brigata ha vissuto da protagonista il fatidico lancio. Infine riporto il motivetto musicale di origine goliardica che i paracadutisti della «Nembo» usarono con fischietti per richiamo e ritrovarsi nella notte.
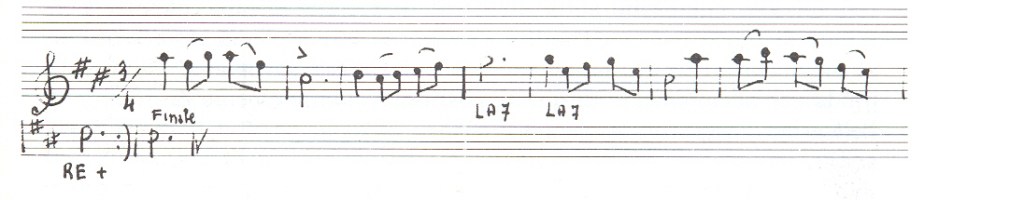
Resteranno indelebili, nella mia memoria, le serate passate con « Cengia» nell’osteria di Volpara, assieme agli inseparabili Miccia e Quadrato, di Tornolo. Basterà di lui ricordare che era leggermente « balbuziente» difetto che peraltro perdeva completamente quando con noi cantava in coro le vecchie canzoni alpine. Nel gennaio 1945 la Zona Ovest della provincia viene, investita da un violento rastrellamento, «Cengia» si pone a disposizione del comando di brigata, di stanza a Pellegrino. In considerazione della sua esperienza e capacità, gli viene affidato il comando di un reparto ancora in fase di formazione e inviato nella direzione di Varsi per contenere la pressione nemica alle spalle dello schieramento di brigata; onde permettere così al grosso, l’effettuazione del previsto piano di sganciamento. Compiuta la sua missione il reparto rientrava in zona di Pellegrino e qui sciogliersi a sua volta. Mentre con un compagno Enrico Ruffini « Fantasma» di Fidenza si dirigeva verso Careno « Cengia » scorgeva un reparto nemico in marcia, nella sottostante strada Castellaro – Careno. Con grande abnegazione e sprezzo del pericolo, piazzava la sua arma e apriva il fuoco contro la colonna nazista obbligandola, ad un’ulteriore sosta; solo la morte poneva fine al suo generoso tentativo. Alla sua memoria è stata conferita la Medaglia d’Argento al V.M. Con la seguente motivazione:
La Repubblica Sociale Fascista lo commemorerà per radio alcune sere dopo, citandolo come un Badogliano venduto al nemico che aveva cambiato la divisa grigioverde con quella kaki. Lo trovarono che portava ancora il « vecchio» cappello d’alpino, ormai sgualcito dalle intemperie e dai lunghi periodi di battaglia, sepolto nella neve, all’estremo delle forze, si faceva uccidere, piuttosto che arrendersi
Partigiano Medaglia d’Argento al V. M. (alla memoria)
REDOANO MARCO
Classe 1917
Già distintosi nella lotta partigiana per ardore combattivo e redditizia attività informativa, in dura situazione di guerra non esitava a porsi con un solo compagno sulla direttrice di marcia di una colonna. Con azione di fuoco tenace ed ardita riusciva ad imporre una sosta sensibile al movimento nemico, molto favorendo la difesa partigiana. Cadeva da prode nell’adempimento di questa missione volontariamente assunta.
Pellegrino Parmense, l0 gennaio 1945.
RICORDO DI UNA PARENTE VALOROSA AMICA
Il 20 Giugno un pomeriggio arriva a Volpara un forte gruppo di 40 partigiani dell’lstriano, di cui, non apparivano ben chiare le intenzioni. Erano comandati dall’amico « Ralf ». Questi credendo di far « cantare» la nostra staffetta-basista locale, Moglia « Driola » dopo una abbondante libagione svelava che erano venuti solo con lo scopo di prelevare « forzata manu » le nostre armi automatiche di dotazione, per la scarsità di armamento automatico dei partigiani in Valnure. Ugualmente ricevevo una soffiata a conferma dalla Calzetta Luisa « Tigrona », cara amica di Isola di Compiano, che più tardi cadrà eroicamente combattendo e alla sua memoria verrà concesso la medaglia d’argento al valor militare con la seguente motivazione:
Partigiano Medaglia d’Argento al V. M.
(alla memoria)
CALZETTA LUISA
Classe 1919
Indomita partigiana, nel nobile tentativo di portare al sicuro un componente della propria formazione che era rimasto ferito in combattimento, veniva circondata da un folto numero di nemici. Impugnata la pistola, si difendeva con eroica fermezza fin tanto che, sopraffatta, veniva trucidata. Fulgido esempio di abnegazione e di attaccamento alla causa. Zona di Gropparello (Appennino Piacentino), 4 dicembre 1944. Immediatamente passiamo la voce e corriamo ai ripari. Nascondiamo in alcune stalle i vari « Sten » mitra e mitragliatore, con relativo munizionamento e le cassette delle bombe a mano, mentre alloro posto vengono messi in bella evidenza solo carabine e moschetti di tipo 91 lungo, già della guerra 1915-18.
Amichevolmente, i compagni fraternizzano all’osteria con i nuovi venuti. Mi presi il gusto di far visitare la nostra « caserma» in casa Vignola a « Ralf » impegnandomi in maniera solenne di fargli avere a Pertuso (dopo alcuni giorni) almeno alcuni muli carichi di dinamite; unica cosa a mio dire che avevamo in abbondanza e nascondevamo, lontano dall’abitato in una grotta sotto Spora. Accertata la mancanza di un valido armamento, forse resi edotti che la sorpresa era sfumata, facevano buon viso a cattiva sorte, rimarcavano le mie proposte e il giorno dopo ripartivano per la Val Nure via Selvola Zoallo alla spicciolata come erano venuti.
Medaglia d’Argento al V.M.
(alla memoria)
GHILLANI OTELLO
Classe 1925
Ghillani Otello, nato il 18 febbraio 1925 a Parma. Combattente attivo e ardimentoso partecipava a moltissimi fatti d’arme contro soverchianti forze nemiche, riuscendo sempre ad ottenere brillanti risultati ed infliggendo ingenti perdite in uomini e materiali. Il 26 e 27 giugno 1944 a Farini d’Olmo, dopo 36 ore di accaniti e sanguinosi combattimenti contro preponderanti forze nazifasciste, muoveva all’assalto contro l’ultima estrema resistenza nemica ponendosi alla testa del suo distaccamento ed assicurando un’altra vittoria alla lotta di liberazione. Per tale eroico comportamento veniva promosso « Comandante di distaccamento» sul campo. Bettola,
15 agosto 1944.
ESTATE 44 SCONTRI A DISTANZA
Verso la fine di giugno ’44, su preciso incarico del Comandante « Scarpa », con una sola squadra, ci recammo nella zona di Rezzoaglio per un’azione segreta, su richiesta e in accordo con il maresciallo dei C.C. Monaco Luigi agente con stazione R.T. già facente parte del gruppo OTTO di Genova. Il giorno stabilito, stipati in una vecchia « Topolino » furgonata raggiungemmo il passo della Forcella, dominante su Borzonasca, luogo fissato per l’importante appuntamento. Di questo incontro peraltro noi gregari che figuravamo solo come scorta armata, non conoscevamo né il motivo né l’importanza dei personaggi che lo avevano organizzato. Dopo breve attesa giunse lassù un distaccamento del fantomatico gruppo « Virgola» sbandato si a seguito di un cruento rastrellamento nella zona di Velva. Questi partigiani in effetti desideravano ricevere aiuti per sfamarsi e stavano esaminando la possibilità di unirsi a noi. Il nostro comandante incaricato Beccarelli Angiolino « Rata» ed il maresciallo iniziarono le trattative, ritirati sotto il voltone della cappelletta. La forza di quel reparto era di dodici uomini più una giovane e florida ragazza. Erano tutti poco loquaci e molto disciplinati. Il mio amico il « Gobbo» mi chiama dietro al costone della strada, facendomi cenno di chinarmi vicino a lui, mi fece notare con voce sommessa ed allarmata, che i sedicenti partigiani di « Virgola» erano vestiti tutti in pantaloncini corti kaki, maglioni e camicie grigio verde ed erano dotati di armi personali solo di marca italiana o tedesca; unico richiamo patriottico i foulard rossi portati al collo molto vistosamente. Restammo sul chi vive a lungo, il « Gobbo» aveva addirittura già tolta la sicura allo Sten e aveva allineato davanti a se diverse bombe a mano, tolte dal tascapane assieme all’inseparabile bottiglia di grappa. Sentivo il cuore che batteva forte, ma nell’intimo dell’animo attribuivo tutto ciò ai primi calori estivi e alla nuova divisa di panno inglese che indossavo.
Come Dio volle l’incontro finì, i nostri ospiti ci fecero un lungo ed amichevole saluto con la mano alzata a pugno chiuso e ritornarono sui loro passi per lo stesso sentiero da dove erano venuti. Più tardi da Rata apprendemmo che avevano fatto richiesta di un « aviolancio » promesso dal maresciallo, il quale, in attesa, per la « sopravvivenza » aveva anticipato un biglietto da mille lire. In quegli stessi giorni «Cengia » aveva fatto inviare un camion della Terni da Sestri Levante, tramite il fratello. Nella notte il gruppo sabotatori, sceso da Volpara al completo aveva fatto saltare il ponte della « Squassa» sulla strada che saliva da Borzonasca dopo la curva e un po’ prima dell’omonimo albergo. Quel pomeriggio fu giocoforza, dietro le richieste di molti sfollati, inviare il camion guidato da Carpano, sul luogo del sabotaggio, per trasportare i passeggeri della corriera in arrivo diretti nei paesi della Val d’Aveto.
Fu nel ritorno, quando arrivati al passo della Forcella, pressati dalla fretta perché da Borzonasca ci avevano avvertiti dell’arrivo di due colonne fasciste, che Carpano, forse poco pratico nella guida di quel tipo di Camion Lancia 3 RO, forse causa lo scoppio di qualche colpo di mortaio nelle vicinanze, perse il controllo dell’automezzo che finì contro lo sperone roccioso del Passo. Trovandomi sdraiato sul parafango anteriore destro con imbracciato un mitragliatore « Brem » per il contraccolpo mi ritrovai sbattuto contro la roccia. Pagavo così le conseguenze della posizione molto pericolosa che avevo assunto. L’amico Vittori « Apuano » con l’aiuto di altri mi adagiò nella cunetta cercò di suturarmi le ferite con i pacchi di medicazione, mi coprì con un telo per ripararmi dal sole. In quel trambusto fui di fatto abbandonato, perché considerato ormai spacciato. Ricordo di aver perso i sensi; lo stato di choc m’impediva di parlare, ma sentivo i discorsi di chi mi stava intorno; più tardi, sempre sotto choc, mi accorsi che altre persone mi toglievano i panni inglesi di dosso e gli scarponi per lasciarmi con solo le mutande e canottiera essendo considerato ormai morto.
Per mia buona sorte il maresciallo dei C.C. e Rata verso le ore 21 rientrati i fascisti a Borzonasca, ritornarono sul posto. . . per il recupero dei miei miseri resti. Con loro grande meraviglia scoprirono che respiravo ancora. A tutta velocità mi caricarono sulla « Topolino », mi trasportarono all’albergo Leon D’oro di S. Stefano d’Aveto, dove in nottata mi fecero operare e ricucire dal medico condotto e dal Prof. Podestà. In quei tempi scarseggiavano i medicinali e non trovandosi anestetici e antidoti adatti, ricorsero all’uso dell’acqua ossigenata e alla tintura di iodio. Per calmare le mie grida di dolore, dato che mi si operava senza anestesia, mi fu messo un tovagliolo in bocca con un nodo, trattenuto saldamente dietro al collo dall’amico « Rata ». Un trattamento, come avevo veduto, solo nelle scene del Far West.
Questo ho voluto raccontare, non per vanità, ma perché il fatto dell’ incontro alla « Forcella» fu l’inizio di successivi avvenimenti molto importanti e anche luttuosi, ma certamente determinanti sulla nostra permanenza in Val D’Aveto. I mesi di Luglio e agosto li passai in convalescenza al « Leon D’Oro », ottimamente trattato ed assistito dai proprietari F.lli Monteverdi Ricordo che non essendo possibile ingessare l’arto colpito causa la ferita lacero contusa e tutta ingraffettata, mi fecero preparare dal locale falegname una formella con delle assicelle, in cui ogni mattina inserivo la gamba destra fasciando poi il tutto con una lunga benda.
Questa protesi artigianale, mi permetteva di spostarmi ogni mattino, con l’aiuto delle stampelle, dall’albergo al comune e recarmi ai giardinetti, dove incontravo molti amici sfollati dalla vicina Liguria. Dopo la battaglia di Pelosa e successivo sbandamento, arrivò Alfredo Moglia « Bill» con l’inseparabile Commissario Dado Braga « Rolando ». Fu li da me che una sera si definì l’accordo con la Divisione Bisagno per cui riunite le forze a quelle di Gianni Moglia « Scarpa» si costituì la 57′ Brigata Garibaldi « Cichero ». Si venne a conoscenza che una colonna fascista camuffata, aveva fatto una puntata nella zona di Rezzoaglio catturando il maresciallo dei C.C. Luigi Monaco e prelevando la stazione R.T. e impadronendosi dei codici segreti cifrati.
In quel frangente il « Gobbo» si salvò per miracolo. Mescolatosi con carbonai veneti, suoi compaesani, sostenne di essere uno di loro e infiorando il discorso nel suo idioma, riuscì a far credere di essere « mal tacconado » di non capire nulla di politica e di essere stato sempre così dalla nascita. Queste puntate fasciste che utilizzavano la tattica del colpo di mano a sorpresa, tattica tipicamente di stampo partigiano, impensierivano notevolmente il nostro comando che intensificò le vedette e sguinzagliò per ogni dove, informatori e staffette. L’operazione diede i suoi frutti; infatti vennero presto catturate due giovani donne che avevano il compito di arrivare in anticipo nei luoghi, prescelti per le puntate, per conoscere meglio l’ambiente e prendere le informazioni necessarie a preparare l’azione armata che immancabilmente seguiva il giorno dopo.
Le due donne furono riconosciute come aguzzine della Federazione repubblichina di Chiavari, come appartenenti alle SS italiane e più tristemente note come torturatrici della S.D. Ricordo, che la più giovane era poi la stessa che accompagnava il gruppo sbandato di «Virgola» al Passo della Forcella, durante l’incontro con Rata e il maresciallo dei C.C. La stessa fu poi identificata per Campaila Giovanna, segretaria particolare del Federale fascista Vito Spiotta di Chiavari. Il peso delle accuse che gravavano sulle due prigioniere era grande. Il tribunale partigiano le condannò alla fucilazione; la sentenza venne eseguita alcuni giorni dopo all’alba, nella cunetta della strada provinciale nei pressi di S. Stefano D’Aveto.
Sempre in quei giorni era arrivato a S. Stefano anche 1’Istriano proveniente da Castell’ Arquato con la preda di quattro camions tedeschi e relativi autisti, con un carico di centinaia di seggiole a sdraio che erano destinate ad un ospedale militare tedesco. Fu un piacevole incontro con i vecchi amici di Parma, i quali mi regalarono una sdraio per la convalescenza e mi rifornirono di munizioni calibro 7,65 per rivoltella da noi quasi introvabili.
Quella stessa sera accadde anche un fatto grottesco che per poco non sfociò in tragedia. Un partigiano di Parma noto col nome di « Penato » si recò all’albergo Leon D’Oro, in cerca di avventure. Volle cioè avvicinare le due prigioniere per entrare nelle loro grazie, millantò con la sua ben nota parlantina, tutta una serie di amicizie e conoscenze fra i partigiani e relativi comandanti. Si impegnava con una formale promessa convalidata da giuramento, a farle liberare o nel peggiore dei casi portarle in salvo con la sua squadra. Quando le due donne si resero conto che per loro era giunta la tragica fine, rivelarono tutto quanto aveva loro proposto il « Penato» e lo sfidarono a testimoniare. Il comandante Bill fece parlare le prigioniere a lungo. Esse raccontarono l’incontro della sera nei minimi particolari. Le rivelazioni lo mandarono su tutte le furie tanto che sull’istante ordinò l’arresto dello sprovveduto. Il Consiglio subito riunito decretò la pena di morte per il « Penato» ganimede, incolpato di aver rivelato al nemico; notizie, dislocamento e consistenza del movimento partigiano. Gli amici di Parma all’unisono invocarono la « grazia» per il compagno « Penato» descrivendolo come individuo innocuo al movimento ma solo donnaiolo impenitente e mitomane. Inoltre garantivano che lo avrebbero riportato via con il gruppo Istriano e che non si sarebbe più fatto vivo in Val Taro o nelle zone controllate dal gruppo « Penna» fino alla fine della guerra. Così riuscirono a salvarlo . . .
Battaglia di Pelosa – Serventi Fortunin
Durante il mese di luglio, nella nostra vallata, giunse l’eco dei fatti avvenuti ad Alpe e Strepeto, dove, dopo lo scontro armato di Pelosa, ci furono feriti, morti ed incendi. Nello scontro di Pelosa, avvenuto il giorno 10 e 11, la parrocchia di Chiesiola dovette lamentare la morte del parrocchiano: il partigiano Serventi Fortunato (Fortunin). Ferito in molte parti del corpo, venne portato nel Seminario di Bedonia, che allora fungeva da ospedale, ed ivi spirò fra dolori atroci; il medico non ha potuto far nulla per lui. Il funerale di questo nostro eroico parrocchiano fu celebrato a Chiesiola con grande concorso di popolazione venuta da tutte le parrocchie della vallata. I suoi compagni di arma col comandante in testa prestarono servizio di onore. La vecchia mamma Marianna ed i fratelli, fra i quali c’era Pietro, lui pure partigiano, esternarono la loro forza d’animo e rassegnazione in una circostanza tanto dolorosa.
Rastrellamento e scorrerie nazi fasciste estate 44
Da qualche giorno era stato preannunciato un rastrellamento di fascisti e tedeschi che dovevano partire da Chiavari per portarsi fino a Bedonia, e proseguire quindi per la valle del Ceno. La sera del 16 luglio, mi trovavo in chiesa per la recita del santo rosario e la benedizione col 88., quando durante la funzione, mentre mi trovavo inginocchiato davanti al tabernacolo aperto, sentii del rumore all’esterno della chiesa in direzione della canonica. Terminato affrettatamente la funzione, mi precipitai fuori per vedere di che cosa si trattasse. Appena fuori dalla chiesa, mi trovai davanti ad un ufficiale tedesco che, con un italiano appena intelligibile, mi disse che dovevo, a tutti i costi, dare cena ed alloggio almeno a tre soldati tedeschi durante il rastrellamento che era iniziato allora.
Portai come scusa di non poter soddisfare la sua richiesta la presenza in casa di ben cinque persone, oltre me, e la mancanza di letti. L’ufficiale non volle ascoltare ragioni e mi disse esplicitamente (questo lo disse ben chiaro) che se non avevo letti a disposizione, i suoi soldati si sarebbero accomodati magari nel corridoio sdraiati sulle loro coperte, ma non sarebbero più usciti dalla mia canonica, e dopo questo… ordine uscì dalla canonica. Davanti ad un’imposizione così perentoria dovetti adattarmi e mettere al corrente della situazione i miei ospiti di Lavagna. Essi erano, come ho visto, già tanto spaventati per il contegno dell’ufficiale tedesco. Quando i tedeschi avevano fatto irruzione in canonica, vi si trovava solo la Maria col piccolo Eugenio sulle ginocchia, che stava per addormentarsi. Al vedersi comparire dinanzi la figura dell’ufficiale, la Maria, emise un grido (lo avevo sentito dalla chiesa), balzò dalla sedia su cui si trovava seduta, e, senza accorgersi di quello che stava facendo, mandò a ruzzoloni in mezzo alla cucina il piccolo Eugenio. È questo il motivo per cui, rientrando in canonica dalla chiesa, trovai una confusione indescrivibile.
Uscito l’ufficiale, come me, anche i Sig. Mangiante, si rassegnarono alla sopraffazione e dovettero preparare qualche cosa per la cena dei nuovi ospiti. Intanto la signora Ester mi fece capire che, con tre soldati tedeschi in casa, non si sentiva di dormire in canonica. Andò quindi da Moglia Sante, presso cui sperava di potere trovare, per quella notte, alloggio. La sua richiesta venne accolta con carità cristiana dai bravi Sante ed Adelaide. Usciti di casa i miei sfollati, mi trovai solo soletto con tre soldati tedeschi armati fino ai denti, senza riuscire a capire che intenzioni avessero. Feci loro vedere la camera che potevo mettere a loro disposizione, avendo tutta la canonica libera dopo l’allontanamento involontario degli sfollati.
Questi tre… ospiti capivano bene l’italiano se parlato adagio, e a qualche modo riuscivano a farsi capire in un italiano un po’ approssimativo. Temendo che, durante il sonno, che speravo di non riuscire a prendere, i miei tedeschi mi ispezionassero la casa, a mia insaputa, sono sceso nella casa di Moglia Lazzaro e gli chiesi se permetteva che il suo garzone Peppino venisse a dormire con me in canonica. Il ragazzo, mio affezionato chierichetto, di 10 anni circa, mi fece così compagnia durante tutta la notte.
Una volta ritirati nella loro camera, dove avevano portato tutto il loro armamento, sentii i tre soldati recitare le loro preghiere in latino a voce sufficientemente alta per essere intesi anche da noi due che occupavamo la stanza attigua alla loro. Dopo circa mezz’ora non si sentì più nulla nella loro stanza. Il mio Peppino, stanco per la sua giornata di pastorello, se la dormiva beatamente; io invece stavo almanaccando sui casi miei che non mi sembravano dei più rosei, e stavo pensando al domani. Dopo circa (il tempo in certi momenti non si misura) un’ora di questi ripensamenti sento un’improvvisa scampanellata alla porta di casa.
Balzai dal letto, mi infilai la talare e corsi da basso, mentre sentivo che nella stanza accanto i tre tedeschi si erano destati e stavano parlando fra di loro. Giunto davanti alla porta chiusa, chiesi: – Chi c’è? Nessuno rispose. Chiesi di nuovo chi aveva suonato, e sentii come un soffio una voce che rispose: – Bill! Il comandante della brigata, che durante il giorno era andato a dare una mano alla brigata Beretta per un’azione di sabotaggio nei pressi di Bertorella. Al sentire quella voce che riconobbi, aprii subito la porta e nell’oscurità intravidi la figura di Bill con la pistola spianata. Appoggiai la mano sull’arma che gli abbassai, ed egli mi chiese in un fiato: – Hai dei tedeschi in casa? – Ma sì. Non li senti parlare? – In quale camera sono? – In quella sopra la saletta. – In quanti sono? – In tre e ben armati. – Ce ne sono in paese? – E come! In tutte le case ce ne sono, e siamo stati costretti a ricoverarli.
Vicino a Bill nell’oscurità intravidi altre figure e compresi che formavano il gruppo che erano di ritorno da Bertorella. Sentendo ancora parlare i tedeschi nella loro camera, mi affrettai a dire a Bill: – Gli altri si sono ritirati verso il Penna, prendendo la strada che conduce alle Galere e Romezzano. Per carità, allontanati dal paese, prima che vi vedano, altrimenti ci possono essere dei guai per voi e per noi. A questa mia raccomandazione Bill coi suoi si allontanò con un «Ciao» sussurrato. Richiusi la porta e stetti fermo pensando: – Cosa dirò a quelli di sopra se vogliono sapere qualche cosa della scampanellata?
Mi venne in mente un’idea che tentai di tradurre in pratica. Mi portai nella mia cucina, poi di nuovo vicino alla porta di casa che riaprii, e dopo un istante, rinchiusi col chiavistello, come ero solito fare tutte le sere. Risalii le scale, mentre i tre tedeschi continuavano nel loro parlottare incomprensibile. Non uscirono dalla loro camera. Entrai nella mia, dove trovai il mio Peppino sveglio. Appena entrai, mi chiese: – Chi ha suonato il campanello? Con la più bella faccia tosta che la circostanza richiedeva gli risposi: – Era la signora Mangiante. È venuta a chiedere il pettine, che, ieri sera, si era dimenticata di prendere, quando è andata a dormire nella casa di Sante. Il mio Peppino, soddisfatto della mia spiegazione, voltò fianco e dopo un po’ si appisolò di nuovo. Con questa scusa potevo essere sicuro che anche egli avrebbe dato la mia medesima versione agli occupanti tedeschi, che intanto avevano cessato il loro parlottare e-davano l’impressione di non aver dato importanza alla cosa.
I tedeschi, nel ritirarsi nella loro camera, la sera, avevano espresso il desiderio di essere svegliati alle sei. Non chiusi letteralmente occhio tutta la notte. Erano circa le cinque e mezza, quando, senza fare rumore per non destare né Peppino, né i tedeschi, mi alzai da letto, mi vestii, scesi nel pian terreno. Uscii di casa per recarmi alla casa di Sante. Egli era già desto. Feci alzare la signora Mangiante, e, in due parole la misi al corrente dell’avventura della notte, la pregai che desse la versione del pettine se venisse interrogata dai tedeschi.
Ritornai in casa e destai, ormai erano le sei, Peppino e i tedeschi. Scesi in cucina, fecero la loro pulizia personale ed attesero ordini dal loro ufficiale, dopo aver accettato la colazione offerta dalla Signora Mangiante, che intanto era rientrata in casa e che si scusò d’aver interrotto il loro sonno per la dimenticanza del pettine. Intanto che i tre tedeschi stavano facendo colazione, di cui si mostravano soddisfatti, la signora Mangiante attaccò discorso con loro per sentire di che umore fossero, e nel parlare, trovandoli abbastanza socievoli, tra l’altro, fece un confronto tra l’esercito tedesco e le SS tedesche, lodando i primi e trovando da ridire sulla condotta dei secondi, sperando così di accaparrarseli e non avere noie da parte loro durante il rastrellamento.
Durante la chiacchierata della signora Ester, i tre la stavano guardando come se non intendessero cosa dicesse. Quando essa terminò, uno dei tre, mostrando la piastrina che aveva al collo, disse: – Noi essere SS! Non ricordo più di che colore fosse il viso dei presenti! Il tedesco che aveva parlato, continuò dicendo (col suo italiano approssimativo) che per quello che aveva sentito non dovevamo temere, perché purtroppo, anche nelle loro file ce n’erano pochi che meritavano… l’elogio fatto dalla signora. Questo episodio, con una comprensione… che non sono riuscito a comprendere, non ebbe seguito da parte dei tedeschi e finì così.
In questo frattempo, l’ufficiale tedesco della sera precedente con un suo subalterno ed un fascista, che doveva fare da interprete, si presentò in canonica chiedendomi di poter salire sul campanile e servirsene come punto di osservazione. Trovai la scusa che il campanile non era forse adatto, essendo un po’ basso, e che le scale di legno erano ridotte in uno stato che rappresentavano un pericolo per le condizioni precarie in cui si trovavano, e non pochi pioli mancavano addirittura. Egli non volle sentire ragioni e dovetti accompagnarlo ai piedi del campanile; essi salirono fino alla cella campanaria. Fortuna volle che in quel giorno vi fosse di buon mattino una folta foschia, per cui scesero, si scusarono con me dicendomi che… veramente il campanile non era di nessuna utilità per loro e tra l’altro le scale erano veramente malsicure per poter portare nella cella campanaria i loro strumenti di osservazione.
Ero contento che questo inconveniente fosse andato a buon fine quando, ritornato in canonica e congedato l’ufficiale, la Maria di Sante e l’Annetta di Lazzaro bussarono alla mia porta portandomi ciascuna un fagotto e chiesero: Ci fa il piacere di portare da mangiare a Marco (fratello della Maria), a Louis, Jean (fratelli dell’Annetta) e a Tognin (cugino dell’Annetta). Non capii, in un primo tempo la loro richiesta, poi mi spiegarono che i loro fratelli e cugino si trovavano nel soffitto della chiesa, dove si erano rifugiati in fretta e furia la sera prima, quando i tedeschi ed i fascisti erano già in paese. Non mi ero ancora ripreso completamente per i fatti occorsomi durante la notte che questa mi sembrava addirittura enorme. Questo mio nuovo spavento era determinato dal fatto che l’ufficiale, per salire sul campanile, aveva dovuto sfiorare una porticina che portava nel soffitto della chiesa dove i giovani si erano ricoverati a mia insaputa.
Mi dovetti decidere a fare qualche cosa. Posi le due ragazze nei crocicchi della strada perché facessero la guardia intanto che salivo la scala esterna, e portavo i rifornimenti ai rifugiati nel soffitto della chiesa. Arrivai nel soffitto senza farmi scorgere, ed appena dentro, non vidi nessuno. Chiamai sottovoce i rifugiati, non ottenni risposta. Ripetei la chiamata e sentii muoversi una delle assi che si trovavano nel solaio. Sporse la testa Jean che chiamai fuori con g li altri.
Diedi loro i due fagotti che avevo con me, e mi accordai con loro che la mia prossima venuta fino a loro sarebbe stata preceduta, se mi era possibile, da un suono dell’armonium della chiesa, quindi non si fidassero a farsi vedere da chi avrebbe potuto entrare nel solaio senza quel dato convenzionale. Raccomandai poi di non fare il minimo rumore per non farsi scoprire, perché in caso contrario non ci sarebbero stati di mezzo soltanto loro, ma anche le loro famiglie, il sottoscritto come connivente e forse anche la popolazione dell’intera parrocchia.
Riuscii a compiere il tragitto di ritorno in piena tranquillità. Verso sera del medesimo giorno la Maria e la Virginia (sorella di Tognin) mi portarono un altro fagotto perché tentassi di nuovo a portare qualche cosa ai rifugiati. Dovetti aspettare che calasse la notte per potermi azzardare a salire la scala del campanile, donde si poteva passare nel soffitto della chiesa, senza essere visti. Riuscii a consegnare il fagotto e mi feci dare gli avanzi del mattino. Nell’oscurità stavo per iniziare la discesa della scala quando intravidi in fondo alla scala due ombre che si muovevano. . Mi si gelò il sangue nelle vene, e dissi fra me: – Ormai ci sono! !!
Scesi con passo apparentemente franco e, giunto poco lontano dalle ombre, chiesi: – Che cosa fate qui? – pensando di rivolgermi a qualche fascista, ed invece sento la voce della Maria, che insieme con la Virginia, mi disse: – Ci fa il piacere di portare ai nostri fratelli questi due cuscini, così si potranno coricare meglio! Dico sinceramente che mi era venuta la tentazione di prenderle a schiaffi tutte e due, per il pericolo in cui avevano messo se stesse, me ed i loro fratelli.
Presi in fretta e furia i cuscini, consegnando loro i fagotti dei fratelli, risalii di corsa la scala, buttai nell’interno i cuscini, ed ancora di corsa mi portai in canonica col cuore in gola. Le due sorelle, per loro fortuna, erano già sparite! Le avventure di questo rastrellamento però non finiscono qui. Il giorno dopo, nell’imminenza della partenza, i fascisti si erano riuniti nel piazzale della chiesa. Erano sdraiati per terra in attesa dell’ordine di partenza. Ad un certo momento, sento, nella confusione, un fascista gridare: – Chi è che tira i sassi?
Gli altri negarono di essere autori di un tanto… delitto. Dopo pochi minuti sentii ripetere la medesima domanda dallo stesso fascista. Non riuscivo a capire il perché… Ad un certo momento, con mio orrore, mi accorgo che qualche sasso effettivamente colpiva quel fascista, ma il sasso non proveniva dai suoi commilitoni, bensì da un foro, a forma di croce, che si trovava nella facciata della chiesa. Erano i miei quattro… lazzaroni, che si trovavano nel solaio della chiesa, e che stavano scherzando col pericolo di farsi scoprire all’ultimo momento.
Compresi la situazione, e non sapendo cosa fare, rivolgendomi ad un bambino che giocava alla fontana e stava spruzzando d’acqua un suo amichetto, gridai: – O la pianti o vengo su e te la faccio piantare! I fascisti credettero mi rivolgessi a quel bambino, ma per fortuna che gli abitanti del soffitto compresero e sospesero il loro gioco pericoloso. A questa scena aveva assistito, senza che me ne accorgessi, anche un ufficiale fascista che da Spora aveva condotto a Chiesiola per la partenza i suoi militi. Egli aveva visto donde venivano i sassi e, senza riflettere che io mi trovavo già nel piazzale della chiesa, entrò in canonica e chiese di me alla signora Mangiante per ottenere spiegazione del fatto a cui aveva assistito. Voleva vedermi perché intendeva salire sul soffitto della chiesa per snidare coloro che vi si erano rifugiati.
La signora, che sapeva già dei quattro, non negò il fatto della presenza dei rifugiati nel soffitto della chiesa, ma prese la loro difesa adducendo l’età e la condizione di salute dei ricoverati, e che non erano partigiani, con un coraggio tale che l’ufficiale rimase in un primo tempo meravigliato e poi offeso, e nello stesso tempo soggiogato alla sua diatriba, benché la signora si fosse espressa con termini poco riguardosi verso gli italiani (cioè i fascisti) che si mostravano tanto succubi ai tedeschi in casa propria. Quasi annichilito dalla foga della signora Mangiante, l’ufficiale uscì dalla canonica, e incontrandomi nel piazzale mi disse: -Se a lei ed al suo paese è andata bene ringrazi sua cugina. A queste parole sono cascato dalle nuvole. Di che cosa intendeva parlare? E poi chi era questa mia cugina?
Dopo pochi minuti venne dato l’ordine di partenza, e fascisti e tedeschi lasciarono il paese. Partiti i fascisti e i tedeschi riferii in canonica la frase dettami dall’ufficiale fascista. Solo allora venni a conoscenza della scena avvenuta in canonica pochi minuti prima, e dagli occhi ancora rossi e dall’emozione della signora compresi chi era mia cugina. Per togliermi dai pasticci si era fatta passare per mia cugina sfollata ed aveva preso le mie difese. Grazie di cuore, Signora Mangiante.
Quando scesero i miei… amici del soffitto, mi intesi con loro. Non intendevo più correre rischi con tipi di così poco buon senso, per cui ho loro proibito di servirsi della chiesa come nascondiglio, minacciando di denunciarli se non avessero tenuto conto delle mie minacce. In paese questa invasione notturna di tedeschi e di fascisti, e la loro permanenza portò molto spavento. Quasi tutte le case del paese hanno dovuto dare ospitalità, perché solo pochi gruppi si erano spinti lontani dall’ Anzola. Il grosso del pericolo e del disagio l’hanno dovuto subire Chiesiola, Fornolo e Casalporino. In alcune case, i cui abitanti avevano destato sospetto per il loro contegno di spaventati, i fascisti (non mi risultò che avessero fatto altrettanto i tedeschi) hanno rovistato da capo a fondo per vedere se c’erano nascosti partigiani; per questo aprivano i cassetti dei comò e dei comodini; però una volta partiti gli… invasori, i proprietari delle case si sono accorti che erano stati sottratti catenelle d’oro, orologi ed altri oggetti di valore.
In mancanza di partigiani, i fascisti hanno pensato a portare con sé qualche cosa come ricordo del pacifico rastrellamento. In seguito a questo fatto l’ingegnere mi chiese se vicino alla chiesa non c’era la possibilità di trovare o costruire un rifugio senza dovere correre fino alle Galere. Se i tedeschi fossero arrivati improvvisamente di notte. Come era successo in tale circostanza, come era possibile recarsi fino al rifugio? Pensammo di scavare un rifugio sotto il pavimento di uno stanzino della stessa canonica, capace di contenere almeno tre persone, lo ricoprimmo con una gettata di cemento ed una botola, sempre di cemento. Era possibile servirsene in caso di emergenza, ma per fortuna che, durante la permanenza dell’ingegnere in canonica, non ne abbiamo avuto mai bisogno.
Nino Rolleri primo cappellano partigiano
Circa un mese dopo questo rastrellamento, un pomeriggio, mi vidi capitare in casa don Nino Rolleri, cappellano del Comando Unico di Parma. Siccome sapevo che detto sacerdote, oltre che prestare il suo servizio di cappellano, in non poche circostanze, si era interessato per salvare non pochi ostaggi dai tedeschi e fascisti, la sua improvvisa comparsa mi recò molta gioia. Dopo i primi convenevoli, anche con i miei ospiti, disse che desiderava parlarmi a tu per tu. Ci ritirammo nella mia cucinetta e, ricordandomi che non poteva accettare la mia ospitalità perché doveva proseguire per Santo Stefano d’Aveto a nome del Comando Unico di Parma, mi ricordò il rastrellamento del maggio precedente e volle sapere che contegno avevo tenuto in quella circostanza. Con sincerità e schiettezza gli esposi quanto avevo fatto allora. Egli non mi interruppe duramente la mia esposizione, e quando terminai, mi disse: Va bene. Sapevo già tutto, e temevo che le cose fossero andate in un modo differente. Mi avvertì che quanto io gli avevo detto era esattamente uguale al rapporto che era stato steso in quella circostanza nella cuci netta in cui ci trovavamo, rapporto che era stato sottratto ai tedeschi in un’imboscata e che ora si trovava al Comando Unico di Parma.
Per quello che riguardava me, a Parma mi si credeva un connivente coi tedeschi per avere loro offerto la mia cucina per stendere detto rapporto ed aver loro offerto da bere. Egli era stato mandato fino a Chiesiola per sentire come veramente erano andate le cose. Conoscendo i miei sentimenti nei riguardi dei fascisti, mi tranquillizzò, assicurandomi che avrebbe chiarito tutto a Parma, perché oltre che dai fascisti non dovessi avere delle noie anche dal Comando Unico. Dopo aver preso uno spuntino per merenda, gli indicai il percorso per arrivare a Santo Stefano e partì rifiutando la mia compagnia e raccomandandomi di non allontanarmi dal paese per non dare nell’occhio.
Grazie, Don Nino!
Don Domenico Dallacasa «Dado»
UN EPISODIO SCONCERTANTE
All’inizio dell’estate nel giugno del ’44, cinque « marò » della X Mas Btg. S. Marco di stanza a Chiavari, riuscirono ad ottenere un permesso per rientrare a casa e confidando nella strada per Bedonia ritenuta più sicura della ferrovia, continuamente bombardata, salirono sulla corriera in partenza da Chiavari nel pomeriggio, per la Valle del Taro verso la famiglia. Sull’autobus di linea, della ditta Carpani, vennero avvicinati da una ragazza, Maria, di Varese Ligure, nota staffetta partigiana che, salita a Pontestrambo, li convinse con le buone e con l’aiuto di una rivoltella a scendere subito alla fermata successiva di Casa Brina. Qui un gruppo di partigiani, che pur legati alla «Centocroci» agivano autonomamente, lontani dalla base; disarmarono e spogliarono di ogni loro avere e dei documenti personali i cinque malcapitati « marò ».
Successivamente, con la scusa di portarli al comando, li incolonnarono sul sentiero che sale verso il monte Torletto, scortati dai partigiani Sabini Andrea (amante della Maria) Nino Siligato e Walter Bruschi. Arrivati su uno spiazzo di una ex carbonaia, Andrea che comandava il gruppo diede ordine al più giovane, Walter, di fucilare i marò quali traditori e sporchi fascisti volontari della Repubblica Sociale. Walter che era ancora un giovane imberbe, venne preso da forte tremore si da far inceppare l’arma automatica. Inesorabilmente, l’esecuzione fu portata a termine da Andrea e Nino. Due altre persone armate di picco e pala dovevano provvedere alla fossa per la sepoltura. Essi agirono frettolosamente perché stanchi e sistemarono i cadaveri in una fossa comune, disponendoli vicino a testa e piedi.
Nella estate del ’44 il comando partigiano della 32° Brig. Garibaldi di Bill venne a conoscenza dei fatti e immediatamente processò i partigiani colpevoli a Masanti: Andrea, Maria e Walter (Nino aveva abbandonato la zona ed era caduto in combattimento). Andrea venne condannato alla fucilazione sentenza eseguita davanti al cimitero di Illica. Maria trovandosi in stato interessante fu salvata per le norme internazionali di Ginevra e Walter ormai disarmato, ebbe salvo la vita perché minorenne e cittadino straniero. L’Avv. Silva con funzioni di Pubblico Ministero, lo ritenne plagiato da Andrea e irretito da Maria. Nell’ottobre del 45, passata la bufera, il parroco di Casale Don Tedaldi Costantino, novello pastore, venne a conoscenza della triste verità sui crudi fatti, aiutato anche da indicazioni di un certo Bastè di Pontestrambo che aveva avuto modo di spiare la combriccola nella tragica notte, accompagnato dal Dr. Squeri, ufficiale sanitario del comune di Tornolo, volle far riesumare i miseri resti dei marò con la cristiana intenzione di restituirli alle loro famiglie. I cadaveri ormai consunti, non avevano però più alcun elemento d’identificazione e solo uno di loro fu riconosciuto per la protesi dentaria, dal fratello e dalla sorella che con un amico erano giunti da Firenze.
Particolare macabro rivelatoci dal parroco, fu che in quel frangente non fu possibile attribuire ad un teschio il relativo corpo in quanto sepolto al centro seduto, poteva essere confuso con quello di altri. I famigliari vollero ad ogni costo caricare in macchina, sotto la loro responsabilità e contro il parere del rappresentante della Amministrazione Comunale, Lusardi Guido, i miseri resti del congiunto. Giunti a Firenze dove allestirono una camera ardente, ebbero notevoli guai compreso l’arresto per trafugamento di cadavere. Tutti i resti degli altri corpi, furono pietosamente ricomposti dalla pia popolazione di Casale e ricevettero onorata sepoltura « come caduti ignoti » in: un unico loculo offerto nella sua cappella gentilizia dal signor Medioli Aidano di Ponte strambo già maresciallo dell’esercito Italiano.
S. STEFANO D’ AVETO – PAESE LIBERO
L’onorevole Carlo Squeri « Venor » di S. Stefano scrive:
« Quando per la prima volta alla luce del sole, nel Giugno del 1944 eravamo scesi a S. Stefano c’eravamo trovati di fronte una popolazione stupefatta ed incredula che non sapeva rendersi conto del come i ribelli potessero essere ragazzi comuni, affatto ineducati, spesso imberbi, soltanto un po’ più bronzei e scalcinati degli altri. Rotto l’incanto, molta fu la cordialità popolare, molte le bottiglie, molti i canti cantati in comune con le comitive spensierate dei giovani eleganti, d’un tratto entusiasmati: nella notte ripartivano per la montagna» omissis . . . « Da allora la Val D’Aveto ha avuto modo di farsi le sue esperienze di guerriglia intrecciate di incubi, di scontri, di rastrellamenti, di distruzioni: è divenuta una valle partigiana anch’essa ma S. Stefano non dimenticherà tanto facilmente i primi partigiani che ha veduti e ospitati: questi erano quelli del Penna ».
Questo alone di simpatia suscitata nei locali fra i giovani « bene» portò inevitabilmente alle prime adesioni al corpo volontari della Libertà. Iniziò lo studente Carlo Fumagalli « Rett » che poi diventerà famoso per la costituzione dei M.A.R. in Valtellina. Era giovane, biondo il padre industriale a Milano aveva mandato la moglie inglese, sfollata in villa a Rapallo, lo stesso nome di battaglia era un diminutivo affettivo, dato dalla madre al rosso « Red ». Amava farsi confezionare divise su misura da un alpino sarto fuggito dalla « Monterosa ». Il modello era costituito da pantaloni alla cavallerizza, non più alla moschettiera, e giacche a vento in telo tenda mimetico a chiare linee fumettistiche, copiate dall’eroe « Gordon »; con spalle larghe e poderose e fianchi esili. Poco dopo lo seguirà Serra Giovanni « Gordon » di nobile famiglia genovese che purtroppo cadrà, assieme a Menoni Vincenzo «Parma» in una trappola per troppa giovanile inesperienza, su azione condotta dallo stesso « Rett ».
Il partigiano Menoni era nato a Reggio Emilia il 14 Giugno 1921, il padre lavorava alla Caproni, quindi il figlio venne chiamato alle armi nell’aeronautica e assegnato alla compagnia di rappresentanza a Roma. Già facente parte del corpo di spedizione in Russia (Armir) rientrò nell’estate del ’43 e l’otto Settembre riuscì a fuggire dall’ aeroporto di Bologna, ormai circondato dai tedeschi. Arrivò a piedi dai suoi a Moletolo, dove trascorre tra una fuga e l’altra, sempre a cavallo della bicicletta, sua passione giovanile, tutto l’inverno. In primavera sente il richiamo della « montagna» e senza rivelare nulla delle sue segrete intenzioni, fa puntate, sempre in bici, a Varano Melegari e S. Andrea: zone che conosceva perfettamente avendovi svolto lavori occasionali prima della guerra. Ai primi di giugno, preleva la rivoltella d’ordinanza del fratello ex ufficiale e con un semplice saluto alla madre, parte la mattina presto in bicicletta per Varano Melegari; quindi a Casanova di Varsi e poi a Bardi da dove alla prima prova del fuoco si unisce all’lstriano. Risale la Valceno e a Volpara entra a far parte del gruppo «Penna» con Gianni Moglia « Scarpa».
Partecipa alla battaglia del Tomarlo a fine Agosto e nel successivo sganciamento anziché seguire il grosso della formazione verso il piacentino, segue «Rett» e « Gordon» verso la Liguria dove i due avevano conoscenze ed amicizie un po’ ovunque. Il giorno 6 Settembre ’44 passata la bufera del rastrellamento, risalgono dietro agli alpini, per rientrare in distaccamento in Valtaro. Nei pressi di Rezzoaglio « Rett », riceve una soffiata secondo cui alcuni alpini desiderano unirsi ai partigiani. Subito decide l’aggancio, che riesce perfettamente con due alpini oriundi di Parma. Mentre sono appostati sulla provinciale passa un altro alpino con un maresciallo, tutti della « Monterosa » e « Ipso facto» i nostri prelevano anche quelli.
Il gruppo così formato lascia la provinciale dopo Rezzoaglio e procede per Brignole su per la comunale oltre il ponte. Davanti è « Gordon » dietro in fila i tre alpini quindi il maresciallo e in fondo «Parma» e « Rett ». Quest’ultimo con il suo modo di fare e la sua continua millanteria da duro, ripete in continuità che i fascisti sono tutte spie e vanno fucilati senza pietà. A un chilometro circa oltre l’abitato il gruppo si ferma per un breve riposo e « Rett » ne approfitta per recarsi, per un bisogno, oltre la siepe, lasciando a terra lo sten. La reazione del maresciallo è immediata, repentinamente prende l’arma incustodita e con una raffica stende il Menoni a lui vicino e spara a Gordon che cade con un colpo in viso. Reagisce a noi favorevolmente anche un alpino che a sua volta spara verso il maresciallo e l’altro alpino in fuga, salvando così il « Rett ». I due alpini che poi rientreranno con noi erano Ottonelli Federico nato a Taranto ma dimorante in Via D’Azeglio che prenderà il nome di « Parma II » per ricordare il caduto Menoni « Parma» compagno di un giorno e l’altro alpino Adorni Jones « Parma I »: Entreranno a par parte tutti e due del distaccamento « Gordon » di nuova formazione in ricordo anche del caduto Serra.

Il cippo ricordo di Menoni Vincenzo ..Parma» e Serra Giovanni ..Gordon» a , Brignole di Rezzoaglio (Genova).
Il fatto per noi fu grave, molti non volevano credere alla versione dei fatti data dal Fumagalli «Rett ». Questa però era l’unica avvalorata da testimonianze e combaciava con quanto poi rilevato sul posto. Il Rett per le sue manie, fu sempre molto chiacchierato: amava la vita comoda, non era portato per i lavori manuali e di corvè. Quando si arrivava in paesi nuovi, la sua prima preoccupazione era di informarsi dove abitava il parroco o il medico o anche la maestra per scroccare un buon letto e ancor meglio un buon « zabaione» ristoratore. Una sua giacca a vento, prestatami una notte che pioveva, era stata accidentalmente trapassata in due punti da una pallottola di rivoltella, mentre mi trovavo con l’amico « Pasquin » a Selvola; la portò subito dall’alpino-sarto, per fargli rammendare i due fori che resteranno trofei a conferma dei suoi racconti avventurosi sul tempo di guerriglia.
Nel dopo guerra mi ricercò assieme ad Ernestino Braga con una inserzione sull’Europeo e all’appuntamento a Milano, ci fece esaminare le bozze di un suo film che aveva intenzione di produrre, sui ragazzi del Penna. Viste le nostre notevoli perplessità, girò ugualmente il film in Valtellina, dove sembra avesse molte amicizie. Il film venne programmato quasi subito, col titolo « Vento di Nord ». Con Ernestino ed altri amici andammo a vederlo al cinema Centrale a Parma e lo trovammo ancora più deludente del previsto.
La parte più impegnativa, di tutto un racconto sconclusionato mai coerente sulla linea politica, fu una carica a cavallo in brughiera-lombarda, dove il « Rett » eroe, appariva in prima fila. In riferimento a quanto riferito dai parenti del compagno « Menoni », che andarono a trovarlo nel dopoguerra, appresi che aveva vendicato la morte del loro congiunto, con una puntata a Collegno, (Torino) dove avrebbe «giustiziato» in famiglia l’ex maresciallo della «Monterosa », vile traditore fascista. Sarà stato vero?
PRELUDIO DI GLORIA – PELOSA ‘44
All’inizio dell’estate del 1944, le formazioni partigiane della nostra zona si ingrossarono notevolmente, a seguito del bando della Repubblica sociale del 25 Maggio, ma principalmente per il favorevole andamento della guerra su tutti i fronti Alleati, quale elemento determinante per una scelta decisiva di tanti giovani. Ormai la lotta partigiana non era più un fatto di bande ribelli armate da controllare con normali azioni di polizia ma veniva posta dal Maresciallo tedesco KesseIring sullo stesso piano della guerra al fronte.
Sarà utile anteporre e ricordare che se la battaglia di Tasola, per Pasqua del ’44, rappresenta il primo vero scontro armato fra partigiani e nazifascisti in Valtaro, le battaglie del Grifola, della Manubiola e di Pelosa passeranno alla storia come i fatti d’arme più cruenti e qualificanti della Resistenza Parmense. Non tanto per la consistenza dei reparti in lotta o per le sbalorditive vittorie ottenute, ma per la efficienza dimostrata dai vari reparti partigiani, per la loro velocità di spostamento da un fronte all’altro, per aver saputo superare le rivalità purtroppo esistenti fra banda e banda, e soprattutto la dimostrata obbedienza al Comando Unico del territorio libero, eretto a Repubblica, con sede in Compiano Capitale. Venerdì 7 luglio 1944, truppe nazi-fasciste salivano verso il passo del Bocco provenienti da Chiavari; dopo aver superato una breve resistenza opposta dal distaccamento di « Fortunin» Serventi Fortunato di Chiesuola (Bedonia) si accamparono sul posto. Fortunin sganciato si senza perdite al Bocco inviò subito una staffetta al comandante « Bill » in Bedonia per chiedere rinforzi con urgenza. L’inviato riportava le sue stesse parole « perché il nemico incalzava senza tregua ed era sempre più numeroso ». Domenica 9 Luglio, abbandonava anche S. Maria avviandosi verso Bedonia. A Pelosa incrociò Bill che saliva in forze e si prese la decisione di attendere in loco, l’arrivo della colonna nemica. Nel pomeriggio arrivò di rincalzo l’ottavo distaccamento Beretta e un gruppo delle Cento Croci. Il tempo scorreva lento, ma tutto sembrava tranquillo, il movimento di staffetta con S. Maria era continuo e frenetico con ripetute segnalazioni ed allarmi. Arrivò la conferma che cinque tedeschi, usciti di pattuglia al Bocco erano rimasti feriti in un’imboscata e venivano rimandati a Chiavari in autoambulanza. Lunedì 10 Luglio alle ore 15 arrivò da S. Maria una staffetta trafelata, annunciando che una colonna nazifascista forte di oltre 200 uomini in perfetto assetto di guerra, aveva occupato il paese e aveva arrestato subito come ostaggi il parroco Don Celso Mori, il medico Dott. Cesare Pighini e un suddito argentino sfollato da Genova.
Il capitano tedesco, che assunse il comando della piazza emise un’ordinanza con cui proibiva il suono delle campane nella chiesa parrocchiale, fece fermare l’orologio, controllare le carte d’identità di tutti gli uomini, reclutando quelli validi dai 18 ai 70 anni onde poter ricostruire, il giorno dopo, il ponte della Malanotte, al confine fra la Provincia di Parma e Genova. Il ponte della Malanotte era stato fatto saltare dai sabotatori del gruppo « Penna» con i due tecnici, già paracadutisti della « Nembo », « Cellini » e il « Gobbo ». Il Capitano installava il suo Comando a Villa Francesconi, con stazione radio, deposito, armeria e cantina-prigione, Il mattino di martedì 11 di buon ora, mentre tutti gli uomini armati di picco e pala, guidati da ufficiali del genio tedesco salivano verso il Bocco per ricostruire il ponte, le truppe nazifasciste, a piedi disposti su due colonne scendevano in fila indiana verso Bedonia, mantenendosi sui bordi dello stradale.
Nel tardo pomeriggio, la donna delle pulizie, che eravamo riusciti a piazzare al comando, tramite il faccendiere-interprete alto atesino, riferisce che a Pelosa i tedeschi erano caduti in un imboscata lasciando sul campo molti morti e prigionieri. A tarda notte ci vengono comunicati dall’interprete, i dati ufficiali trasmessi dallo stesso comando tedesco: 34 morti, 15 prigionieri e un numero quasi doppio di feriti fra cui lo stesso comandante. Di caduti partigiani ne figuravano 3 soltanto. Da fonte partigiana invece si confermò che i morti lasciati sul terreno dai nazifascisti erano più di 80 e i feriti fatti prigionieri e trasferiti al Seminario di Bedonia, attrezzato ad ospedale di fortuna erano, 75. Facendo notare all’interprete alto-atesino, la differenza dei dati sulle perdite in battaglia subite a Pelosa, rimediava dicendo: che i suoi dati riguardavano solo quelli delle truppe regolari germaniche e non tenevano in alcun conto le perdite dei fascisti o « Folk-starm » ad esse aggregate.
Nello scontro di Pelosa cadde eroicamente Serventi Fortunato « Fortunin » comandante del distaccamento; « fregato» come si suol dire, durante il rastrellamento del campo di battaglia. Dopo aver combattuto a lungo per espugnare un nido con mitragliatore « mauser » che ben protetto, insidiava le nostre posizioni, usciva allo scoperto lanciando bombe a mano. Non si avvedeva però che il sottufficiale armiere era soltanto ferito, cosicché a distanza ravvicinata gli riusciva con un’ultima raffica a falciargli le gambe. Fortunin morirà poco dopo per dissanguamento. Oltre a Piazza Fioravante di Cassego Varese Ligure e Pecunia Fino di Rio Maggiore, La Spezia, cadde anche il nostro Ghiorzi Lino di Tarsogno carabiniere vice capo distaccamento della Cento Croci. Fu decorato di medaglia di bronzo al valor militare, con la seguente motivazione:
Nel 40° anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale di Tornolo dedicherà una nuova piazza della natia Tarsogno, per meglio ricordare ai posteri l’eroico caduto. Così la commemorazione nelle parole del Sindaco. « Oggi in occasione del 40° anniversario della Liberazione, ci ritroviamo a commemorare forse il più eroico dei nostri partigiani, il carabiniere GHIORZI LINO classe 1920 capo distaccamento, caduto eroicamente in quella battaglia alla testa di un manipolo di prodi, alla cui memoria verrà assegnata una medaglia di bronzo al valor militare. Vorrei ricordarlo semplicemente come lo conobbi da Maggi nella Marzuola, nell’autunno del ’43 quando imberbe studente diciottenne, guardavo a lui come ad un « vecio » ricco di consigli ed esperienze per la lotta e la resistenza che andavamo a preparare. Pensando a Lui e a tutti i caduti nella lotta per la liberazione d’Italia, vorrei citarvi le parole del Papa, riprendendo una frase del Suo discorso in occasione della S. Pasqua di quest’anno: (1985)
« resistettero, non per opporre violenza a violenza, odio contro odio, ma per affermare un diritto e una libertà per sé e per gli altri, anche per i figli di chi allora era oppressore. Per questo furono martiri ed eroi. Questa fu la loro resistenza».
Le parole del Pontefice non hanno bisogno di commento; lasciamo alle generazioni future e ai giovani di oggi, questo patrimonio di libertà e democrazia che a noi costò tanto sangue e tanti caduti con la sola speranza che ne facciano buon uso, traendone utile insegnamento per il loro futuro avvenire. Nei giorni successivi continuarono ad arrivare rinforzi da tutte le zone limitrofe. Tuttavia era chiaro che poter mantenere le posizioni conquistate, pur salendo sulle alture dominanti: da Setterone a Streppeto ed Alpe, sarebbe stata pura follia, e pertanto venne deciso uno sganciamento generale per arroccarsi su basi più sicure in Val d’Aveto. Il rastrellamento che seguì al combattimento, fu durissimo; guidato dal capitano Mtiller delle SS, già prigioniero dei partigiani a Compiano, fu indirizzato principalmente verso Strela.
Se al Mtiller vanno addebitate molte fucilazioni e incendi fatti eseguire per vendetta a pseudo maltrattamenti o energici interrogatori subiti dai partigiani, non da meno furono altri prigionieri, già concentrati nel ricovero di Compiano e provenienti dalle battaglie di Grifola e della Manubiola. Il Comando del territorio libero, nascosti i feriti nel ricovero si trasferì ai Bigarelli in quel di Tornolo, la sera stessa del 15 Luglio 1944. I tedeschi, fatti prudenti per gli scacchi subiti nei giorni precedenti, in questa prima fase di avvicinamento, procedettero lentamente e soltanto il 18 sera il grosso delle truppe occupò Compiano decretando praticamente la fine del territorio libero.

Il monumento aricordo dei caduti partigiani e civili a seguito della battaglia di Pelosa ‘44
LINO GHIORZI – eroico caduto

Il capo distaccamento Lino Ghiorzi, carabiniere arruolato si nella Brigata « Berretta CentoCroci » medaglia di bronzo al valor militare, immolò la sua giovane esistenza con coraggio e profondo senso di altruismo, spinto nel sublime intento di salvare la vita a un giovane compagno caduto. Postosi alla testa di un pugno di valorosi, combattendo aspramente, contro preponderanti forze nemiche, in una battaglia trionfale per le formazioni partigiane, scriveva il suo nome col sangue, nell’elenco degli eroi più puri, della guerra di Liberazione. Il fatto d’arme ritenuto uno dei più importanti, dal punto di vista militare, tra le battaglie combattute sul nostro Appennino, passerà alla storia col nome della località:
PELOSA Il LUGLIO 1944
Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1956
« Caposquadra già segnalatosi in frequenti circostanze per slancio ed ardimento notevoli nel corso di un duro combattimento contro proponderanti forze germaniche, visto cadere un compagno gravemente ferito, sprezzante del pericolo correva in suo soccorso, ma nel generoso tentativo, cadeva colpito a morte da una raffica di fuoco. Bell’esempio di fraternità e di altruismo» (Pelosa – Bedonia) 10 Luglio 1944 ».
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Roma 16 aprile 1959.
COME S. MARIA VISSE LA BATTAGLIA, DIETRO LE LINEE TEDESCHE
Sul far della sera i tedeschi superstiti tornarono a S. Maria con molti feriti fra i quali il Capitano e obbligarono la popolazione a fornire materassi per l’alloggio dei feriti e delle truppe. Il giorno dopo continuarono ad arrivare rinforzi tedeschi e fascisti che si sistemarono in paese trasformato in un vero quartier generale a ridosso del fronte. Dopo lo smacco subito dai tedeschi ci si attendeva la rappresaglia punitiva che non si fece attendere molto. Tutta la popolazione delle piazze rimasta, fu costretta con modi brutali ad abbandonare le proprie case e radunarsi alla caserma dei carabinieri ribattezzata dai tedeschi « Casa Bianca ».
La furia nemica si sfogava contro quegli innocenti, con continue minacce di morte e accanendosi principalmente contro gli uomini. Ormai per molti era arrivata la certezza della morte vicina, pertanto il 12 luglio fu passato: piangendo e pregando, molti si raccomandavano l’anima a Dio. . I tedeschi in mattinata avevano trasportato i loro morti caduti in combattimento a Pelosa il giorno prima, sistemandoli allineati di fianco alla strada di fronte al cimitero. Nel pomeriggio tutta la popolazione concentrata alla caserma venne fatta uscire e incollonata per due, tutti credevano di andare al martirio, invece sfilarono davanti ai morti denudati o mutilati, riempiendo di orrore, per quella visione macabra, tutti gli animi. Dopo nuove e terribili minacce verso le ore 16 vennero liberate tutte le donne e i bambini e solo verso le ore 20 anche gli uomini che avevano compiuto i sessanta anni di età. La gioia del rientro fu subito messa a dura prova, constatando che nella loro assenza era stato sacheggiato tutto: dalla biancheria ai sopramobili anche di scarso valore.
L’arciprete era stato rinchiuso con il medico e altri tre ostaggi in una stanza, verso sera passò un maresciallo tedesco che disse loro di prepararsi che era giunta la fine. Don Celso confessò i presenti e scorgendo dalla finestra i morti tedeschi, scrissero le ultime volontà e si prepararono alla morte. Il mattino del giorno 13 vennero fatti salire su un autocarro e deportati nel campo di concentramento di Rubbiano nei pressi di Fornovo Taro. Di qui verranno poi trasferiti in altro campo a Bibbiano di Reggio Emilia mentre Don Mori verrà liberato con l’ordine di presentarsi provvisoriamente al Vescovo di Parma e con il divieto, pena la morte di ritornare a S. Maria del Taro.
Tutti gli uomini rastrellati in zona e dichiarati validi al lavoro vennero invece mandati a ricostruire il ponte di Pelosa, utilizzando abeti tagliati nel parco di villa Francesconi. Quando erano esausti e cercavano pretesti per un breve riposo, venivano picchiati a sangue e in molti casi anche obbligati a scavarsi subito la fossa. Da quel giorno 13 luglio si cominciarono a registrare le prime vittime per rappresaglia fra la popolazione civile. Luigi Bottini dei Lazzini venne trovato nascosto lungo il Taro e immediatamente fucilato, Lino Devoti di soli 16 anni prelevato a Varviaro con degli zii verrà fucilato sopra il bosco della chiesa. Luigi Picetti « Ginella » di Scurtabò trovato con molti viveri, sul monte presso le Pietre Bianche, venne portato a Case Fazzi e torturato quindi gli fu fatto scavare la fossa e seppellito ancora vivo che respirava ancora. Lusardi Bartolomeo di Case Belloni venne fucilato nel bosco dove si era nascosto, mentre il figlio Angelo arrestato verrà fucilato al cimitero di S. Maria. Serventi Angelo della Strinata fu bruciato in casa, Longinotti Giovanni e Serventi Angelo di Giuncareggio furono fucilati a Molino Nuovo e De Vincenzi Bartolomeo di Castagnola a Pelosa. La frazione Menta, veniva completamente bruciata, le poche donne rimaste a casa a malapena riuscirono a sottrarre poche masserizie e videro il loro bestiame tutto prelevato dai fascisti.
La colonna barbara salì a Varviaro dove bruciò pure case e cascine quindi salirono verso il monte e piombarono inaspettati a Pianazzo dove uccisero ben sette uomini: i fratelli Angelo e Pietro Chierici il loro cognato Ilari Sante presso la vecchia osteria per ultimo eliminarono anche il figlio Primo di 16 anni perché testimonio di tante barbarie. Al Pianazzo fucilarono ancora i fratelli Longinotti Ernesto e Francesco e Longinotti Antonio portandoli nel praticello del molino dove alcuni fascisti li depredarono anche dei soldi, anelli, orologi e scarpe.
Dopo questa bravata, salirono a Grondana bruciando completamente la frazione Torri e alcune case e cascine della frazione Mazzi. In quei giorni terribili, bruciarono le canoniche di Scurtabò e Cassego, l’albergo del Bocco e la canonica di Streppeto. Bruciò la frazione di Bruschi di Sotto al completo (verrà completamente rifatta nel dopo guerra, dagli Alleati con gli aiuti U.N.R.R.A.). Praticamente i comuni di Bedonia, Compiano e Tornolo ebbero a lamentare la perdita di ben 61 civili fra i quali alcuni sacerdoti. Furono distrutte oltre duecento case, altrettanti cascinali ed asportati ben cinquecento capi di bestiame adulto. Finalmente il 20 luglio i tedeschi lasciarono la nostra zona però si cautelarono il trasferimento deportando come ostaggi diverse decine di uomini A seguito di vari trasferimenti da un campo di concentramento all’altro moltissimi riuscirono a sfuggire e rientrare mentre altri finirono nei lager nazisti senza più ritornare.
Spariti i tedeschi rimasero in paese solo; le squadre dei bravacci neri di Vito Spiotta che a mano libera senza più alcuna autorità depredarono quel poco che era rimasto; Durante una sua visita, resosi conto che ormai si era giunti al limite di ogni umana sopportazione, pensò bene di costituire una commissione di uomini influenti composta dai signori: Flaminio e Cesare Aella, Giacomo Guglielminetti, Cesare Longinotti e Angelo Pessagna. La predetta commissione iniziava a funzionare quando Spiotta ritornò sui suoi passi e nominò Commissario unico con pieni poteri civili, il signor Francesconi. Il 5 agosto i fascisti avendo sentore che erano di nuovo in circolazione gruppi partigiani, abbandonarono S. Maria del Taro permettendo il rientro in famiglia di tante persone sfollate. Il parroco dopo ulteriori vicissitudini subite nella casa del fascio di Chiavari, tristemente famosa per le torture, il 31 agosto riuscì a rientrare in parrocchia con un permesso autografo del maresciallo Kesselring.
Pelosa, 12 Luglio 1974
Parole del Sindaco di Tornolo, espresse a Pelosa in occasione del 30° anniversario della battaglia omonima. « A nome dell’Amministrazione Comunale di Tornolo, porgo il più cordiale benvenuto a tutte le autorità Ass. combattenti partigiani e cittadinanza qui convenute, per celebrare congiuntamente, tra le province di Parma e La Spezia, il trentesimo di quella battaglia che prese il nome di questa ridente località, combattuta da brigate partigiane di diversa astrazione politica, ma unite sotto un unico fulgido ideale di libertà. Questa località, ci deve ricondurre a meditare: – sul sacrificio di tante vite cadute nel nome della patria – sulle ineguagliabili sofferenze che la popolazione locale ha virilmente accettato e degnamente sopportato – sulle deportazioni nei campi di sterminio e di prigionia nazifascista.
La celebrazione odierna, trovi ciascuno di noi nel riverente omaggio ai caduti, idealmente collegati con i grandi sentimenti di libertà che ci animarono nella lunga e vittoriosa lotta di Liberazione; vada quindi riconfermata la volontà unanime di servire con uguale generosità i supremi ideali di libertà nella democrazia, in un clima fattivo di giustizia e di pace interna ed esterna del nostro caro e tanto amato paese.
Viva la Resistenza Viva la Libertà
INDIRETTO RICONOSCIMENTO ALLEATO SULLO « STATO LIBERO DEL T ARO»
Sullo Stato. Libero del Taro con capitale Compiano, già si è detto e scritto molto, pertanto mi limiterò a rievocare un fatto che indirettamente ne conferma il riconoscimento delle Nazioni Alleate, oltre a quello più entusiastico della popolazione locale. Alla fine di giugno 1944 un aereo componente di una pattuglia di caccia americani, in volo di scorta a bombardieri, viene colpito dalla contraerea nel cielo di Cremona. Il pilota JHONNY ANDERSON. di S. Francisco si stacca dal gruppo tenta di rientrare alla base verso Sud, puntando direttamente sul nostro Appennino. Giunto sopra il passo delle Cento Croci si rende conto che l’apparecchio non avrebbe resistito più a lungo, causa il forte vento contrario, così lo abbandona e si getta con il paracadute.
Scende calmo e tranquillo nei prati verdi di Tarsogno. Ai partigiani subito accorsi e meravigliati di tanta sicurezza, mostra una cartina geografica fornitagli dalla R.A.F., nella quale il territorio libero dello Stato del Taro, era stato contornato marcatamente con matita rossa. Tale riconoscimento non venne, per contro, fatto dalla radio e stampa Nazi-fascista. Queste indirettamente e con inaudita crudeltà vollero cancellare lo Stato Libero nel sangue e decretarne la fine con il rastrellamento del 18 luglio 1944. Bedonia fu per la prima volta Comune libero dal 12 giugno al 17 luglio ’44 avendo come Sindaco il sig. Serpagli Luigi.
IL LANCIO DI FINE LUGLIO
ALLA PIANA DEL PRINCIPE AI PIEDI DEL M. TOMARLO
Un messaggio da Radio Londra aveva preannunciato un lancio per la sera di venerdì 21 luglio 1944 sul campo precedentemente segnalato. Si trattava della spianata posta alle pendici del Tomarlo, detta « Piana del Principe », al centro di una zona sotto nostro controllo. La squadra lanci riceve l’ordine di recarsi sul posto il pomeriggio del 21 per raccogliere legna, accatastarla in mucchi posti secondo una preordinata simmetria, allo scopo di delimitare il perimetro utile per il lancio e dare assicurazione ai piloti che il campo era sotto il nostro controllo.
Alla sera verso le dieci vengono accesi i falò e gli addetti alla squadra lanci se ne stanno ai margini della spianata in attesa dell’arrivo dell’aereo. L’attesa si protrae oltre il previsto e rende necessario riattizzare i fuochi. Finalmente dalla direzione del Penna si sente provenire un rombo di aereo, prima lontano poi, man mano, sempre più forte. Il rombo si attenua, l’apparecchio sta rallentando e questo da la certezza che si appresti ad effettuare il lancio. Nella spianata c’è un gran urlare di gioia, tutti gli sguardi rivolti in alto in attesa di vedere scendere i paracadute. Tutto ad un tratto la grande, stupefacente sorpresa: dall’apparecchio, che qualcuno piccandosi competente assicurava essere un B 26 americano, cominciano a partire raffiche di mitragliatrici, le pallottole miagolano sinistramente . . . Dopo un attimo di smarrimento, la squadra lanci corre a ripararsi dietro alcuni massi. L’apparecchio fa una brusca virata per schivare il picco del Monte Martincano, si allontana nella direzione di Genova. Dopo poco inverte la rotta e ritorna sul campo sparando nuovamente con tutte le armi di bordo e lanciando bombe e spezzoni.
Quando qualche sera dopo venne ripetuto il messaggio di conferma del lancio via radio, la squadra lanci predispose le cataste di legna secondo lo schema ma, appena appiccato il fuoco, si ritira fuori dalla spianata dietro sicuri ripari, onde evitare altre sorprese. Comotti Graziano « Nibbio», così chiamato anche in relazione alla scarsissima acutezza della vista, mentre la squadra attendeva l’arrivo dell’ apparecchio, dava sfoggio delle proprie cognizioni di astronomia indicando alcuni bracieri come pianeti: il più grande, secondo lui, era Venere. A un certo punto le dissertazioni astronomiche vennero sommerse da una risata corale, con grande disappunto di Nibbio. . . Finalmente quella fu la sera buona. Invece del cacciabombardiere tedesco arrivò un apparecchio americano che lanciò armi, munizioni, esplosivi, viveri di riserva e il tenente Bob, con la sua missione e radio RT. Ricordo la dicitura di un manuale per le comunicazioni in codice: Walla, Walla – Warning decode only.
Musa Ferdinando “Spartaco”
RASTRELLAMENTO DELL’ AGOSTO 1944
Don Celso Mori racconta:
Il comando tedesco, dopo che ebbe condotto a termine il terribile e feroce rastrellamento del luglio, lasciò alcuni distaccamenti di militari. a Borgo Val di Taro, a Bedonia e al Passo del Bocco per presidiare la zona. Il presidio di Borgo Val di Taro, era addetto in modo speciale alla difesa della linea ferroviaria. A Bedonia vi erano i Bersaglieri e vi rimasero soltanto fino all’Ottobre, essendo poi stati costretti a ritirarsi per i continui attacchi dei partigiani. Il presidio del Passo del Bocco era composto di Alpini della Divisione « Monte Rosa» rientrata da poco dalla Germania, dove era stata formata da militari internati dopo l’otto Settembre 1943 e con le reclute delle classi 1922-23-24-25 mandati in Germania per l’addestramento. Questa divisione venne adibita parte in Liguria per i rastrellamenti e per la difesa della costa e parte sul fronte di guerra della Lunigiana in Apuania. Gli Alpini al Passo del Bocco si erano installati nell’albergo, semidistrutto dal fuoco dell’ultimo rastrellamento e si circondarono di campi minati e di camminamenti, protetti da nidi di mitragliatrici e perfino da un cannone onde difendersi da eventuali attacchi dei partigiani.
Questo presidio rimase fino al 10 Aprile del 1945; era un incubo continuo che gravava sopra S. Maria e che non ci lasciava mai tranquilli, né di giorno né di notte, temendo sempre qualche sortita che tornasse a nostro danno, specialmente dei nostri uomini. I partigiani cercarono di disturbarli, di attaccarli ma non riuscirono mai a farli sloggiare. Ogni volta che gli Alpini venivano attaccati, entrava in funzione il cannone che sparando più di una volta ha colpito le immediate vicinanze di S. Maria. I partigiani intanto nuovamente organizzati si erano accantonati sul monte Penna, al di là del Passo dell’Incisa nella casa della milizia forestale. S. Maria era venuta a trovarsi in una posizione quanto mai critica. Da una parte aveva gli Alpini e dall’altra i partigiani che controllavano tutta la zona al di sotto del Bocco nella Val Taro. Si doveva quindi sottostare agli ordini e alle minacce degli uni e degli altri e sempre con il pericolo di nuove deportazioni e rappresaglie. Questa nostra pericolosa situazione ebbe termine soltanto alla liberazione.
I partigiani non potevano stare inattivi e cercavano sempre di attaccare il nemico, specialmente con atti di sabotaggio delle vie di comunicazione, rendendo sempre più impossibile i movimenti. Il 20 agosto, i partigiani tentarono di far saltare il ponte di Giuncareggio, nella strada Bedonia-S. Maria non riuscendo nell’intento e lasciandolo lesionato in alcune parti. Il mattino dopo, comparve un Tenente dei Bersaglieri, con due sergenti armati fino ai denti, si portarono dal Sig. Avella che fungeva da Commissario in mancanza del Signor Francesconi, facendo chiamare anche l’Arciprete. Il tenente con un modo di fare quanto mai altezzoso e prepotente, intimò alla popolazione di salvaguardare i ponti e la strada, minacciando, qualora questa via di comunicazione fosse distrutta o interrotta, di distruggere col ferro e col fuoco, tutta la zona da S. Maria a Bedonia.
Questa minaccia ci spaventò non poco conoscendo già per dolorosa esperienza le feroci rappresaglie operate in seguito ad atti di sabotaggio. Si cercò quindi di correre ai ripari coll’inviare ai comandi dei partigiani che si trovavano al Penna e a Tarsogno, una petizione, firmata dai capi famiglia, con la quale si chiedeva di non interrompere la strada, per amore di queste popolazioni già troppo duramente provate. L’esito di questa missiva, non fu tanto soddisfacente. Gravando allora sopra di noi la continua minaccia di distruzione, si allestirono rifugi nei quali si nascosero mobili, biancheria e masserizie, conservando in casa le cose più indispensabili. Molti dormivano perfino in terra, avendo posto tutto nei rifugi, chiusi con muri e convenientemente occultati.
Alcuni giorni dopo capitò a S. Maria diretto verso Bedonia, il generale Carloni Comandante della Divisione Alpina, « Monte Rosa» con un largo seguito di ufficiali e militari tedeschi e fascisti. Il generale mandò subito a chiamare l’Arciprete e gli raccomandò di avvertire la popolazione e in modo speciale le donne, di non favorire in alcun modo le diserzioni degli Alpini, perché chiunque si fosse prestato, sarebbe andato soggetto a gravissime sanzioni. Infatti erano moltissimi i militari repubblichini che fuggivano, abbandonando il loro reparto, o per far ritorno alle loro case o se questo non era possibile per unirsi alle bande dei partigiani. Per favorire queste diserzioni i partigiani si servivano delle donne che avevano generalmente il libero passaggio su tutte le strade e che in questi tempi erano loro, invece degli uotipini a viaggiare esercitando tutte il mercato nero. Il 25 agosto aveva inizio un’altra operazione di rastrellamento sul monte Penna, che però non ebbe la portata e le tristi conseguenze di quella del luglio precedente. Come abbiamo già detto, i partigiani si erano organizzati sul monte Penna, da dove facevano molte sortite compiendo atti di sabotaggio nelle zone di Borzonasca e di S. Stefano d’Aveto, nonché nella Val Taro.

s. Maria Taro . Monumento ai caduti partigiani.
Parteciparono a queste operazioni le famose S.S. tedesche e forti contingenti della divisione alpina. L’attacco era condotto da varie direzioni, con provenienza oltre che dalla Val d’Aveto anche dal Passo del Bocco. Il mattino per tempo, arrivò a S. Maria, una compagnia di Alpini con salmerie e si fermarono in paese. Al comparire degli alpini venne dato subito l’allarme e tutti gli uomini fuggirono in tutte le frazioni che credevano sicure.
Intanto da S. Maria assistevano all’avanzata delle truppe addette al rastrellamento che dal Bocco si dirigevano all’Incisa sulla piccola strada aperta dalla milizia forestale, protetti dal cannone che colpiva il Penna e la zona circostante. La superiorità di armi pesanti di cui erano dotate le truppe nazi-fasciste, costrinse i partigiani dopo una breve resistenza, ad una sistematica ritirata. I nazi-fascisti, furono attaccati dai partigiani all’Incisa e al Tomarlo e dopo alcune ore di combattimento i partigiani si ritirarono nel Piacentino, lasciando sul terreno due morti, mentre imprecisate sono state le perdite del nemico. Fortunatamente questo rastrellamento durò poco e gli uomini poterono tornare subito alle loro case, sempre all’erta e pronti a fuggire alla venuta o al passaggio di truppe nazi-fasciste.
RITIRATA DA S. STEFANO D’AVETO
S. Stefano d’Aveto, posto nell’immediato entroterra genovese già prima della guerra centro turistico di rinomata importanza, divenne un naturale rifugio di sfollati. La non comune attrezzatura ricettiva alberghiera: in generale il Grand Hotel « Siva » la colonia estiva della Gil, la villa del console del Brasile, l’altra di Bruno Mussolini, bastano a indicare l’importanza di tale località. Quando noi partigiani, scendemmo in paese, per la prima volta alla luce del giorno, con i primi tepori estivi, si dissolse ben presto quella diffidenza nei nostri confronti che era diffusa tra la popolazione locale.
Ci rendemmo subito conto che dichiarare quella Comunità « territorio libero» era assumerci un compito assai gravoso, non tanto per provvedere per la normale amministrazione locale, quanto per la necessità di assicurare il vettovagliamento giornaliero di ben 2.800 sfollati provenienti da Genova e da tutta la Liguria. Gianni Moglia « Scarpa» nostro comandante ed esperto di amministrazione locale, iniziò subito, emanando bandi e circolari che spaziavano dai prezzi calmierati sul latte, burro e formaggio a disposizioni e norme di P.S. e al transito dei forestieri. Fu reclutato un reparto di 60 muli che facevano la spola verso Bardi e il piacentino per rifornirei del grano necessario alla panificazione locale. Una precisa disciplina alla macellazione, permise di distribuire la carne.
Questo stato di cose venne recepito e approvato un po’ da tutti. Inevitabilmente ci portò anche ad un accordo con i tedeschi della Div. Monterosa di stanza a Rezzoaglio i quali riconoscevano S. Stefano « paese aperto ». Pertanto niente reparti armati, ma solo popolazione civile. In paese ero l’unico partigiano accettato come residente; una pattuglia partigiana, garantiva l’ordine pubblico di notte: arrivava verso le 18 di sera e ripartiva all’alba. Verso le ore 9 del mattino arrivava il cambio con alpini della « Monterosa» guidati da un sergente tedesco, che restavano in paese fino al tardo pomeriggio.
Passavano a ritirare il buono gratuito per il pasto e quando per combinazione mi incrociavano per la strada o incontravano Mario Squeri « Battaglia » che a cavallo, si recava in comune nella sua qualità di Commissario, salutavano militarmente senza alcun patema d’animo e con la massima naturalezza. Questo stato di cose, in un’atmosfera eccezionalmente idilliaca, per una guerriglia in atto, durò fino al 26 agosto, allorché cominciarono puntate con scontri cruenti prima all’Incisa sul M. Penna e poi su alle rocce del M. Tomarlo. I partigiani dopo un combattimento, in cui lasciarono sul terreno due caduti: Fortunato Lionardo da Marsala e Zacconelli Giovanni da Ferrara, si ritirarono verso il piacentino. In conseguenza di queste puntate, fatte apposta per sondare le nostre posizioni, la situazione precipitava. Il maresciallo Graziani in persona giungeva inaspettato a Rezzoaglio, annullava tutti gli accordi precedenti e fatte affluire tutte le forze disponibili in Liguria, iniziava l’ennesimo rastrellamento, partendo dalla Val d’Aveto.
Nel pieno della notte la famiglia Monteverdi dell’albergo « Leon d’Oro », dove ero alloggiato, mi svegliava avvertendomi che gli alpini stavano circondando il paese. Poiché ero impossibilitato a camminare a piedi, per la gamba che era ancora ingessata, mi sellarono il cavallo del quale ebbero cura di fasciare gli zoccoli. Accompagnato da uno dei figli minori che teneva il cavallo alla briglia, seguii il corso del canale e potei venire così, fuori dal paese, non visto. Procedendo, molto lentamente, alla chetichella, passammo sotto il naso del nemico e il sole del mattino ci trovò già sull’altopiano di Torio fuori accerchiamento. Dietro in basso potevamo osservare S. Stefano rigurgitare di truppe in ogni angolo. Ogni tanto giungevano fino a noi l’eco di lugubri spari. Ricordo che per facilitare la mia fuga, avevo abbandonato nel prato di trifoglio, fra il Leon d’Oro e la Chiesa, una bomba a mano da sabotatore del tipo « Signorina» in calza-maglia nera, ripiena di gr. 700 di dinamite plastica. Al pomeriggio gli alpini la ritrovarono e non conoscendone il tipo e la sostanza, cominciarono a calciarla come fosse stato un rudimentale pallone. Le continue percussioni, ruppero il piccolo contenitore in plastica del detonatore, che colpito in pieno deflagrò maciullando la gamba destra di un imprudente alpino e ferendone almeno altri tre.
In serata a Torio, arrivarono anche i reduci dalla battaglia del Tomarlo tra i quali con mio grande sollievo ritrovai gli amici di Tornolo « Miccia » e « Quadrato ». Di comune accordo, decidemmo di stare uniti noi tre e tentare di effettuare uno sganciamento tattico, per passare nel piacentino verso Selva di Gambero quindi a Pertuso e Rompeggio. Pernottammo nuovamente nella faggeta del M. Zovallo e non sentendo più spari, ritornammo in Valceno per rientrare alla spicciolata in famiglia. Nei giorni successivi, dopo un doveroso riposo e trascorsa in pace la festa della Madonna del Faggio, mi accordai con Zanelli Roberto « Miccia» col quale decidemmo di ritornare a Volpara per recuperare oggetti personali ed armi, che tenevamo nascoste presso i miei bisnonni. Nel frattempo Mantegari Paolo « Quadrato » un po’ sfiduciato e pressato dalla famiglia, ci lasciava per ritornare al duro lavoro dei campi; rientrerà in squadra solo alla vigilia della discesa vittoriosa verso la pianura. A Volpara dove non mi avevano più visto dal tempo in cui ero rimasto ferito, trovammo una calorosa accoglienza allietata da brindisi continui fino alle ore piccole. Stavamo per addormentarci in un provvidenziale letto, quando la « Mainin di Duri» ci chiamò, bussando sommessamente alla porta: «ci sono gli alpini, fuggite! ». Alcuni muli erano già nel piazzale davanti l’osteria, allora saltammo dalla finestra sul retro, calandoci nel bel mezzo di una piantata di fagioli con armi e bagagli e cercammo a carponi di allontanarci.
Tutto sembrò andare liscio fino a quando arrivati in fondo presso la cascina sulla strada, il culo di « Miccia» fece trombetta, mentre lui lanciava secca una « giaculatoria » che fece voltare due alpini. Credendolo uno di loro intento ad un impellente bisogno, gli gridarono in dialetto lombardo « Purgot ». Era successo che « Miccia» strisciando al buio era finito in mezzo a un cespuglio più folto ma di ortiche. Più tardi ormai lontani e fuori pericolo guardavo ridendo l’amico che era divenuto rosso come non mai e nella sua, esuberante indole; aveva acquistato una faccia tutta fuoco, che se non fosse stato per la presenza di piccoli puntini bianchi, avrebbe dato l’impressione di una improvvisa scottatura solare.
Fra i rastrellatori la presenza dei primi Mongoli 31 1uglio’44
Da qualche giorno si era sparsa la voce che truppe tedesche e mongoli si trovavano nei pressi di Cornolo. Nella vallata del Ceno non si era ancora visto nessuno. La mattina del 31 luglio, dopo la celebrazione della Messa li trovavo con Marco, Pedrin, Silvio e l’ingegnere Mangiante nella piazzetta di Sante quando improvvisamente si sentono degli spari che abbiamo riconosciuto per colpi di moschetto, seguiti da raffiche di mitra. In un primo tempo si pensava che fossero colpi sparati da partigiani nelle loro esercitazioni. I presenti si lamentavano della imprudenza dei partigiani avendo a così breve distanza truppe tedesche, quando arriva di corsa e tutto trafelato Antonio Moglia (Putareu), che, esterrefatto, grida: – Arrivano i tedeschi. Sono vicini a casa mia.
La nuova recata e la sua faccia spaventò tutti i presenti. Le donne si ritirarono in casa coi bambini, i giovani con me fuggirono in direzione del poco lontano bosco di castagni. Era la prima volta che mi allontanavo dalla parrocchia durante un’incursione, ed è stata l’ultima. Per giungere a detto bosco si doveva attraversare un tratto di terreno erboso e scoperto. Ci infilammo per il sentiero. Appena fummo allo scoperto, si sentirono di nuovo le ,raffiche. Raffiche che erano dirette a noi. Marco mi precedeva nella corsa. Ad un certo punto Marco inciampò e cadde, lo aiutai a rialzarsi e si riprese la corsa. Appena entrammo nel bosco, e quindi ci rendemmo invisibili a chi tirava verso di noi dal versante di Casalporino, un nugolo di foglie tagliuzzate ci investì. Chi aveva mirato a noi aveva alzato troppo il tiro. Sostammo un istante dietro un grosso castagno per prendere fiato, ed io chiesi a Marco se si fosse fatto male quando era inciampato. Egli, per tutta risposta, si chinò per guardarsi la scarpa destra. Aveva il tacco trapassato da parte a parte da una pallottola di mitra.
Alla vista dello scampato pericolo, ci separammo. Con l’ingegnere e con Marco mi recai alle Galere dove si erano rifugiati i fratelli Bosco con le famiglie. Giunti là mi invitarono a nascondermi nel loro rifugio sotterraneo, ma per la corsa compiuta, ho avuto l’impressione che lo restare chiuso mi togliesse il respiro, per cui mi rifugiai di corsa nella vicina faggeta. Rimasi lontano da casa fino a circa le quattro del pomeriggio; quando il papà di Silvio mi rintracciò e mi avvertì che i pochi fascisti e mongoli del mattino si erano accontentati di raccattare pane, salume, polli, vino e così carichi ripartire.
Quando rientrai in casa, seppi che i pochi fascisti di quella incursione, entrando in canonica, con le armi spianate, avevano spaventato parecchio le donne coi bambini per il loro parlare ed agire minaccioso e per il modo con cui cercavano dappertutto il prete che dicevano di volere portare via. I miei ospiti temevano più per me che per loro stessi, perché non mi avevano visto quando ero fuggito con i miei amici. Quindi non sapevano dove fossi. Gli… invasori hanno rovistato la canonica da cima a fondo, buttarono all’aria anche quanto c’era in cantina, ma non trovarono altro che un po’ di commestibili che portarono con sé nel partire. Per fortuna che non riuscirono a trovare le ormai poche bottiglie di vino, di cui mi servivo per la S. Messa. Nel loro giungere ad Anzola i fascisti avevano colpito con una raffica ad una gamba Federici Pietro che non si era fermato alla loro intimazione. Il Federici rimase per molto, degente a letto, e la gamba gli rimase diritta.
Mons. Paolo Checchi l’instancabile
Rimasto in tutta la vallata con la sola compagnia del Parroco di Calice, Don Clemente Boccardo, ormai anziano e gracile di salute, sentivo la necessità di potermi intrattenere con qualche altro confratello. In certe circostanze come si apprezza la vicinanza di un Confratello, se non altro per potersi vicendevolmente confortare ed incoraggiare! Quale non è stata la mia sorpresa e la mia gioia quando un giorno (non ricordo la data), sentii bussare alla porta della mia canonica e mi si presentò davanti la figura alta e paterna di Mons. Paolo Checchi, arciprete di Bedonia. Davanti a questa apparizione rimasi senza parola, mi sembrava un secolo di non avere visto il mio venerando Monsignore. In quel momento capii quanto avevo desiderato vederlo e intrattenermi con lui. Non ebbi alcuna esitazione, perché in quel momento non vedevo davanti a me un superiore, ma un padre, e mi buttai al suo collo e lo baciai come se fosse stato il mio amico più caro che da tempo non rivedevo.
Il caro Monsignore mi ha ricambiato paternamente l’abbraccio ed il bacio. Così stretti l’uno all’altro scoppiai in lagrime. Anche ora ripensando a quell’incontro, provo di nuovo la stessa profonda emozione! Quanto conforto mi ha recato quell’incontro! Monsignore si trattenne poche ore; era venuto per sapere come andavano le cose nelle nostre parrocchie, mi chiese dei partigiani e volle sapere i particolari della morte di Peppino Galli. Lo presentai ai miei ospiti che lo salutarono cordialmente ed a cui rivolse parole di incoraggiamento e di conforto. Quando uscì di canonica, trovò nel sagrato della chiesa un gruppo di persone con cui si intrattenne, indi ripartì con una persona (non ricordo chi) che l’aveva accompagnato.
Don Agostino Viviani capitano degli alpini 1915/18 Cappellano partigiano Div. Bisagno
Bombardamento di Drusco
L’arciprete di Drusco, Don Agostino Viviani, aveva accettato l’impegno di cappellano della Divisione Bisagno nel genovesato, per cui rimase per molto tempo lontano dalla parrocchia, dove faceva solo qualche capatina. Il Parroco di Romezzano, Don Rocco, poco coraggioso, dopo il trattamento che aveva avuto dai fascisti in un drammatico rastrellamento, non si muoveva mai dal paese. Don Luigi Pilla, parroco di Casalporino, alle prime avvisaglie del pericolo che portava la presenza dei ribelli nella zona, un giorno mi pregò di assumermi la cura della sua parrocchia, perché doveva andare a Piacenza per farsi operare di appendicite, ed il giorno dopo partì. Non lo si vide più in zona se non dopo parecchi mesi dalla fine della guerra per il trasporto del suo mobilio alla parrocchia di Trebecco, a cui nel frattempo era stato assegnato come parroco.
A sostituirlo, in seguito, venne come parroco, Don Davide Monteverdi, nativo di Romezzano, sacerdote ordinato durante la guerra. Questo giovane sacerdote si è prestato durante il conflitto con abnegazione, generosità e sprezzo del pericolo. Durante l’assenza dei parroci sopradetti avvenne un fatto che portò morti, feriti e rovine a Drusco. Il 5 agosto 1944 a Volpara, frazione di Casalporino, che avevo avuto in consegna da Don Pilla, si doveva celebrare la festa della Madonna della Neve. Mi dovevo trovare sul posto per la S. Messa e per la processione con la statua della Madonna alle ore 11. Alle ore 8 circa mi trovavo nel piazzale della chiesa di Chiesiola col piccolo Eugenio, quando vidi spuntare nel cielo dalla direzione di Bardi una formazione di aerei, che si dirigeva nella direzione del monte Tomarlo.
Il fatto non mi ha impressionato perché simili formazioni solcavano spesso il cielo allora. Quando però la formazione sorvolò l’abitato di Drusco scorsi gli apparecchi lasciare cadere qualcosa. A questo gesto seguirono rombi e scoppi nell’abitato di Drusco e lungo tutto il percorso fino a Volpara, che non era visibile da Chiesiola, e ivi cessarono. Gli aerei quindi si perdettero in direzione del monte Tomarlo. A quella vista, con l’ingegnere che era uscito precipitosamente di casa, comprendemmo che il disastro che era successo richiedeva il nostro aiuto. Pensai subito a Volpara che dava l’impressione di essere stata l’ultimo obiettivo centrato dal bombardamento. Mi misi di corsa nella direzione di detta frazione con l’ingegnere e Marco Moglia. Volpara non era stata colpita. La bomba che credevo destinata a detta località era scoppiata a circa un chilometro di distanza tra Volpara e Selvola. Essa aveva aperto sulla strada che unisce le due frazioni un cratere di circa venti metri di diametro, ma non aveva recato danno, perché il punto colpito era deserto.
Di corsa con l’ingegnere e Marco ci recammo a Drusco. La vista del paese ci fece una profonda impressione! Case sventrate, lamenti, e grida da tutte le parti. Chiesi se vi erano dei feriti o dei morti e dove fossero. Mi venne indicato un ferito adagiato in un fienile. Una scheggia gli aveva fratturato una gamba ed un braccio. Cercammo di adagiarlo nella posizione più comoda possibile, ma non volle essere rimosso per i dolori che gli procuravamo col solo toccarlo. Cercai di confortarlo promettendogli di portare presso di lui il dottore, con la speranza di trovarlo. Mi recai presso una famiglia dove un anziano era morto in seguito allo spostamento d’aria. Era ammalato di cuore. Benedii la salma e cercai di confortare la vedova ed i figli. Mi recai quindi nella casa di Musa Luigi di Anzola, che si era portato nella sua casetta di Drusco nella speranza di essere più al sicuro che nella sua villetta di Anzola. Egli era gravemente ferito in diverse parti del corpo da schegge di bombe. Il dottor Squeri Angelo stava curandolo. Una volta ritiratosi, il dottore crollò il capo esclamando: Oltre che per le ferite riportate questo ferito è in condizioni gravissime perché ha già il diabete.
Cercai di confortare il buon Luigi e gli impartii la benedizione degli infermi. Uscendo da questa casa incontrai Don Clemente Boccardo, parroco di Calice, che, benché anziano e malaticcio, cercava di supplire don Viviani assente. Gli dissi che desideravo andare verso la chiesa parrocchiale per celebrare la S. Messa che quel giorno avrei dovuto celebrare a Volpara per la festa della Madonna della Neve. Nell’andare verso la parrocchiale incontrai l’allora chierico Monteverdi Davide e lo pregai di seguirmi per servirmi la S. Messa. Entrammo in chiesa. Lo stato della chiesa era come quello del paese!
I banchi ricoperti di calcinacci e di rottami di vetri, di cui neppure uno era rimasto intatto. Pulimmo a qualche modo l’altare e celebrai la Messa per i poveri parrocchiani di Drusco. Col giovane Monteverdi visitai ancora il Musa ed il ferito ricoverato nel fienile dove accompagnai il buon dottor Squeri. Dopo essermi accordato con don Clemente che si trovava presso la salma del morto, per il servizio della parrocchia, ritornai a Chiesiola con l’ingegnere e con Moglia Marco. Il Musa Luigi, ferito gravemente, è morto il giorno dopo, assistito da don Clemente e se ne sono celebrate le esequie a Drusco.
Arrivo in Italia Div Monterosa primi presidii fascisti. Rastrellamento 25 agosto ’44
In canonica durante questo periodo si viveva tranquilli. Tranquilli, si capisce, fra partigiani armati, con qualche lancio e con l’eterno incerto di vedersi capitare in casa bocche affamate (partigiane, tedesche e fasciste) oltre il numero previsto, a cui non solo la carità imponeva di provvedere a sfamare. Ci si trovava in queste condizioni quando un giorno, il 25 agosto 1944, giunse la nuova che alcune compagnie di fascisti sarebbero arrivati per compiere un rastrellamento. Era il tempo in cui Scarpa era intendente e Bill il comandante della Brigata. Nella mia Parrocchia, e precisamente nella frazioncina denominata «Montà» abitava la moglie di Scarpa: Moglia Rina con i due figli: Gabriella e Giuseppe, questo ultimo di pochi mesi.
Giunsero in paese le truppe dei fascisti che si accamparono in alcune case. Si accamparono anche ad Anzola, a Fornolo ed a Casalporino. Una volta insediatisi nelle case e nelle cascine, di fatto non fecero nulla; di giorno gli ufficiali chiacchieravano del più e del meno, e verso sera, stendevano uno sbarramento attraverso le strade pel timore di un assalto notturno da parte dei partigiani. In canonica non era alloggiato nessuno, ma, di giorno, venivano per mangiare, un tenente della Milizia, un medico e qualche volta un sergente ed un caporale. Il tenente era giovane e bontempone. Dava l’impressione di aver preso la vita militare come un diversivo pieno di avventure.
Il medico, di 36 anni, era un uomo serio, che, tra l’altro, a Tarsogno, era stato fatto prigioniero dai partigiani della nostra vallata, e durante la prigionia era stato trattato bene, anche secondo le sue stesse asserzioni. Era stato trattato tanto bene e con confidenza (e forse con meno prudenza) che mangiava addirittura con il comandante ed i capisquadra. Il secondo giorno (si sono fermati tre giorni) mi trovavo nella mia cucina, quando il tenente-medico mi si presentò per parlare del più e del meno. Mi sono detto: – Attento! Costui vorrà senz’altro, assaggiare il terreno, perché è il più serio ed il più taciturno di tutti. Infatti ad un certo punto mi chiede candidamente: – La Montà è molto lontana da Chiesiola? Dissi fra me e me: Ecco, ci siamo; e risposi: – Non conosco nessuna parrocchia che porti questo nome!
Ed era infatti vero. Egli portò quindi lontano il discorso, parlando dei partigiani, della sua prigionia ed infine mi buttò lì un’altra domanda: – Lei, reverendo, conosce la moglie di Scarpa? Con franchezza risposi: – So che Scarpa è sposato! Dopo questa mia risposta, la conversazione venne interrotta dal caporale che venne a chiamare il mio interlocutore. Mi accorsi di avere in casa uno che conosceva troppe cose e avrebbe potuto mettermi nei pasticci, perciò mi proposi di stare molto attento.
Verso sera, dopo la cena, prima che si ritirasse in una casa vicina per riposarsi, mentre mi trovavo ancora nella mia cucina da solo, con la scusa di venire a darmi la buona notte, ecco di nuovo il medico. Desiderava fare due chiacchiere con me, non avendomi visto con la famiglia dei miei sfollati. Di nuovo entrò nell’argomento trattato durante il giorno. Parlò ancora della moglie di Scarpa, e, ad un certo punto mi disse: – Reverendo, oggi lei mi ha detto di non conoscere la moglie di Scarpa, ma, badi, credo sia meno male conoscere la moglie di Scarpa, che farla passare per una sfollata e darle vitto e alloggio.
Capii quel che voleva dire, e anziché impressionarmi, scoppiai in una sonora risata e risposi: – Scusi, dottore, credo che lei abbia preso un granchio fenomenale. Vorrebbe forse insinuare che la famiglia a cui ho dato ospitalità sia la famiglia di Scarpa? Certo lei non mi conosce. Le assicuro che non sarei tanto imprudente da arrivare al punto di dare ospitalità alla moglie di Scarpa e tenerla in casa in compagnia di chi cerca con tanto accanimento Scarpa stesso. Le posso assicurare che nessuno della famiglia Scarpa si trova in casa mia. A questa mia affermazione così chiara e tranquilla, cambiò argomento.
Intanto nella cucina dei Mangiante si sentiva il caporale che sembrava discutesse con un tono di voce piuttosto alto. Il dottore si alzò e scusandosi, fece l’atto di uscire. Lo seguii. Giunti nella cucina degli sfollati, trovammo il caporale che con la signora stava discutendo su un detto del Duce. Egli sosteneva che la frase in questione era: DIO, PATRIA, FAMIGLIA, mentre la signora sosteneva che fosse: DIO, FAMIGLIA, PATRIA! Ne uscì una discussione in cui il caporale, siciliano, non dimostrò un grande riguardo ed affetto per la propria famiglia. Anzi ad un certo punto uscì in un’asserzione che suscitò la reazione dei due ufficiali e di tutti i presenti. Disse che se il suo stesso padre fosse stato di idee differenti da quelle del Duce, non avrebbe avuto esitazione a parteggiare per il Duce contro il proprio padre.
La conversazione continuò per un po’ ancora, poi ci ritirammo per dormire. Il giorno dopo era giorno di partenza per i fascisti. E speravo di non avere noie per le idee del tenente-medico, non tanto per me, quanto per la famiglia di Scarpa ed eventualmente per tutto il paese. Il mattino non vidi in circolazione il tenente-medico. La cosa non mi preoccupò, perché era già successo anche gli altri giorni un fatto simile. . A pranzo il tenente ci avvertì che sarebbero partiti subito dopo. Infatti i militi si erano riuniti nel piazzale della chiesa ad attendere il segnale di partenza. Terminato il pranzo ci salutò. Quando il tenente-medico mi si avvicinò per salutarmi, si chinò e mi disse quasi sottovoce:
– Reverendo, ora so chi è la moglie di Scarpa. Mi scusi del granchio che ho preso ieri. La moglie di Scarpa è più giovane della signora Mangiante, ed i due figli sono una femmina ed un maschio, e non due maschi. Non tema per loro. Non mi voglio mostrare ingrato per il trattamento che ho avuto da Scarpa durante la mia prigionia. Rimasi di stucco a queste parole; ci demmo una forte stretta di mano e ci separammo. Seppi poi, più tardi, che questo tenente-medico è caduto in un’imboscata tesa dai partigiani alla sua compagnia in un successivo rastrellamento. Durante questo rastrellamento avvenne un fatterello, potremmo dire insignificante in sé, ma che mise in grave pericolo la vita dei miei ospiti, e forse anche la mia. Come ho detto, il tenente-medico aveva preso confidenza con gli sfollati della mia canonica. Era ovvio che l’ingegnere non fosse presente. Per noi era nelle Galere coi signori Bosco, ricoverati in un rifugio ricavato in una cascina; per quelli che chiedevano di lui, specie per i tedeschi ed i fascisti, si trovava a Lavagna per lavori ordinatigli dal governo del tempo.
La mattina del secondo giorno, il tenente-medico si mise a chiacchierare col piccolo Eugenio, un bambino di tre anni, che prendeva confidenza con chiunque gli si avvicinava. I due si misero a parlare del più e del meno; mi trovavo presente, per caso con la Giuseppina, la bambinaia. . Eugenio si era dimenticato di quanto gli avevano raccomandato i genitori e la donna di servizio: – Non parlare coi fascisti e coi tedeschi delle cose di famiglia. Ad un certo punto il tenente-medico fece cadere il discorso sull’ingegnere, e chiese al piccolo: – Dove si trova ora il babbo? Il bambino, con la spontaneità e la schiettezza propria del la sua età, rispose con prontezza: – È nella Galere!
La bambinaia, ascoltando il colloquio e non avendo potuto evitarlo, intuì il pericolo della risposta di Eugenio, per cui, interpretando la espressione di incomprensione della faccia del tenente, rispose: – Galere è una località presso Lavagna, dove il signor ingegnere ha una casetta di campagna. Indi chiamò il piccolo con la scusa di ripulirgli le scarpette e lo condusse fuori. Temevo che il tenente ritornasse sull’argomento, invece non ne fece più parola per tutta la durata del rastrellamento. L’accortezza e la prontezza della buona Giuseppina evitò che succedesse un fatto molto spiacevole e pericoloso.
Don Domenico Dallacasa «Dado»
Dalla scuola di Tarsogno Paola Bronzini racconta:
LA CATTURA DEGLI ALPINI
Gli alpini stavano venendo a Tarsogno per fare la spesa, quando i partigiani li presero prigionieri. Al battaglione di Cento Croci, quando si accorsero che i loro compagni erano stati catturati, vennero a Tarsogno in fila indiana, presero della gente in ostaggio e tutta la sera spararono contro il campanile, credendo che i partigiani si fossero nascosti lì. Quella sera mio nonno era andato alla Breva a fare la spesa; mentre veniva a casa incontrò la Polonia che gli disse: «Un ti vé? » « Vo a cà » rispose. « Anei indré, perché ighen i alpini che i piéna a gente in ostaggio» disse lei (1). (1) « Dove vai? » « Vado a casa». « Andate indietro, perché ci sono gli alpini che prendono la gente in ostaggio ». Riportiamo inoltre come il fatto fu riassunto dall’On. 1e Carlo Squeri « Venor » nel suo volume « Quelli del Penna »: « Il distaccamento Turco si portava a Tarsogno dove prelevava dopo breve sparatoria un tenente medico, una squadra di alpini con due muli e una carretta. Intensa la reazione di artiglieria che continuava nella notte a far fuoco con pezzi da 75/13 ».
AZIONE DI SABOTAGGIO E SCAMBIO PRIGIONIERI
Venerdì 29 settembre, sempre con la squadra sabotatori, guidata dai paracadutisti della Nembo « Cellini » e « Gobbo» già facenti parte della missione del Capitano Bernini, partiamo per Setterone e di qui saliamo a Casonetti, una frazioncina isolata e dominante sulla Val Taro, posta a perpendicolo su Pelosa. Il compito assegnato, era quello di distruggere nuovamente il ponte, fatto ricostruire agli abitanti, dal genio-militare tedesco, utilizzando grossi tronchi di abeti tagliati a villa Francesconi di S. Maria Taro e con un impalcato di tavoloni prelevati in un grosso cantiere di Chi avari.
L’intenzione nostra era quella di bruciarlo. Avevamo solo due bombe incendiarie. La popolazione locale venuta a conoscenza delle nostre intenzioni; ci offriva da mangiare a volontà, purché si ritornasse sui nostri passi, lasciando stare le cose come stavano, nel timore che l’azione scatenasse nuovamente la reazione della furia tedesca, momentaneamente assopita. Si viveva quella atmosfera di tensione in attesa del buio, finché Cellini rotto l’indugio, faceva uscire dalla stalla un paio di buoi e con questi e l’aiuto di alcuni civili più ardimentosi, faceva trasferire sotto il ponte, due pagliai completi. Si accese subito un bel falò, sull’impalcato vengono sganciate le due bombe. La vallata illuminata a giorno, ha come un risveglio; tutta la popolazione, compresi donne e bambini, corre armata di attrezzi agricoli e si scaglia contro le impalcature del ponte, con il solo intento di strappare alle fiamme, qualche tronco o qualche asse.
In questo modo ciò che non fece il fuoco fu portato a termine dai civili così che a mezzanotte l’operazione era completamente riuscita, sul posto restavano solo ceppi fumanti. In quei giorni il tenente Collini, ansioso di vendetta, per lo smacco subito a Tarsogno, scendeva improvvisamente a Bedonia e prelevava il partigiano Berni « Lagardeur » che funzionava da capopiazza della polizia partigiana. Legato come un salame e caricato sulla solita moto carrozzetta questi veniva trasportato a Cento Croci dove era sottoposto ad estenuanti interrogatori. L’ambiente bedoniese rimase in subbuglio, si diffondeva il timore che i fascisti riuscissero a far parlare il Berni, che era (informatissimo su tutto il movimento partigiano locale) mentre Spiotta da Chiavari reclamava il prigioniero.
Era giocoforza ricorrere, per l’ennesima volta all’intervento di Mons. Checchi, onde avviare le trattative per uno scambio di prigionieri; da parte nostra si -poteva offrire il tenente medico. Le trattative ebbero buon fine; mentre agli alpini che non volevano rientrare, venne richiesto una dichiarazione scritta atte stante di aver scelto volontariamente l’arruolamento nel corpo dei partigiani. Il sergente Confortini e il caporale Pasqualini, timorosi di rappresaglie verso i famigliari, aderirono contro voglia, allo scambio, impegnandosi segretamente con noi a disertare successivamente. Rientrati a Centocroci, il comandante tenente Collini forse subodorando qualche cosa, li fece trasferire all’altra Compagnia dislocata a S. Pietro in Vara, sotto il comando del tenente Campanini.
Il 12 ottobre 1944 un folto gruppo di 60 alpini della « Monterosa » guidati dal nostro sergente e accompagnati da una staffetta locale si presentarono ai partigiani della « Berretta Centocroci » a Montegroppo di Albareto,aderendo al corpo volontari della libertà. Raccontarono di essere fuggiti, come da accordi verbali presi in precedenza, ma non potendo portare con loro armi pesanti, come promesso, preferirono renderle inservibili prima di disertare. Inutile dire che furono accolti con indicibile e caloroso entusiasmo da tutti i nostri. Il tenente Campanini, tramite il parroco di Varese Ligure, scrisse ai due responsabili della diserzione, minacciando la fucilazione dei loro genitori se non fossero rientrati al corpo entro 48 ore, però la missiva non fu mai recapitata. Il parroco si giustificò dicendo di non essere riuscito a trovare dove gli alpini si erano rifugiati, anzi suggerì che molto probabilmente erano ritornati in Valceno con i partigiani di Bill che già avevano conosciuto in precedenza durante la loro cattura e conseguente scambio dei prigionieri.
La cosa non garbò molto e per tutta risposta fu fucilato la staffetta di S. Pietro in Vara che aveva fatto da « trait-union » per la fuga. Il fatto della diserzione generale dalla Monterosa, preoccupò notevolmente i vari comandanti che diedero incarico allo stesso parroco di Varese Ligure Don Olivieri e a Don Bobbio di Valletti di stabilire un incontro con il comando partigiano a Torza in campo neutrale, onde concordare un « modus-vivendi » fra le parti contendenti. All’incontro di Torza erano presenti per la « Berretta-Centocroci » il
Commissario politico Benedetto e il Dr Roberto Berté; per gli alpini della Monterosa il Tenente colonnello Chierici e il Tenente Bernardi di stanza a Velva. Come moderatori dell’incontro i parroci Don Olivieri e Don Bobbio. Se in quel momento ci fosse stata più determinazione decisionale da parte nostra, molto probabilmente si sarebbe potuto concludere una diserzione in massa, di buona parte della divisione « Monterosa ». Era evidente che il Tenente colonnello Chierici stava attraversando una profonda crisi morale e spirituale, invitò i due sacerdoti plenipotenziari alla mensa degli ufficiali, presso il suo comando di Velva. Successivamente Don Bobbio riprese le trattative separatamente e convinse il Colonnello che era possibile una soluzione pacifica passando tutti con armi e bagagli alle forze partigiane.
Da parte sua garantiva che i reparti non sarebbero stati smembrati ma integrati e che sarebbe stata mantenuta la stessa gerarchia di comando già esistente nella « Monterosa ». Il Chierici fu talmente convinto della cosa che in un attimo di completa disponibilità consegnò a Don Bobbio anche il suo diario spirituale, dimostrando la sua buona fede di cristiano e fervente cattolico. Tutti gli Ufficiali presenti, aderirono spontaneamente all’accordo preso, anzi si offrirono subitamente di scendere da Velva con lui e passare alle forze patriottiche. . Don Bobbio, probabilmente impressionato da questa resa incondizionata, che era andata oltre alle sue deleghe e ad ogni umana previsione, chiese il tempo di poter riferire al più presto al nostro comando e raccomandò a tutti di attendere una sua ulteriore comunicazione.
Purtroppo però il ritardo portò a debita conoscenza dèi superiori i patteggiamenti di Velva. Venne decretato un subitaneo rastrellamento con uccisioni, vandalismi e deportazioni, lo stesso Don Bobbio picchiato a sangue prelevato dai fascisti verrà poi fucilato a Chiavari come partigiano ribelle. Ho voluto dilungarmi, su questo episodio forse di scarso interesse bellico, per completare le citazioni di Don Domenico della Casa che nel suo diario nomina fra i rastrellatori della « Monterosa » un Tenente medico che molto bene conosceva i paesi della Valceno e i nomi dei comandanti partigiani locali, perché già prigioniero dei partigiani a Selvola e poi ostaggio di scambio in Bedonia tramite mons. Checchi.
Dal volume « QUELLI DEL PENNA» di Carlo Squeri stralciamo:
Il giorno 4 ottobre una pattuglia del distaccamento Orlando catturava nell’interno dell’abitato di S. Stefano d’Aveto presidiato dalla Monte Rosa una pattuglia alpina armata al completo. Il giorno 11 una pattuglia dello stesso distaccamento entrava in Rezzoaglio in pieno giorno, catturando tre sergenti alpini e un interprete tedesco. All’uscita dal paese la nostra pattuglia era attaccata in forze e si disimpegnava senza perdite. Il giorno l0 ottobre la seconda squadra del distaccamento Fortunin portatasi sulla strada Varese-L\. Spezia attaccava un’autocolonna delle brigate nere di ritorno dal Passo di Cento Croci, dove aveva disarmato gli alpini del presidio perché sospetti di collaborazione con i partigiani. Un autocarro carico di materiale e di truppa veniva fatto saltare con lancio di cariche esplosive. La reazione nemica era intensa da parte dell’artiglieria dei presidi vicini: la squadra rientrava senza perdite. Il giorno 13 ottobre una squadra del distaccamento Turco mentre rientrava da una missione nel versante ligure era circondata ed attaccata da oltre 260 tra alpini e bersaglieri nell’abitato di S. Stefano d’Aveto. Lo scontro violento per intensità di fuoco – i fascisti avevano mitragliere e mortai – aveva breve durata. I nostri rotto il cerchio riuscivano a raggiungere il distaccamento. Il patriota Brin (Fiori Fulvio da La Spezia) cadeva prigioniero perché ferito ed era immediatamente fucilato alla schiena sul sagrato della chiesa di S. Stefano d’Aveto. Due altri dei nostri rientravano feriti tra i quali il commissario del distaccamento, Stefano.
Il mattino del 17 ottobre, elementi dei distaccamenti Cosimo e Fortunin, attaccavano il presidio tedesco di Bertorella sulla strada BorgotaroBedonia. La reazione tedesca era intensa. A colpi di bombe a mano erano messe a tacere le postazioni delle mitraglie. Dopo alcune ore di combattimento il presidio era sopraffatto con bottino di armi. Perdite avversarie, 4 morti, alcuni feriti e due prigionieri. Il grosso approfittando della bassa nebbia e delle acque torbide del Taro riusciva a fuggire. Da parte nostra rimaneva ferito l’Apuano commissario del distaccamento Cosimo. Nel bottino si rinvennero importanti documenti militari. Nella notte del 20 ottobre una squadra di pochi uomini al comando di Bill e di Rolando si recava nell’accampamento degli alpini al Passo del Bocco e prelevava un’intera squadra di mitraglieri; complessivamente otto uomini armati, una mitragliatrice tedesca P. 42 e molte cassette di munizioni. Intensa la reazione nemica con fuoco di 75/13 che battevano la zona circostante per più ore.
AUTUNNO TRISTE
Venerdì 13 Ottobre 1944 un reparto di alpini della Repubblica di Salò fucilava sul sagrato della chiesa parrocchiale di S. Stefano, l’amico Fiori Fulvio « Brin » di La Spezia catturato ferito e immediatamente condannato a morte. Fiori Fulvio classe 1924 era militare e l’otto settembre nello sbandamento .dell’esercito seguì due « veci » della Val Taro, Mantegari Francesco di Tornolo e Zanelli Domenico di Selvola di Bedonia, sperando di potersi salvare fra i monti, evitando la deportazione quasi certa se fosse rimasto a casa, in Piazza Brin a La Spezia. Precedentemente aveva intrecciato una fitta corrispondenza con una bella ragazza, Maria Bruni di Montevaccà, sotto forma di madrina di guerra, pertanto venire da noi era anche l’occasione per conoscere1a gentile fanciulla che con tanto calore lo sosteneva epistolarmente nei momenti di sconforto sotto la« naja ».
Pur essendo di convinzione politica antifascista, egli non aderì subito al movimento patriottico, ma maturò la sua scelta nel tempo e quando la decise spontaneamente e consapevolmente, venne da noi, sia in conseguenza degli incontri amichevoli avuti a Tornolo, sia seguendo per simpatia i consigli dell’amico maestro Gasparini « Pasquino » di Montevaccà. Rossi « Dartagnan » che comandava il distaccamento « Turco» completò l’opera di convinzione. La fucilazione alla schiena di Fulvio, fu come una mazzata in testa a tutti noi. La stagione era brutta e uggiosa, ci si prospettava un altro inverno duro di lotta, i nervi erano tesi a fior di pelle. In quella situazione, la reazione del nostro comando fu immediata, dura, istintiva e brutale: fucilare per rappresaglia dieci Prigionieri in numero di due per distaccamento ‘e quattro del distaccamento
« Turco» a cui apparteneva « Brin ». Purtroppo la rabbia umana esasperata all’estremo nella guerra civile quando scoppia improvvisa, non ha limiti. Così chi meno sentiva il peso della perdita subita perché distaccato più lontano, per spirito umanitario non eseguì l’ordine ricevuto, mentre noi che eravamo i più colpiti direttamente predisponemmo la fucilazione per la sera stessa. Tuttavia a questo punto, diversi tra noi, più sensibili alla pietà cristiana, facevano ancora affidamento come « ultima» chance per evitare l’esecuzione sul colloquio e confessione del Parroco di Calice. Purtroppo dire che Don Clemente Boccardo era anziano e malaticcio, come ha scritto Don Domenico Della Casa, era una versione eccessivamente benigna che non valse minimamente a mitigare la gravità della decisione presa dal Comando Partigiano.
Formata con estrazione a sorte la squadra d’esecuzione, i prigionieri vennero condotti davanti al cimitero e fucilati. Uno di essi l’alpino Dina De Guio, il più ardito e che fra l’altro non aveva voluto confessarsi, nell’ oscurità diede una manata sulla lanterna portata dal partigiano che lo sorvegliava saltò la siepe e si rese uccel di bosco. Fui mandato in pattuglia con tre partigiani nel tentativo di riprenderlo, ma più che altro per impedirgli di raggiungere S. Stefano e rientrare con i suoi. Sceso da Calice ai Cerri, vidi come uno sprazzo di luce nella notte, verso il mulino oltre il Ceno. Attraversammo il ponte in legno, ed entrati nel molino, trovammo molte donne imbarazzate dal nostro arrivo, ma che subito si giustificarono spiegando che stavano facendo l’olio di contrabbando con i « garigli » di noci e nocciole.
Colsi al volo l’effusione amichevole di quelle donne che credevano di essere in dolo con. . . l’annonaria e pur vedendo muovere qualche cosa d’insolito, ritornai verso la porta dicendo ad alta voce al mugnaio e alle sue ospiti, che avrei proseguito le ricerche del fuggiasco verso Anzola e Casalporino. Il mugnaio capi al volo, mi accompagnò all’uscio, mi strinse forte il braccio in segno di solidarietà, mi fece molti auguri per l’esito delle mie ricerche. L’alpino Dino poi vagò alcuni giorni nei boschi fra la frazione di Tomba, Anzola, Tasola nutrendosi di frutta selvatica e castagne, rifugiandosi sotto il fieno in alcune cascine per passare le notti ormai fredde. Poi passò il Monte Segalino e allo stremo delle forze, prese la decisione di presentarsi ad una famiglia di Montarsiccio, che lo sfamò, lo vestì e incaricò il Parroco di sistemarlo. Per meglio inquadrare tutti gli avvenimenti riporterò quanto scritto sull’argomento dalla Sara Raffi Lusardi di Montarsiccio nel suo volume « Tempi di guerriglia» e pubblicherò lo stesso diario dell’Alpino Dino per meglio focalizzare il dramma come cristianamente subito dalla controparte.
NEL DISTACCAMENTO DI KLEPS LA PRIMA ESECUZIONE
Aveva piovigginato per tutto il giorno e sul tardi era calata la nebbia. Quando fu sera, la gente del villaggio dentro le case, nel Distaccamento ci fu movimento. Il prigioniero venne mandato innanzi sulla strada per Cornolo. Da Camurata a Cornolo c’è poco. La larga mulattiera portava (ora v’è la carrozzabile) già al ponticello sul Lecca e poi saliva sull’altra sponda: lì sopra ci sono le case con la chiesa ed il cimitero. Camurata e Cornolo, un gruppo di case qua e l’altra di là dal rio, hanno nomi diversi, ma sono lo stesso paese.
L’alpino cominciò a chiedere dove lo si conducesse; e siccome nessuno gli rispondeva fu preso dalla paura. Il silenzio ostinato dei partigiani che lo accompagnavano (uno solo ogni tanto, badava a dirgli: «Va avanti, cammina») gli diede la certezza del presentimento avuto. Provò allora a supplicare: «Che cosa ho fatto? ». « Ditemi che cosa ho fatto ». Lo disse via via tremando, piangendo, inceppandosi nelle parole, sino a che non fu più nemmeno capace di balbettare. Pareva, nel silenzio della sera, di udire il suo tremare. Già sotto l’erta diede segno di reggersi a stento; e si dovette arrivare sul lo spiazzo tra la Chiesa ed il cimitero.
Allora dalla canonica uscì il prete che indossava una palandrana dal cappuccio nero. La figura del prete, apparso così acconciato, nello scenario già di per sè lugubre della sera caliginosa, fece serpeggiare un brivido tra gli astanti. Egli corse incontro all’alpino e lo abbracciò. Stettero soli. Per quanto? Il tempo s’era fermato o s’era messo a fuggire precipitosamente? Non era una scena reale. I Partigiani che, ancor oggi, a più di trent’anni di distanza, sotto vesti di incubo, ricordano quella triste ora, ristavano trasognati ed increduli. Quando l’alpino si staccò dal prete era divenuto calmo; con comportamento dignitoso andò a mettersi dinnanzi al plotone ormai schierato. Di fronte ai fucili spianati disse ancora, con voce che non tremava più: « Perché? ».
Una scarica lo abbatté. Qualcuno gli si avvicinò a finirlo. Quanti del plotone gli avevano veramente sparato? Il suo corpo venne tirato via subito e portato nel camposanto. Qualcuno con le mani andò a mescolare terra nella pozza di sangue e sparse l’impasto tepido per togliere quella terribile fresca traccia. Sbatté le mani una contro l’altra per nettarsele e se le passò sui calzoni. Questo fu il tocco finale cui occhi sgomenti guardarono con raccapriccio quella notte per non dimenticare. Fu una esperienza tristissima per i Partigiani del distaccamento di Kleps lo slavo.
Per pura obiettività, nello stendere questi racconti, ho voluto inserire, come documento, anche il diario dell’alpino Dino De Guido.
PREMESSA
L’Italia dal ’43 al ’45 ha sofferto gli orrori della guerra civile ed i suoi figli non si riconoscevano più: erano ragazzi sperduti nella bufera della lotta fratricida in cerca di asilo, fanatici in agguato pronti a seminare lo sterminio e la morte, traditori decisi anche a denunciare il proprio fratello pur di salvare se stessi, deboli in preda ad una continua paura, sfruttatori, depravati, imboscati, figli di papà, ostaggi, malviventi, eroi ed altre vittime di quella che fu la guerra la più crudele che l’uomo abbia fatto a se stesso. In mezzo a questi disgraziati sono venuto a trovarmi anch’io, e se sono riuscito a salvarmi era perché il mio destino era che non dovessi morire. Le pagine che seguono narrano le vicende dell’avventura che mi è capitata pochi mesi dopo il mio rientro dalla Germania nazista, ed è con vero raccapriccio che 9 anni dopo mi volto indietro a rivedere i fatti.
NOVE DIAVOLI NERI
Alle otto e mezzo di sera del 3 ottobre 1944, assieme ad altri sei compagni di sventura, caddi prigioniero di un gruppo di partigiani della 32.ma Brigata Garibaldi (Formazione partigiana, comandata da un certo Bill, operante nella zona Bedoniese della provincia di Parma). Quella sera eravamo di pattuglia a Santo Stefano d’Aveto, piccolo paese di montagna situato nei pressi di Rezzoaglio, in Liguria. La nostra compagnia, la 3° del battaglione complementi della divisione repubblichina Monte Rosa, comandata dal capitano Gianti, era accantonata in un gruppetto di case, a circa un chilometro da Santo Stefano. I partigiani ci piombarono addosso proprio nel momento in cui meno ce li aspettavamo: stavamo appunto per sederci sopra una panchina posta davanti alla chiesa (quest’ultima scostata da Santo Stefano di circa cento metri) quando ci giunsero all’orecchio delle intimazioni di mani in alto, e nello stesso momento vedemmo sbucare da di dietro il muricciolo di cinta del sagrato nove ombre nere, le quali, in due salti ci accostarono minacciose, ed in quattro quattr’otto ci disarmarono. Poi, quello che sembrava il comandante ci disse con voce autoritaria di seguirli di corsa, senza parlare e senza far rumore. Cosicché, lungo viottoli sassosi ed il più possibile all’ombra delle siepi, il comandante davanti e gli altri ai nostri fianchi, quei nove diavoli neri ci condussero verso una ben triste avventura.
DISTACCAMENTO CHIESA
L’indomani pomeriggio, dopo aver camminato tutta la mattina attraverso valli e monti, (la notte l’abbiamo trascorsa in un fienile) giungemmo, sempre scortati, in un paese chiamato Santa Giustina di Bedonia, in provincia di Parma. Infine eravamo arrivati a destinazione. A Santa Giustina era accantonato un distaccamento partigiano forte di circa quaranta uomini, con a capo un bedoniese soprannominato Chiesa. Una grande casa era stata messa alla disposizione di quell’imponente raggruppamento di uomini coraggiosi, anche se praticamente non capitava mai che tutta la comunità vi alloggiasse, perché una parte di essa era sempre <<in missione», così com’erano stati «in missione» quei nove partigiani che la fatidica sera del 3 ottobre ci piombarono addosso con vellutata violenza. L’ottimismo e l’armonia che regnavano in seno al distaccamento Chiesa erano sorprendenti, malgrado che la disciplina imposta dalle circostanze ad ogni singolo individuo fosse molto severa. I partigiani di Santa Giustina erano quasi tutti di Bedonia, e come tutti i cospiratori di questa terra avevano il loro nome di battaglia. Ce n’era uno, ad esempio, che si faceva chiamare Attila, ed un altro Bandolero; inoltre c’erano i Ben-Hur, i Nerone, i Macario, i Cobra, ed altri dai nomi di battaglia strambi, pescati chissà dove e come.
Tanto per dire in breve quale fu la nostra attività a Santa Giustina, scriverò che la nostra occupazione di tutti i giorni era di accudire ai lavori cosiddetti di casa, tra i quali i più importanti furono quelli di lavar piatti e pentole, di scopare la «caserma» da cima a fondo, di spaccar legna e di
sbucciar patate per la cucina. Ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questi lavori erano per noi un diversivo, dato che non ci era ancora permesso di allontanarsi per nessun motivo dal paese di Santa Giustina. Si sapeva, però, che non era lontano il giorno in cui il comandante Chiesa ci avrebbe dato in consegna sten o qualcosa di simile, ma prima bisognava dar prova di buona volontà e di coraggio.
TRASFERIMENTO PRECIPITATO
Sennonché un giorno, e precisamente la sera del 14 ottobre 1944, il comandante Chiesa, di ritorno a Santa Giustina dopo una breve assenza, ci fece chiamare nel suo «ufficio» e ci disse che cinque di noi sarebbero stati trasferiti in un altro distaccamento. Essi erano: Severino da Castello di Arzignano (Vicenza), Antonini e Manno ambedue da Roma, Cozzolino, siciliano ed io stesso. Fu veramente una partenza precipitata. Non avemmo nemmeno il tempo di salutare i compagni che restavano. Accompagnati da Cobra e da un certo Thompson, ci incamminammo tristemente dalla parte da dove, dieci giorni prima, eravamo giunti. Siccome il giorno avanti era piovuto, lo mulattiera era seminata qua e là di chiazze di fango gelato; per di più le mie vecchie scarpe facevano acqua, così, per non bagnarmi del tutto i calzettoni di lana che avevo ai piedi, me li tolsi e li misi nella tasca posteriore del mio giacchettone militare con lo scopo di trovar li asciutti una volta giunto a destinazione.
Dopo circa un’ora di cammino arrivammo in un paese non diverso da tutti quelli che abbiamo già visti in precedenza; era, come seppi più tardi, il paese di Ca’ Murata. Ormai era caduta lo notte, e le finestre delle case erano tutte illuminate. Siccome i nostri accompagnatori avevano l’aria di cercare qualcosa chiesi a Cobra se eravamo arrivati, ma lui mi rispose semplicemente di no. Giunti un po’ più lontano, davanti ad una grande casa situata ai piedi di una ripidissima salita, Cobra ci disse di aspettare e vi entrò. Ne uscì poco dopo accompagnato da parecchi partigiani armati fino ai denti. Il primo di questi, un uomo alto e magro, (certamente il comandante) ci venne appresso, e dopo averci guardati da vicino ci disse di metterci in riga, uno di fianco all’altro. Stupiti eseguimmo. Allora l’uomo lungo e magro si accostò a Severino, a lui il più vicino, ed il primo della riga, e gli chiese: «Di dove sei?» «Da Vicenza» rispose Severino. «E tu?» riprese, rivolto a me che ero il secondo. «Pure da Vicenza » fu lo mia risposta. Lo strano personaggio si scostò ancora, e, trovatosi questa volta faccia a faccia con Cozzolino: «E tu?» chiese palesemente innervosito. Come intese lo voce del siciliano scandire il nome del suo paese d’origine, l’uomo lungo e magro fece un passo indietro e disse a Cozzolino: «Vieni tu!» Il siciliano non eseguì subito e l’uomo ripeté l’ordine. Allora Cozzolino s’incamminò assieme allo strano comandante ed ai suoi uomini, e con essi entrò nella casa da dove, pochi minuti prima erano usciti.
L’UOMO DAL PIZZO ROSSO
Cozzolino e gli uomini che lo accompagnavano erano appena spariti ai nostri occhi che un uomo a cavallo, seguito da altri due a piedi, venne verso di noi, dicendo: «Vogliamo andare, ragazzi?» Allora Cobra e Thompson ci strinsero lo mano augurandoci buona strada e buona fortuna, e se ne andarono silenziosi. Ci incamminammo subito dopo anche noi, ma nel senso opposto a loro, su per lo ripida mulattiera, lasciando dietro a noi Ca’ Murata, ormai sprofondata nel buio della notte. L’uomo a cavallo, il cui mento era ornato da un pizzo rosso tagliato alla moschettiera, faceva da guida, e stava sempre davanti a noi, mentre gli altri due, armati di sten e di bombe a mano, rimanevano in mezzo a noi a chiacchierare. Ero stanco, ma l’idea che domani era domenica mi confortava un pochino. Non so esattamente per quanto tempo camminammo; il fatto sta che ad un certo momento ne ebbi abbastanza e mi lamentai coi partigiani. Uno di questi mi tranquillizzò dicendomi che eravamo presto arrivati. Difatti poco dopo entrammo in un raggruppamento di case buie e silenziose. «È qui» mi disse uno dei partigiani. «Che paese è?» chiesi. «Calice, Calice di Bedonia», mi rispose lo stesso. Giunti davanti ad una casa illuminata ci fermammo; ne uscì gente armata. Istintivamente mi guardai attorno: l’uomo dal pizzo rosso non c’era più. «È andato tutto bene?» chiese qualcuno. «Tutto bene!» rispose uno dei nostri accompagnatori. «Entrate, ragazzi!» ci fu detto. Entrammo, seguiti da vicino da tutta quella gente.
Dopo quel lungo camminare nella notte, e quel pestare nel fango delle mulattiere, la grande stanza illuminata e piena di gente che si offerse ai miei occhi mi parve la più accogliente che avessi mai visto in vita mia.
IL CORRIDOIO RISCALDATO
Ci fecero sedere; ci chiesero se avessimo fame. Eravamo affamati! Ci portarono un piatto di minestrone per ciascuno e mangiammo con appetito sfrenato, anche se tutta quella gente che ci stava attorno ci guardava con un’aria che aveva non so che di minaccioso e di preoccupante. Finito che ebbi di mangiare mi rivolsi ad un partigiano che stava proprio davanti a me a guardarci, e gli chiesi come mai c’erano tutti armati all’intorno, e quello mi rispose, dopo un attimo di riflessione, che era perché Calice era vicino alla zona controllata dai fascisti. Poco convinto da quella risposta mi girai dalla parte dei miei compagni, ma il partigiano che mi stava vicino, il quale, certamente, ci teneva di continuare la conversazione, mi chiese a sua volta: «Era molto tempo che vi trovavate nel distaccamento Chiesa?». «Dieci giorni» risposi. «Prima eravate a Santo Stefano d’Aveto, vero?». «Sì» risposi. Il mio interlocutore mi fissò negli occhi e mi chiese ancora: «Lo sapete che qualche giorno fa a Santo Stefano è successo un brutto fattaccio?». «No» risposi. «Che cos’è successo?». «È successo che siamo stati traditi da una masnada di alpini della Monte Rosa. Traditi nel più indegno dei modi, capisci? Prima ci avevano fatto sapere che desideravano passare con noi, e poi ci hanno teso un’imboscata. Uno dei nostri è caduto, ferito, nelle loro mani. E sai la fine che gli hanno fatto fare? Lo hanno attaccato alla coda di un cavallo e trascinato per le vie del paese fino ad ucciderlo tra le sofferenze più atroci che l’uomo possa sopportare».
In questo momento entrò nella stanza un partigiano, il quale, avvicinatosi al nostro tavolo, ci disse: «Se avete finito possiamo andare». «Dove?» chiesi preoccupato. «A dormire» rispose. Ci alzammo sospettosi. Un silenzio opprimente si era fatto nella stanza. Sentivo che stava per accadere qualcosa di estremamente grave, ma non osavo dire né chiedere nulla che potesse tradire il mio stato d’animo. Seguimmo il nuovo arrivato ed uscimmo all’aperto, scortati da vicino da parecchi di quei partigiani che stavano nella stanza assieme a noi. Fuori la notte era buia pesta. Risalimmo, dietro alla nostra guida, la stradicciola di pietre piatte che pochi minuti prima percorremmo dall’alto in basso, e su quel selciato malgualivo i nostri passi titubavano, risuonando cupamente tutt’intorno. No percorremmo più di trenta metri. La nostra guida si fermò davanti ad una porta buia e silenziosa. Senza bussare lo spalancò; una luce viva illuminò i nostri visi. Ci dissero di entrare. Entrammo.
In un corridoio ampio e riscaldato altri partigiani stavano ad aspettare.
UN BEL VISO COLOR DI CERA
L’uscio si era appena chiuso alle nostre spalle che un prete apparve sull’inquadratura di una porta situata sul fondo del corridoio. Il prete era pallidissimo in viso, tanto che sembrava un morto al quale il becchino avesse concesso di fare ancora quattro passi sulla terra prima di riporlo in essa. Al collo portava lo stola da confessore.
Compresi. E credo abbiano compreso anche i miei poveri compagni. perché scorsi sul loro viso i segni caratteristici del terrore. Io, che non dovevo essere meno impressionato di loro, sentii improvvisamente precipitare i battiti del mio cuore ed un brivido freddo percorrermi dalla testa ai piedi. Era questo dunque il trasferimento di cui ci parlò Chiesa quando ci mandò a chiamare nel suo «ufficio» di Santa Giustina? Era il trasferimento dalla vita alla morte al quale alludeva, o, per dirla nel termine partigiano, il «trasferimento in Piemonte». La rappresaglia, una sciocca rappresaglia, si era abbattuta su di noi innocenti, e noi dovemmo accettarla colla rassegnazione di chi non sa più a quale santo rivolgersi per avere salva la vita. Intanto i nostri sguardi smarriti si muovevano attorno in cerca di quel qualcosa che si sapeva già di non trovare. Ad un tratto il partigiano che dianzi ci venne a cercare per accompagnarci fino lì, si fece avanti e disse, rivolto ad Antonini. al quale indicò il prete: «Entra!» Dopo un attimo di esitazione il romano ubbidì ed assieme al religioso scomparve dietro alla porta che un partigiano aveva premurosamente tirato a sé. Ma non passarono più di dieci secondi che lo porta si spalancò nuova mente ed il prete riapparve dicendo con voce tremante: «Non si può: è troppo emozionato!». «Allora lo faccia uscire!» gridò lo nostra guida di poco fa, e, rivoltosi dalla mia parte: «Entra tu!» soggiunse. Io, che dopo lo prima emozione mi ero ripreso un po’, dissi: «Non ne ho bisogno». «Peggio per te!» brontolò, e fece a Manno il cenno di entrare. Questi si mosse, ed il suo passo incerto si incontrò, sulla porta, con quello di Antonini. I due si fermarono un istante a guardarsi. Smarriti, poi Antonini venne vicino a me, e si appoggiò al muro del corridoio, il quale, scosso dai singhiozzi del romano, si mise a vibrare cupamente. Alla mia sinistra Severino non diceva nulla: sembrava come inebetito. Appoggiato al mio braccio, sentivo che tremava tutto. Povero ragazzo, lui che tre giorni prima aveva compiuto i 19 anni. lui così buono e pieno di salute, sentirsi dire ad un tratto che era stato condannato dai suoi propri fratelli a morire come il peggiore degli assassini! Quando venne il suo turno, entrò barcollando dal prete che lo aspettava, e quando ne uscì, il suo bel viso color di cera non aveva mutato espressione, né il suo corpo aveva cessato di tremare.
Finita lo confessione di tutti i miei compagni di sventura, (Antonini era entrato dal prete per la seconda volta e ne uscì un tantino più calmo) un partigiano ci legò i polsi due a due con una cintura di tela militare. Fui accoppiato a Severino, di modo che il polso della mia mano destra si trovò strettamente legato a quello della mano sinistra di Severino. E così tragicamente due a due uniti ci condussero fuori.
IL LUMINO AD OLIO
La situazione nella quale, assieme ai miei tre compagni. ero venuto a trovarmi mi era sembrata talmente critica, che non potevo intravedere la mia salvezza che attraverso la fuga. Ma fu solo quando mi trovai all’aperto che mi resi conto di tutte le difficoltà che dovevo superare per portare a buon termine un così temerario progetto. Difatti la notte era talmente buia, che difficilmente potevo scorgere un ostacolo a più di due metri lontano da me, ragione per cui mi parve impossibile poter scegliere il punto adatto dove iniziare lo mia fuga. Ma ciò che ancora più mi preoccupava era il nodo che mi teneva strettamente legato al polso di Severino. Sarei riuscito a disfarlo prima che fosse troppo tardi e senza che qualcuno tra i partigiani che mi stavano vicino se n’accorgesse, in virtù di un lumino ad olio che alle mie spalle era venuto improvvisamente ad illuminare, con malsicura luce, il lugubre corteo dei condannati a morte? Nonostante queste preoccupazioni, la folla dei partigiani si era appena messa in moto trascinandoci dietro, che già, colla mano sinistra, mi misi a «lavorare» freneticamente il nodo.
Credo di non aver passato in vita mia momenti più terribili di quelli durante i quali le mie unghie malsicure si conficcavano nervosamente nel nodo, in cerca del capo buono da tirare per disfarlo. Era come se fuori da quell’intreccio di tela grigioverde la mia vita fosse definitivamente salva. Ma la paura che avevo di perdere completamente il controllo dei miei nervi mi tormentava più di ogni cosa, perché sapevo che la mia salvezza dipendeva in parte dal mio sangue freddo, ragione per cui mi sforzavo di rimanere il più calmo possibile, scacciando da me il pensiero della morte.
Intanto, a passi lenti e monotoni, giungemmo davanti alla casa nella quale, poco prima, ci fu offerto quella che doveva essere l’ultima cena della nostra giovane vita. E fu precisamente lì davanti che riuscii con sforzo supremo, a disfare il nodo, ed a liberarmi il polso. Siccome nessuno si era accorto di nulla, nemmeno Severino, credo, pensai con soddisfazione che il primo passo verso lo salvezza era fatto e che ora dovevo, ad ogni costo, fare anche il secondo. Stringendo in mano il capo sciolto della cintura, per non dar sospetto, decisi, per tentar la fuga, di aspettare di trovarmi fuori dall’abitato, se quella era la nostra destinazione. Intanto il mio pensiero correva al lumino ad olio che mi seguiva ostinatamente, e colla coda dell’occhio ne studiavo la posizione. Siccome avevo il mio piano di azione, non dovevo trascurare nulla che potesse compromettere la mia progettata fuga. Ad un tratto le case cessarono di profilarsi lungo la strada sassosa, e l’aperta campagna si offerse vagamente ai miei occhi. Mi dissi che era venuto il momento di agire. In uno sforzo supremo feci appello a tutto il mio coraggio, e, nel momento in cui mi trovai a passare vicino ad una siepe allineata sulla mia sinistra, a valle del viottolo, mi girai di scatto, diedi un terribile colpo al lumino ad olio, e mi tuffai paurosamente sopra la siepe, senza sapere dove andassi a cadere.
LA RAGAZZA DEL MOLINO
Caddi bocconi, senza farmi male, sopra un terreno battuto. Intesi gridare. Subito mi rialzai, e mi misi a correre a più non posso. Ma non feci più di quattro passi che alle mie spalle echeggiarono gli spari delle armi automatiche. Mi buttai carponi e mi trascinai in avanti a forza di gomiti, e quando, due metri più in là, giunsi in un punto dove il terreno faceva scarpata, mi lasciai rotolare. Intanto, sopra di me, continuavano a fischiare le pallottole che nell’oscurità mi cercavano rabbiosamente. Ancora qualche metro e mi sarei trovato al riparo dalle armi da fuoco. In quattro salti vi riuscii. Da allora iniziai una fuga veloce e faticosa, rovinando verso il basso senza badare a spese, furiosamente, attraversando di corsa i cespugli che si trovavano sulla mia strada, e scavalcando le siepi di reticolato senza preoccuparmi della sorte dei miei poveri pantaloni, i quali, in quattro quattr’otto lasciarono spirar aria da tutte le parti. In più fui costretto a togliermi le scarpe che mi si erano letteralmente strappate ai piedi come fossero di carta. Rimasi scalzo, coi pantaloni a brandelli e le gambe coperte di lacerazioni dolorose. Ma il guaio più grosso mi capitò proprio mentre stavo per giungere a valle: trasportato nella mia corsa, precipitai da un muro alto parecchi metri, e mi slogai la caviglia del piede sinistro. Zoppicando e a corto di fiato attraversai il fondo valle che una piccola frazione di luna era improvvisamente e pallidamente venuta a rischiarare. E più avanzavo, più distinto giungeva alle mie orecchie il mormorio di un’acqua che scorre via vorticosamente. Ad un tratto, spaventato, mi fermai: pochi metri davanti a me una costruzione scura e apparentemente silenzioso mi sbarrava la strada. Rimasi talmente impressionato da quella inaspettata apparizione, che istintivamente feci l’atto di ritornare sui miei passi, ma l’idea di riavvicinarmi a Calice, anche di un solo metro, mi terrorizzava a tal punto, che rimasi lì, impalato, senza più sapere cosa fare. Ma trovandomi nella necessità di raddrizzare la situazione senza perdere tempo, decisi di spingermi in avanti spostandomi un po’ sulla mia destra, e di prendere, una volta sorpassata la solitaria costruzione, la via della montagna. Mi rimisi quindi in cammino a passi lunghi e silenziosi, con l’occhio attento e l’orecchio teso; ma quando già stavo per sorpassare l’ostacolo (che non era altro che un molino) vidi spirar luce attraverso le giunture di una porta. Istintivamente corsi a nascondermi dietro il tronco di una pianta che mi stava vicino. Da quello stesso momento la porta si dischiuse, ed una figura di donna, con in mano una lampada accesa, uscì all’aperto e si diresse dalla mia parte. Preso così all’improvviso non seppi cosa decidere, se, cioè, aspettare, facendo il modo di cui non farmi vedere, o fuggire prima che giungesse vicino. Il passo della donna era così spedito che non ebbi il tempo di fare né l’una né l’altra cosa, e lo scontro fu inevitabile. Come mi vide, la donna, una ragazza, lanciò un piccolo grido, e si mise a indietreggiare, terrorizzata, verso casa. L’avrei senz’altro lasciata andare, se, preoccupato dal fatto che potesse gridare e dare l’allarme, non mi fosse venuta l’idea di rivolgerle la parola. “Per andare a Santo Stefano!» le chiesi con voce fioca. La ragazza si fermò, ma non rispose. “Per andare a Rezzoaglio!» azzardai un po’ più forte. Allora la ragazza alzò un braccio, e indicò colla mano tesa la montagna alle mie spalle; poi scappò via di corsa. Altrettanto feci, anch’io, lanciandomi, zoppicando, nella direzione che la ragazza mi aveva indicato. Ma non percorsi più di dieci metri che mi fermai di scatto. “Sono uno sciocco» pensai “a fuggire in una direzione che mi é stata indicata da una persona del luogo, quando potrei sfruttare l’occasione per ingannare i miei eventuali inseguitori, qualora venissero a chiedere di me al molino».
Girai su me stesso, e, dopo aver passato, inosservato, dietro al molino presi, zoppicando, lo via della montagna.
LA PAURA DELL’OMBRA
La montagna che con instancabile tenacia mi ero messo a scalare non era tanto alta come me l’ero immaginata, e benché il mio piede mi facesse terribilmente soffrire, in circa mezz’ora arrivai in cima. Ai bassi cespugli del primo versante avevano improvvisamente fatto seguito degli enormi alberi attraverso i quali i pallidi raggi di luna filtravano con difficoltà, per poi andare a morire miserabilmente sopra un terreno coperto qua e là di scaglie bianchissime di sasso bruciato. Progredivo stentatamente su quel terreno pieno di dolorose insidie per i miei poveri piedi scalzi, quando un colpo secco sulla mia destra mi fece rabbrividire. Terrorizzato mi fermai ad ascoltare: un altro colpo uguale al primo si fece udire subito dopo sulla mia sinistra… poi un altro) ancora, alle mie spalle… ed un quarto, nuovamente sulla mia destra. Allora, scombussolato, persi completamente il controllo dei miei poveri nervi, e via via che i misteriosi colpi andavano ripetendosi intorno a me, sentivo crescere nel mio cuore il terrore della morte. Mi sembrava che dietro ad ogni albero e celati nell’ombra del bosco, visi sghignazzanti di uomini cattivi stessero in agguato per strapparmi da dosso tutto ciò che con disperata volontà ero riuscito a trascinare fino lassù. E mi giravo di scatto ad ogni colpo che udivo, senza mai spostarmi dal punto dove mi trovavo, come se una forza sotterranea mi trattenesse per i piedi, permettendomi solo di girare su me stesso. Fu in quei brutti momenti che, per lo prima volta, in quella terribile sera, vissi nel suo pieno la tragedia di Calice. Abbandonato a me stesso, e spossato dalla fatica, provavo l’orrore che prova della morte un essere sano giovane ed amante della vita. Infine, in un supremo sforzo, mi spinsi in avanti gli occhi fuori dall’orbita, tremante, febbricitante, mezzo impazzito dal terrore che mi dominava tutto; ad ogni passo inciampavo in qualche ostacolo che i miei occhi paralizzati non vedevano, e cadendo mi scorticavo le ginocchia e le mani. Un po’ più lontano, accecato dalla paura e stremato di forze, mi lasciai cadere ai piedi di un albero e mi accovacciai. rassegnato e vinto, contro il suo tronco. In quello stesso mo mento qualcosa di duro mi cadde sulla testa, e rimbalzò ai miei piedi e si raccolse nella mia mano destra. Lentamente apersi gli occhi e guardai: era una grossa castagna, nera e luccicante che pareva di vetro. Preso da uno strano dubbio la gettai in aria: il rumore che fece cadendo per terra era del tutto uguale a quelli che dianzi avevano scosso al limite i miei poveri nervi. Istintivamente alzai lo sguardo verso il cielo: sopra la mia testa, rischiarati dalla morente luna, rigogliosi castagni secolari piegavano verso terra i loro rami carichi di ricci maturi. Mi rimisi in piedi, sospirando profondamente, e con passo malsicuro ma deciso, attaccai in discesa, l’altro versante della montagna, lasciando dietro a me l’indimenticabile bosco di castagni.
DIALOGO NELLA NOTTE
Nella terribile sera del 14 ottobre 1944 credo di aver provato, in poche ore, tutte le emozioni suscettibili di marcare la vita di un uomo. Così, dopo aver sofferto gli orrori di una condanna a morte, dopo aver provato il terrore di un incontro indesiderato con un essere della mia specie, anche se quell’essere era una fragile ed innocua ragazza, ed infine dopo aver conosciuto, nel bosco di castagni, il vero aspetto della morte, mi fu dato di vivere, più sotto, un dramma non meno terribile dei precedenti, né meno violento. Mai, come in quella discesa, il piede mi fece così soffrire, tanto che non potevo più servirmene. Ero giunto al limite estremo della resistenza umana, e non potevo fare un passo senza rischiare di cader per terra e rotolare, impotente, verso la valle che laggiù urlava e tuonava come una furia scatenata. Ad un tratto una strada larga e bianca apparve ai miei occhi bagnati di dolore. Una strada? Io, che da dodici lunghi giorni non vedevo che mulattiere, ne provai una gioia indescrivibile. Le strade – mi dissi – sono il simbolo della civiltà, e per me, in quella notte, civiltà voleva dire vita e salvezza. Ma la mia gioia fu di breve durata, perché, girando lo sguardo un po’ a destra, vidi, attraverso i folti cespugli, una grande casa grigia. E nella mia mente stanca riapparve, per l’ennesima volta in quella sera, l’uomo bestiale con tutta la sua cattiveria. Preso dalle vertigini mi sentii cadere sull’erba bagnata e svenni. Quando ripresi i sensi mi trovai lungo disteso sul ciglio della strada, dove certamente ero venuto a rotolare in seguito al mio svenimento. Tremavo tutto dal freddo. Mi rimisi stentatamente in piedi. A pochi metri da me vidi nuovamente la casa. Era una casa dall’aspetto signorile, con davanti una grande ringhiera in ferro, ed una doppia gradinata d’accesso, alle finestre dai balconi chiusi pendevano delle vistose cassette di fiori, allineate con cura l’una rispetto all’altra. Quest’ultimo particolare mi commosse. Chi ama i fiori – pensai – non può essere di animo cattivo. Sapevo di aver bisogno di aiuto; sentivo che da solo, ormai, non sarei riuscito a fare più di cinquanta metri. Ma l’idea che nella casa abitassero delle persone disoneste mi preoccupava di più di qualsiasi altra cosa, anche di morire in quella specie di tomba che faceva il fossato stradale nel punto dove mi trovavo. Cosa dunque dovevo fare per togliermi da quella terribile situazione? Avevo paura della valle, paura della montagna che dianzi mi ero lasciato alle spalle, paura della strada bianca e della casa grigia; avevo perfino paura di me e di qualsiasi decisione che in quel momento avrei potuto prendere. Andare? Restare? Bussare alla porta che il destino aveva posto sulla mia strada? Tutti questi interrogativi, ai quali io solo potevo rispondere, sconvolgevano la mia povera mente. Ma infine, spinto da chissà quale forza occulta, mi incamminai, deciso a tutto, verso il nuovo ostacolo, e ne spinsi il cancello; entrando nel cortile, salii penosamente lo gradinata di sasso, e bussai alla porta della casa solitaria, più che mai rassegnato al mio destino. Ma dovetti insistere parecchio prima che qualcuno, all’interno, si facesse vivo; allora un viso di donna si affacciò alla finestra, sopra lo mia testa, e chiese: «Chi è là?». «Dove conduce questa strada, signora?» chiesi. «A Bedonia» fu la risposta. Conoscevo Bedonia per esservi transitato quindici giorni prima; sapevo anche che una nostra compagnia vi si era fermata per presidiare la zona. Ragione per cui chiesi: «A Bedonia vi sono ancora gli alpini della Monte Rosa?». «No» rispose lo donna. «Alpini e tedeschi sono tutti partiti». Ero disperato. «Signora», dissi, le lacrime agli occhi. «Sono ferito!» La donna non rispose. «Se i partigiani mi riprendono sono morto!» ripresi. «Che cosa posso fare io?» fece lo donna. «Non so, signore», dissi «ma io non posso più camminare; sono mezzo nudo, e ho tanto freddo! Credo di avere lo febbre!» La donna ebbe un momento di esitazione poi disse: «Senta: in casa mia non lo posso ricevere perché non voglio spaventare lo mia bambina. Però vede quella piccola casetta, laggiù, sotto strada? È una stalla. È mia. Vi troverà delle foglie secche. Domani mattina di buonora lo verrò a cercare e qualcosa si farà». «Grazie» dissi. La finestra si rinchiuse ed i passi della donna s’allontanarono e si spensero. Incoraggiato un pochino da quelle parole, scesi dalla gradinata e mi diressi lentamente verso lo stalla e vi entrai. E dopo aver cercato colle mani d’intorno, mi lasciai cadere di peso sopra un mucchio di foglie secche e mi addormentai.
UNA BRAVA DONNA
Sognai partigiani tutta lo notte. Quando mi svegliai il giorno stava già per spuntare. Stentatamente mi misi a sedere; ero tutto un dolore: dai piedi alla testa tutto ciò che toccavo mi faceva terribilmente soffrire, in particolar modo il piede sinistro, il quale era così gonfio che pareva stesse per scoppiare. Fedele alla promessa la donna venne a cercarmi che faceva ancora in parte buio. La seguii faticosamente, senza parlare. Quando fummo in casa mi fece sedere sopra una panca di legno, e, con molta pazienza ed altrettanta delicatezza mi lavò, disinfettò e medicò le numerose ferite. Mi chiese poi se avevo fame, e, siccome le risposi di sì, si fece portare dalla figlia (una bambina di circa dodici anni) un piatto di castagne spelate e cotte che mi offerse dicendo: «In casa non abbiamo granché da mangiare: viviamo colla sola tessera!» Tutto mangiando le feci il racconto dell’avventura capitatami, e quando ebbi finito mi chiese: «Ed ora?» non risposi; d’altronde che cosa avrei potuto rispondere? Ma la brava donna capì senz’altro che ero troppo malmesso per poter continuare la mia strada, perché, dopo un momento di riflessione, mi disse: «Se vuole la posso alloggiare qui vicino in un vecchio forno che un tempo serviva a cuocere il pane. Lì dentro sarà al sicuro fino a quando si sentirà nuovamente in grado di camminare. In quanto al mangiare, l’avverto che la sarà un po’ dura, perché, come già le ho detto…». «Oh! Signora! dissi, commosso fino alle lacrime lei é troppo buona! Lo so che non mi lascerà morire di fame e se proprio non subentreranno delle complicazioni, farò presto a guarire».
Per ben nove giorni rimasi nascosto in quel provvidenziale ripostiglio, gentilmente assistito dalla brava donna, la quale, ragionevolmente, mi veniva a portare tutto ciò per calmarmi l’appetito. Inutile dire che in quel vecchio forno trascorsi anche le giornate più lunghe e le notti più fredde della mia vita. Malgrado ciò le mie ferite guarirono lo stesso; non così il mio piede, però, il quale, anche se si sgonfiò in parte, mi faceva ancora male a poggiarmici sopra. Decisi di partire lo stesso, anche per togliere alla donna ogni ulteriore disturbo. E fu così che la sera del 23 ottobre, alle undici circa (ora di luna piena) infilati i miei piedi nei calzettoni di lana conservati intatti nella tasca posteriore del mio giacchettone, e salutata, con cuor commosso, la brava donna che per nove giorni mi aveva assistito come una madre, lasciai la villa dei Cascinei (così si chiamava la casa grigia) in direzione Santo Stefano d’Aveto.
LA VOCE SOAVE
Malgrado fossi continuamente dominato dall’idea fissa di giungere a Santo Stefano, non mi ero mai illuso di potervi arrivare. Sentivo anzi che per uscire sano e salvo dalla mia triste avventura, il miracolo doveva effettuarsi in quella zona della montagna in cui mi trovavo, al più lontano a Montarsiccio, piccolo paese verso il quale la donna dei Cascinei mi aveva orientato, e distante dalla villa di soli circa cinquecento metri. In partenza mi tenni scostato dalla strada, prendendo la via, più sicura, del bosco, ma dopo un centinaio di metri appena il mio piede mi fece nuovamente tanto soffrire, che dovetti rassegnarmi a seguire il bordo stradale. Alle prime case di Montarsiccio, però, le mulattiere riapparvero nuovamente, selvagge e sconcertanti, con tutti i suoi tristi ricordi per me. Ed era come se il paesaggio si oscurasse improvvisamente. Benché la donna dei Cascinei mi avesse assicurato che a Montarsiccio non c’erano partigiani, proseguivo con circospezione, rimanendo il più possibile nell’ombra delle siepi e delle case. Il paese, sprofondato nel sonno, pareva deserto, tanto il silenzio che vi regnava era grande. Ma ad un tratto, come giunsi sulla piazzetta del paese, una finestra illuminata mi ferì lo sguardo, ed una voce con un canto divino mi giunse all’orecchio e scese nel mio cuore. Il sentimento che provai sul momento era un misto di speranza e,di paura, ma presto mi riebbi e mi fermai, estasiato ad ascoltare. Chi era quella voce che nella notte, in un paesaggio pieno di ombre misteriose, si frammischiava improvvisamente al soffio leggero del vento di montagna, e giungeva fino a me ad accelerare i battiti del mio cuore senza che ne provassi timore come nel passato? E che cosa diceva in un’ora così tarda in cui tutto, all’infuori di quella finestra illuminata, era silenzio e sonno intorno a me? E, infine, da dove veniva? da una di quelle case buie che mi stavano attorno, o dall’alto delle stelle che luccicavano, tremule, lassù nel cielo? Temendo, per un istante, di essere vittima di un miraggio, mi sforzai di concentrare tutta lo mia attenzione nel suon di quella misteriosa voce, non tanto per sapere cosa dicesse, quanto per assicurarmi che essa non era frutto della mia immaginazione. Feci qualche passo verso il centro della piazzetta, senza però uscire dall’ombra in cui mi tenevo nascosto; mi parve allora che non solo lo voce esistesse, ma che uscisse perfino da dietro il vetro opaco della finestra illuminata. Ne provai una gioia indescrivibile, direi quasi violenta, forse come quella che prova il bambino quando, cercando nella calza della Befana un giocattolo che desidera tanto e sopratutto, ve lo trova più bello ancora di come se l’era immaginato. Ma quando, improvvisamente, la voce si tacque, e nell’aria fredda non rimase che il vento d’autunno a soffiare sentii come un terribile tonfo al cuore e le forze abbandonandomi lentamente. Per non cadere andai ad appoggiarmi al muro di una casa, lo sguardo rivolto dalla parte dove si era spenta la voce meravigliosa. Allora mi parve che anche la luce della finestra andasse affievolendosi. E per l’ennesima volta la paura della notte, dell’isolamento e dell’abbandono mi prese del tutto. Fu allora che un nuovo sentimento prese consistenza nel mio cervello, un sentimento che solo lo stato d’animo in cui mi trovavo in quei momenti poteva generare: la fiducia. E mi dissi che ad ogni costo dovevo ritrovare quella voce così rassicurante per me, e scacciare, una volta per sempre, lontano da me l’idea assurda di raggiungere Santo Stefano d’Aveto, prima che fosse troppo tardi, prima, cioè, che altre disgrazie venissero ad aggiungersi a quelle di cui già portavo i segni in ogni parte del mio corpo. Improvvisamente uscii dall’ombra, e con passo deciso mi diressi verso la finestra che poc’anzi aveva richiamato la mia attenzione. Pian piano, per non scivolare, le passai sotto, e andai a vedere dietro la casa. Dopo aver cercato un pochino, scorsi alla mia destra una gradinata scura che saliva nella direzione della stanza dalla finestra illuminata. La scalai aiutandomi colle braccia, e dopo aver picchiato e ripicchiato alla porta che in cima era venuta a sbarrarmi il cammino, spinsi quest’ultima ed entrai in un corridoio scuro dal pavimento malgualivo. Sul momento credetti di essere capitato in un solaio, e già stavo per ritornare indietro, quando vidi luce filtrare attraverso le fessure di una porta chiusa. Col cuore in sospeso mi ci avvicinai a bussare leggermente. Un sordo mormorio mi rispose, seguito da uno strisciar di piedi; poi lo porta girò cigolando su se stessa, scoprendo ai miei occhi lo figura nera e bassa di una donna apparentemente anziana. Come mi vide, il suo volto solcato da profonde rughe, assunse l’espressione della paura, e rimase lì a guardarmi con aria inebetita. Mi feci coraggio: “Per andare a Santo Stefano ?» le chiesi sottovoce. Alle mie parole lo donna si scosse, abbozzò un povero sorriso mezzo sdentato e disse chiudendo a metà gli occhietti che le brillavano in fronte: «Santu Stefanu?» e si girò per un attimo a guardare nell’interno della stanza come per cercare l’aiuto di qualcuno; poi, rivolta nuovamente dalla mia parte: «Ma entri!» soggiunse; e spinse lo porta per allargarne il passaggio. Entrai. In una stanza ampia e nera, illuminata da una lampada a carburo, tre altre persone stavano a ricevermi: una donna, un uomo baffuto e magro, ed una ragazza di circa vent’anni.
La donna che dianzi mi aveva aperto lo porta mi diede da sedere. Per riscaldarmi un pochino, mi posta il più vicino alla stufa che potevo. Dovetti aver l’aspetto di un brigante (erano dieci giorni che non mi lavavo il viso, ed altrettanti che non mi facevo lo barba) perché le persone che mi stavano a guardare avevano l’aria di essere alquanto preoccupate nei miei riguardi delle mie intenzioni. Fu ancora la donna che mi fece entrare a rompere il silenzio opprimente che aveva fatto seguito alla mia venuta in quella stanza semibuia. «Per andare a Santo Stefano – disse ce ne vogliono delle ore di cammino. E poi bisogna conoscere la strada.» – « Non conosco la strada – feci io – ed in più ho un piede che mi impedisce di camminare.» – «Perché? È ferito?» mi chiese la ragazza che fino allora si era accontentata di guardarmi. Il timbro della sua voce, uguale a quello che poc’anzi avevo udito dalla sottostante piazzetta, mi fece andare il cuore in gola, tanto che sul momento mi fu impossibile di aprire bocca. Infine, con uno sforzo: «Sì.» risposi, turbatissimo. «Com’é stato?» chiese ancora lo ragazza. Sul momento non seppi cosa rispondere, ma quella voce, e l’aspetto rassicurante del viso della ragazza non mi lasciarono la forza di mentire. «Scappando – risposi – mi sono slogato una caviglia» – «I fascisti?» chiese con insistenza la ragazza. «I partigiani.» risposi sottovoce. «Ho capito: – disse la ragazza illuminandosi in viso – lei é l’alpino di Calice!» – «Sì – feci io sorpreso – Ma come fa lei a sapere?» – «In questi ultimi giorni si é molto parlato dell’alpino di Calice» fu la risposta. Un lungo silenzio fece seguito a queste parole; poi la donna che mi aveva offerto da sedere mi chiese se avevo fame. «Un po’!» le risposi. Mi offersero un piatto di minestra ed un pezzo di torta impastata colla farina di castagna. Ad un tratto l’uomo che fino a quel momento non aveva aperto bocca, mi chiese: «E poi che cosa pensa di fare?» Non risposi, e continuai a mangiare, preoccupato. Allora l’uomo si alzò, e dopo averle fatto segno col capo, uscì dalla stanza seguito dalla donna che cinque minuti prima mi aveva aperto lo porta, chiesto di entrare, offerto da sedere e da mangiare. Rientrò due minuti dopo dicendo: «Per stanotte le daremo noi da dormire; domani si vedrà.» Mentre stavo mangiando l’uomo s’affarava d’intorno; staccò una lanterna da un chiodo e l’accese. Com’ebbi finito diedi a tutti la buona notte, e lo seguii. Dopo essere scesi nel cortile, mi fece attraversare la piazzetta di poco fa e scendere lungo una larga e sdrucciolevole mulattiera sulla nostra destra. Dieci metri circa più sotto mi mostrò una casetta bassa ed isolata, sulla sinistra, dicendomi sottovoce: «È là!» Mi accompagnò fin sulla porta, la spinse col piede, mi rischiarò colla lanterna un mucchio di foglie secche, che copriva in parte il suolo di quella specie di stalla e mi disse: «Dorma bene. Domani, appena potrò, lo verrò a prendere. E si allontanò rapidamente, lasciandomi solo soletto coi miei pensieri.
ALPINO, GUARDA CHE BEL SOLE
L’indomani, per tutta lo giornata nessuno mi venne a trovare, e fu solo quando già il sole era tramontato e scesa la notte che l’uomo dai baffi, la lanterna accesa in mano, venne a dirmi di seguirlo fino a casa sua, dove, oltre ad un piatto caldo di minestra, avrei trovato anche il prete del paese. Difatti, nell’ampia stanza della vigilia, oltre a ritrovare tutte le persone che già conoscevo, stava ad attendermi un prete dall’aspetto ancor giovane e dalla faccia gioviale. Mi fece un sacco di domande riguardo la mia avventura, ma solo quando mi chiese dove avessi passato i nove giorni seguenti la sera del 14 ottobre, gli raccontai sfacciatamente non so quale fandonia, perché la signora della villa dei Cascinei mi aveva pregato, prima di lasciarla, non so per quali ragioni, di tacere il suo nome. Quella sera, a mia grande soddisfazione, mi furono dati un paio di mutande ed un paio di pantaloni in sostituzione dei miei, laceratissimi. Dal canto suo, Don Costantino (così si chiamava il prete) mi consegnò un paio di pantofole con suola di legno, assai larghe da permettermi di calzarle senza maltrattare la mia caviglia dolorante. Infine, prima di partire, mi promise di recarsi personalmente dall’arciprete di Bedonia per esporgli il mio caso e vedere se non c’era il modo di togliermi, senza male, da quella brutta situazione. Ma dovetti aspettare altri due giorni prima di conoscere l’esito preciso dell’interessamento di don Costantino. Quel giorno, precisamente nel pomeriggio del 26 ottobre, mentre stavo leggendo, sdraiato sulle foglie del mio giaciglio, un brano dei Promessi Sposi che Don Costantino mi aveva imprestato, la porta della stalla si spalancò improvvisamente, ed il prete di Montarsiccio vi si affacciò sorridendo maliziosamente. Mi guardò un istante, poi, con voce scherzosa esclamò agitando le mani: «Alpino, guarda che bel sole!» Intuii subito che c’erano delle buone novità per me, e col cuore che mi batteva forte forte mi alzai ed uscii all’aperto. Fuori il sole inondava coi suoi raggi ancora caldi la campagna circostante. Bevvi quella luce a grandi boccate, e mi guardai beatamente attorno senza più curarmi del mio piede ferito. Don Costantino, lui, si accontentò di guardarmi e di lasciarmi fare, poi, presomi per una mano, mi condusse in canonica, dove sturò due bottiglie di vino spumante, dicendo: «Beviamo alla tua salute, Alpino, e magari un po’ anche alla mia.»
LA FAMIGLIA LUSARDI
Ma sarebbe stato troppo bello se, dopo l’interessamento di don Costantino e la mia susseguente «liberazione» dalla stalla, le cose si fossero messe definitiva mente a posto. Purtroppo, durante i sette mesi che sono rimasto a Montarsiccio, la mia vita non fu del tutto scevra da nuove emozioni e da sorprese poco gradite.
Benché ferito e quindi momentaneamente impossibilitato di lavorare, la famiglia presso la quale avevo trascorso i primi tre giorni di Montarsiccio, un po’ anche dietro interessamento di don Costantino, si offerse di prendermi sotto la sua diretta protezione. Detta famiglia, di nome Lusardi, era così composta: Giovanni, il padrone, era l’uomo magro e baffuto; Linda, sua moglie, era la donna piccola dal sorriso sdentato; mentre altre due donne erano Annetta ed Elda, rispettivamente sorella e figlia di Giovanni. La famiglia Lusardi era una delle più ricche della zona: oltre ad avere sei vacche nella stalla, Giovanni era proprietario di un grande appezza mento di terra fertilissima nella campagna emiliana, nei pressi di Reggio. Assidui lavoratori, i coniugi Lusardi parevano fatti l’uno per l’altra, tanto i loro rispettivi caratteri andavano d’accordo; e la loro vita in comune, che allora durava già da circa trent’anni, li aveva talmente uniti di fronte ai comuni interessi, che parevano fratello e sorella. Di Annetta, invece, la zitella per eccellenza, direi quasi il prototipo delle zitellone le quali, con la loro presenza, rattristano non poco la nostra vita, parlerò in altro luogo e più dettagliatamente. In quanto a Elda, lasciamo intanto che maturi in me l’amore che mi ha costato più notti insonne della mia avventura di Calice.
DON COSTANTINO
In vita mia non avrò mai ringraziato abbastanza don Costantino. L’affetto che mi mostrava, le cure che mi prodigava, e l’aiuto morale che ho ricevuto da lui nelle ore nere che ho attraversato a Montarsiccio, provano a quale grado di bontà e di benevolenza può elevarsi un uomo onesto e volonteroso. Infinitamente calmo e col suo eterno sorriso sulle labbra, egli aveva negli occhi sempre viva non so quale luce di bontà o quale fiamma d’amore. Giovane ancora, e piantato ben alto sulle sue lunghe gambe, tutto in lui ispirava la fiducia del gigante buono e caritatevole. Inutile aggiungere che il meraviglioso carattere di don Costanti no mi giovò molto, specie quando, col precipitar degli avvenimenti, il cielo di Montarsiccio si copriva per me di nubi minacciose. Ma ciò che maggiormente mi entusiasmava in lui era il suo modo di giudicare gli avvenimenti che a piccolo fuoco dilaniavano l’Italia ed in particolar modo l’ Emilia. Con uguale disapprovazione criticava il minaccioso comportamento dei tedeschi in Italia, il fanatismo dei fascisti, l’incoscienza di certi partigiani, e l’indifferenza disastrosa degli alleati, i quali, colle loro bombe, mandavano in aria tutte le migliori città italiane. Il giorno in cui mi fece sapere che i miei tre compagni di Calice e Cozzolino erano stati fucilati ancora la sera del 14 ottobre, lo assicurai con le lacrime agli occhi che erano tutti bravi, ragazzi degni di vivere bene e a lungo. “Ti credo, Alpino, disse – perché in questa disgraziata guerra sono sempre i migliori che pagano col loro sangue gli errori dei grandi.» Incoraggiato da queste parole mi sentii in dovere di parlargli di Cozzolino. “Quel povero ragazzo
– dissi – aveva una paura matta di morire: i moltissimi bombardamenti e mitragliamenti che ha subito in Italia ed in Germania gli avevano completamente guastato il sangue. A Borgotaro, malgrado avesse supplicato l’ufficiale incaricato di risparmiarlo, era stato scelto a far parte di uno dei due plotoni di esecuzione destinati a fucilare due alpini che avevano tentato di passare coi partigiani; ne fu talmente scosso, che per tre giorni non toccò cibo, in preda alla febbre e al delirio. Ma chi l’avrebbe detto che egli stesso sarebbe caduto un giorno sotto il piombo di un plotone di esecuzione?» Un altro giorno mi chiese se serbavo rancore a coloro che mi avevano fatto tanto soffrire. «No – risposi senza esitazione – perché al loro posto avrei potuto trovarmi anch’io.» «Vedi, Alpino – disse allora don Costantino palesemente commosso – non m’importa tanto di sapere quale é la tua opinione religiosa, quanto di apprendere che nel tuo cuore è scesa la pace.» E soggiunse: «Lo sai che Bill è uno stretto parente di Giovanni?» «Sì – risposi – È stata Elda a dirmelo.»
ZEFIRO
Un giorno Linda mi disse che il fratello minore di Bill, Zefiro, sarebbe venuto in serata a farmi visita. Zefiro, che assieme ai genitori abitava provvisoriamente la Ca’ de Bosso (piccola località situata a nord di Montarsiccio) era un ragazzo molto diverso da come me l’ero immaginato in un primo momento; calmo e di carattere taciturno, mi fece subito buona impressione, tanto che in pochissimo tempo diventammo buoni amici. Veniva assai spesso a trovarmi, e se non ero in casa veniva a raggiungermi sui campi dove andavo qualche volta a zappare o a vangare. Quando eravamo insieme, anche se non si parlava molto, ci si comprendeva lo stesso benissimo. Un argomento, però, che non abbiamo mai toccato era quello che riguardava la mia avventura di Calice. Era un po’ anche naturale, dopo le ripercussioni che l’uccisione dei miei quattro compagni aveva avuto sugli abitanti della zona, ripercussioni che, sia detto in breve, intaccarono alquanto la popolarità di Bill nei confronti di quella brava gente di montagna. Ma erano cose queste che a noi non interessavano: la nostra amicizia era al di sopra di tutto.
IL RITORNO DEL CAPITANO GIANTI
Avvenne che verso la fine di dicembre 1944 il capitano Gianti capitò a Bedonia con tutta la sua compagnia. Appena rimessosi dalle fatiche del viaggio si recò dall’ Arciprete Monsignor Checchi per chiedergli come era andata a finire la faccenda dello scambio di prigionieri da egli stesso proposto in seguito alla cattura il 3 ottobre 1944 in quel di Santo Stefano d’Aveto, di sette dei suoi alpini, e per l’attuazione del quale l’Arciprete di Bedonia si era offerto da intermediario. «Ah! – esclamò Monsignor Checchi – Era ormai troppo tardi! Il giorno stesso che avevo interpellato il comandante la brigata di partigiani presso la quale si trovavano i suoi alpini, signor capitano, mi è stato risposto che purtroppo erano già stati fucilati.» «Corpo di Bacco! – disse il capitano addolorato – Fucilati? Tutti?» «Meno uno. – rispose l’Arciprete – Quest’ultimo è riuscito miracolosamente a salvarsi scappando proprio all’ultimo momento.» «Come si chiama? Lo sa lei, Monsignore?» – chiese il capitano. Monsignor Checchi si concentrò un pochino, poi fece il mio nome.» Capperi! s’esclamò il capitano – Proprio il mio magazziniere! Ma dove si trova tutt’ora? Lei, Monsignore, lo deve sapere senz’altro!» «Si. A Montarsiccio, presso una famiglia di contadini.» – fu la risposta. «Senta: – fece il capitano – vorrei tanto potergli parlare!» “Se proprio ci tiene manderò lassù il mio cappellano…» – rispose l’Arciprete Monsignor Checchi.
E fu così che l’indomani mattina, mentre stavo con Giovanni, Linda ed Annetta a vangare a metà valle, vidi scendere verso di noi don Costantino accompagnato da un giovane prete a me sconosciuto. Il parroco di Montarsiccio mi fece da lontano il cenno di salire alloro incontro. Quando gli fui vicino, don Costantino mi chiese con uno strano sorriso: «Di’, Alpino; ti ricordi ancora del capitano Gianti?» «Sì, certo!» – risposi stupito. «Ebbene, pure il capitano Gianti ti ricorda, e desidera vederti!» «Cosa?» – esclamai, diventando pallido in viso. «Egli si trova a Bedonia con tutta la sua compagnia, e ha mandato me per dirti di raggiungerlo al più presto.» – spiegò il giovane prete che stava con don Costantino. «È subito detto!» – esclamai. «Mi ha incaricato di dirti che ti avrebbe mandato a casa tua con una lunga licenza…» – riprese il giovane prete. «A casa mia?…» «… e che se tu ti fossi rifiutato di presentarti entro tre giorni, ti sarebbe venuto a prendere personalmente, e che se ti avesse trovato, ti avrebbe fatto fucilare sul posto per diserzione di fronte al nemico!» Sentii un brivido scorrermi da cima a fondo, gelato come una pioggia novembrina. «Sta ora a te di decidere!» – soggiunse. Don Costantino non sorrideva più: il suo sguardo, rivolto verso terra, sembrava sfuggisse il mio, che lo cercava, smarrito e supplichevole. Un profondo silenzio aveva fatto seguito alle parole del giovane prete di Bedonia. Ma fu ancora don Costantino a romperlo. «Vieni, Alpino. – disse – Ne riparleremo lassù.»
Arrivati in canonica don Costantino mi chiese: «E allora, cosa pensi di fare?» io, che strada facendo avevo raccolto un po’ le mie idee, risposi: «Per quanto lusinghiere possano essere le promesse del capitano Gianti, non mi sento il coraggio di presentarmi.» «E perché?» «So troppe cose sul conto dei partigiani!» – risposi. Don Costantino si rischiarò in viso: «Sono contento che la pensi come me, – disse – perché anch’io sono convinto che non ti lasceranno andare senza averti prima spremuto per benino; e ti chiederanno delle informazioni che con le buone o con le cattive, sarai costretto a dare…» «E se non mi presento? – dissi io – Quelli sono anche capaci di venire fino quassù e mettere sottosopra tutto il paese e dintorni pur di trovarmi. Supposto anche il caso che non riusciranno a trovarmi, non bisogna mica credere che si rassegneranno a ritornarsene a casa, con le mani vuote! Ci sono dei vandali in mezzo a loro, dei mascalzoni, che quando capitano in un paese, qualche dispiacere lo fanno sempre, e se proprio non ammazzano nessuno, trovano sempre un pretesto per incendiare qualche casetta. Più si tiene lontana quella gente meglio è, mi creda. Trovi lei il modo di risparmiare me ed il paese, don Costantino; io proprio non saprei…» E don Costantino trovò: la sera stessa io mi sarei nascosto in qualche luogo sicuro, e all’indomani Giovanni e don Costantino avrebbero sparsa la notizia che l’Alpino di Montarsiccio era improvvisamente scomparso. La notizia non avrebbe tardato a giungere fino all’orecchio del capitano Gianti, il quale, di fronte al difficile compito di raggiungermi sopra una zona vasta e montagnosa come quella in cui mi trovavo, non avrebbe trovato di meglio che rinunciare ad ogni inutile ricerca. All’indomani tutto il paese parlò della mia sparizione, ed i più pessimisti sul mio conto andavano in giro dicendo che non si erano sbagliati asserendo che un giorno o l’altro «l’Alpino-Spia» ne avrebbe combinata una delle sue. Ma la notizia non solo fu raccolta dal vigilante capitano Gianti, ma giunse ancor più lontana, fino al quartiere generale di Bill, per esempio, dove non mancò di suscitare una specie di timore, direi quasi una certa preoccupazione, la quale mise in imbarazzo comandanti e sottocapi. Fortunatamente, però, che mi era venuta l’idea di avvisare Zefiro del mio gioco a rimpiattino; Bill fu così informato e tranquillizzato sul mio conto, e tutto rientrò nell’ordine primitivo. Al quarto giorno, allo stupore generale, uscii dal mio nascondiglio. Il capitano Gianti era già partito la sera prima verso altri rastrellamenti, molto lontano da noi, e mai più ne intesi parlare.
PROMESSE D’AMORE
Un giorno Elda, che nel luglio 1944 aveva conseguito il diploma di maestra elementare, era stata chiamata a sostituire per qualche settimana l’insegnante della scuola di Caneso (paese situato a circa quattro chilometri da Montarsiccio, sull’altro versante della valle). Non vedendola né a mezzogiorno né alla sera, durante un’intera settimana, fui preso dalla malinconia. Fu questo il primo ed indiscutibile indizio di un amore che già la sera stessa che giunsi per la prima volta a Montarsiccio era sbocciato in me, e che fino allora non mi aveva ancora completamente convinto. Siccome Elda non mi sembrava del tutto indifferente alle occhiate che ogni tanto le indirizzavo e che lei gentilmente ricambiava, pensai di sondare alla prima occasione il suo cuore per vedere di che genere erano i suoi sentimenti nei miei riguardi. L’occasione mi fu data un venerdì sera, quando, di ritorno da Caneso, si mise, dopo cena, a correggere i compiti che aveva portato seco. Più per farle un piacere che per altro, le chiesi se potevo esseri e utile in qualche maniera, e lei, sorridente, mi allungò una quindicina di quei compiti (tutti dettati) perché glieli correggessi. Scherzosamente le chiesi se dovevo dare anche i voti. «Perché no? – mi rispose lei con la sua solita voce melodiosa – Dia “bene” fino a tre errori, “sufficiente” fino a otto ed “insufficiente” ai più di otto errori.» Non saprei dire con esattezza come nacque in me l’idea originale di servirmi dei compiti di innocenti creature per soddisfare ai miei bassi istinti di uomo innamorato; so solo che Elda, il lunedì appresso, poco dopo la distribuzione dei compiti alla scolaresca, ebbe la strana sorpresa di vedersi capitare davanti uno dei suoi più bravi allievi, il quale, timidamente le tendeva il foglio del dettato, chiedendole che cosa era il voto che lui e parecchi suoi compagni si erano meritato. Stupita, Elda prese il compito, lo guardò e stralunò gli occhi: in calce al foglio, in matita rossa, stava candidamente scritto: «Le voglio… BENE.» La sera stessa Elda capitò improvvisamente a casa alla sorpresa di tutti i suoi famigliari. Dal canto mio mi aspettavo un serio rimprovero, invece Elda parlò ai suoi di un libro di testo che aveva dimenticato a casa, e che per l’indomani le occorreva senz’altro. A me invece diede un’occhiata tutt’altro che rimproveratrice. Da allora Elda ritornò a casa quasi tutte le sere per darmi lo possibilità di starle vicino. Poi, finita lo supplenza, il nostro amore si arricchì di nuove speranze, e quando, soli a tu per tu, ci fu permesso di parlare del nostro avvenire, ci pareva già che il mondo ci appartenesse tutto. Ma lo forza e la sincerità dei nostri sentimenti vanno ricercate soprattutto nel fatto che malgrado il segreto timore che avevamo di far parte ai famigliari di Elda del nostro amore, continuavamo a vedere nella fine della guerra, che speravamo prossima, la realizzazione incondizionata dei nostri sogni più belli.
LA MOGLIE DEL MACELLAIO
Alfonso era un macellaio ambulante molto conosciuto nella zona bedoniese. D’inverno andava da un paese all’altro ad ammazzare maiali ed a insaccarli. Abitava a Calice dove aveva moglie e figli, ed una casetta tutta sua. Il giorno che venne a Montarsiccio fece una capatina fino in casa di Giovanni col proposito di conoscermi. Com’era naturale il discorso cadde automaticamente sulla sera di Calice del 14 ottobre, e siccome ad un certo punto io gli avevo manifestato il desiderio di ritornare tra breve a Calice per una visita, egli mi disse bonariamente: «In tal caso non manchi di passare anche per casa mia: mia moglie ha molte cose da raccontarle a riguardo di quella orribile sera.
Fu verso lo metà di febbraio che andai a Calice. Dopo essermi raccolto per cinque minuti, il cuore stretto e gli occhi bagnati dal pianto, sopra lo tomba ancor fresca dei miei sfortunati compagni, mi recai in casa di Alfonso. Questi non era in casa, ma come sua moglie seppe chi ero, mi prese tra le braccia come una mamma alla quale fosse dato improvvisamente di riabbracciare il figliolo ritornato da lontano dopo una lunga prigionia. Mi fece sedere, mi chiese se volevo questo o quest’altro, e malgrado la pregassi di non disturbarsi, mi fece assaggiare un po’ di tutto, dal caffè al vino e dal salame alla frutta. «Ho tanto pianto quella maledetta sera! – disse ad un tratto – Ero forse la sola qui in paese a sapere che cosa stava succedendo. D’Artagnan era qui da me, pallido come un
morto. D’Artagnan era il comandante.» «Aveva la barba, un pizzo?» chiesi io. «Precisamente.» fu la risposta. Mi ricordai allora dell’uomo a cavallo che lo sera del 14 ottobre ci aveva scortati da Ca’ Murata a Calice. La donna continuò: «D’Artagnan non era uomo da ammazzare la gente a sangue freddo, e se era venuto qui da me, era per non assistere all’esecuzione io, dal canto mio, ero terrorizzata di ciò che stava succedendo, e non riuscivo a tranquillizzarmi. Me lo prendevo con tutti, e continuavo a gridare a D’Artagnan che il suo atteggiamento era disgustoso, e che doveva ad ogni costo far sospendere una così inumana esecuzione. «Che cosa vi hanno fatto loro di male – gridai – per ucciderli come se fossero delle bestie?» Ma D’Artagnan non rispondeva: la testa tra le mani, sembrava in preda alla più nera disperazione. Io piangevo e gridavo come una forsennata, insultandolo con quanto fiato avevo in gola. Ad un tratto, visto che D’Artagnan non si muoveva dalla sua sedia, esasperata, mi lanciai su di lui, e lo scossi, con tutta lo forza delle mie braccia tremanti gridando: «Ma perché? perché lei deve permettere una cosa simile?» Allora D’Artagnan si scosse, e, liberatosi dalla mia stretta, si diresse disperatamente verso lo porta maestra dicendo: “È vero! é vero: Non posso permettere…! La mia coscienza non mi lascerebbe più in pace ” Ma non
aveva ancora aperto del tutto lo porta, che una terribile sparatoria attraversò fragorosamente l’aria densa della notte, D’Artagnan si fermò di scatto sull’uscio, e, rivoltosi verso di me, tutto sconvolto in viso, disse, con voce rotta dall’emozione: “Ormai é troppo tardi!” E ritornò a sedersi che non era più da vedere. Ma si era sbagliato; ci eravamo ingannati tutti, perché quegli spari non erano l’esecuzione: era semplicemente lei che fuggiva, e Dio solo sa quanta paura avrà avuto. Ah! può ringraziare la madonna d’averla scappata bella con tutti quei mitra e quelle pistole!»
Il racconto della moglie di Alfonso mi ha molto turbato e quando me ne andai ero così triste, che qualcuno mi chiese perfino se mi sentivo poco bene. La questione era che la moglie di Alfonso non solo mi aveva fatto rivivere in parte gli orrori della sera del 14 ottobre, ma aveva in più fatto nascere in me il dubbio che anch’io, benché inconsapevolmente, fossi in parte colpevole della morte dei miei tre compagni di Calice, tanto che ci volle ancora la buona parola di don Costantino per tranquillizzarmi un po’, «Tu non c’entri per niente: – mi disse – era destino che i tuoi compagni dovessero morire, così com’era destino che tu dovessi salvarti.»
ANNETTA
Benché Giovanni avesse una sola sorella, in casa Lusardi vivevano due Annette: una colla dentiera e l’altra senza. L’Annetta senza dentiera era quella di tutti i giorni, quella, cioè, che si vedeva trotterellare dai campi a casa e viceversa sulle sue sgalmarette eternamente pulite e così bene sagomate che a Cenerentola sarebbero andate a pennello. L’Annetta colla dentiera, invece, era qualcosa di molto più distinto della precedente, tanto che un profano, un individuo, cioè, venuto da altre zone, per lo prima volta, su quelle montagne, che si fosse imbattuto casualmente prima nell’una e poi nell’altra versione di quel fenomeno vivente che era lo sorella di Giovanni, non si sarebbe immaginato nemmeno lontanamente che era sempre lo stessa persona che successivamente aveva incontrato e colla quale aveva magari conversato.
La maggior preoccupazione dell’Annetta senza dentiera erano le galline. Ne aveva di tutte le razze e colori nel suo pollaio semibuio. Ogni gallina aveva il suo personale nome di battesimo ed il compito preciso di metter giù il maggior numero di uova possibile. Giovanni. lui la lasciava fare, anche se non era padrone di tirare il collo ad un pollastro senza prima chiedere il permesso alla sorella, la quale, poi, non sempre glielo concedeva. Era forse anche per questo che le galline avevano una particolare simpatia per Annetta, e questa ne era fierissima, dopo che gli uomini l’avevano relegata nel suo piccolo mondo popolato soprattutto di ricordi di gioventù e di qualche superstite ma pallida speranzioncella d’avvenire. Ma quando l’Annetta appariva in pubblico con la dentiera, se proprio non era festa, qualche importante avvenimento attraversava senz’altro la sua monotona vita di zitella. Allora il suo viso si allungava di un palmo, e sul suo petto di pollo spuntavano chissà come due misteriosi seni giovanili. Il suo portamento diventava grave e dignitoso, e lo sguardo col quale sfolgorava i passanti lanciava tutt’intorno fiamme d’orgoglio. Così acconciata io credo che si sentisse trasportata di parecchi anni indietro verso il passato, ai tempi in cui tutte le sue speranze erano ancora intatte ed i suoi denti molto più efficaci. Era l’Annetta colla dentiera il simbolo vivente della carne che non vuole morire.
GLI AVVENIMENTI PRECIPITANO
Siccome a Montarsiccio mancava la radio, tutte le notizie sull’andamento della guerra ci venivano recate a voce dalle persone provenienti da Bedonia; così, quando non era il postino a portarcele, qualche altro benvenuto capitava sempre che ci metteva al corrente sugli avvenimenti riguardanti la guerra. Io, le notizie, non le lasciavo scappare e per essere più sicuro le annotavo sul mio diario senza tanto ricercare se erano esatte o no. Così, in poco tempo, specie tra marzo ed aprile, ebbi l’occasione di riempire parecchi fogli del mio quaderno intimo. Trascrivo qui sotto, nell’ordine cronologico, quelle tra le notizie di allora che mi sembrano le più vicine alla realtà.
10 marzo 1945 – Colonia sarebbe stata occupata dagli alleati. Il Reno oltrepassato dagli inglesi sopra un ponte ferroviario lasciato intatto dai tedeschi in ritirata. Stettino minacciata; Dublino occupata.
8 aprile – Le armate russe sarebbero giunte ai sobborghi di Vienna. Gli inglesi, dal canto loro, avanzano a passi da gigante. Kesselring, mandato da qualche settimana sul fronte occidentale, avrebbe tentato armistizio. Hannover quasi raggiunta; Brema a poche diecine di chilometri; Norinberga in vista.
11 aprile – Fronte dell’est: Berlino circondata dai russi; Vienna occupata. Fronte italiano: Massa Carrara occupata ed oltrepassata dalle truppe alleate.
21 aprile – Bologna, accerchiata da qualche giorno, sarebbe caduta oggi in mano agli alleati.
25 aprile – Fiume attaccata dai partigiani di Tito.
27 aprile – Stamani notizie sbalorditive. Le porta da Bedonia Rico du Fron. Bedonia è tutta imbandierata, pronta a ricevere le truppe alleate. Chiavari occupata dai partigiani liguri, Genova pure. I francesi sono entrati a Ventimiglia. Parma, Piacenza, Verona occupate dagli alleati. Gli stessi hanno già raggiunto la strada Padova-Venezia e sono a 10 chilometri da Milano. Si ha notizia che Mussolini è caduto, assieme alla Petacci ed altri caporioni del fascismo, in mano ai partigiani della zona cuneense. Berlino resiste ancora, ma per tre quarti è già occupata dai russi. Gobbels fa sapere al mondo che Hitler non abbandonerà, per nessun motivo, la capitale tedesca.
Gli avvenimenti precipitano, e tutto dà da sperare che la guerra stia per finire.
28 aprile – Questa mattina gli alleati sono giunti a Bedonia tra gli èvviva della popolazione. Sono circa una sessantina, tutti neri. all’eccezione del comandante.
IL RIFIUTO.
In seguito all’arrivo delle truppe americane a Bedonia, pensai che era giunto il momento di parlare a Giovanni delle relazioni che correvano tra me ed Elda, ma siccome mi mancava il coraggio di farlo personalmente, incaricai don Costantino, l’unica persona che era al corrente del nostro amore. Così. una delle prime sere di maggio, durante il fioretto alla Madonna, un chierichetto fece sapere a Giovanni che dopo la benedizione don Costantino avrebbe desiderato parlargli. L’incontro tra il prete e il padre di Elda avvenne sul sagrato, proprio davanti alla chiesa. Don Costantino, senza preamboli, andò direttamente al nocciolo della questione. Ma il colloquio fu di brevissima durata, e, dal nascondiglio che all’occasione avevo scelto, fui testimonio della scena la più sconcertante alla quale mi fosse dato di assistere: senza dire nè si nè ma, Giovanni piantò in asso don Costantino, e scappò via di corsa come se tutti i suoi capitali stessero per bruciare. Quando, poco dopo, giunsi in casa Lusardi, non vi trovai che Annetta: Giovanni. Linda ed Elda erano di sopra che discutevano. Mi sedetti vicino al lume a carburo, ed attesi che Annetta mi dicesse qualcosa. Non aspettai molto: la zitella mi venne vicino, e con voce scossa da una falsa emozione mi disse sibilando: «Non si vergogna, dopo tutto il bene che le abbiamo fatto?..» Scappai via per non darle una brutta risposta. Ma per tutta la notte non chiusi occhio. Pensavo al male che potevo aver fatto ai Lusardi di essermi innamorato di Elda e di aver chiesto a suo padre il permesso di scriverle dopo la mia partenza. Mi consolai un momento al pensiero che Annetta era in fin dei conti una povera zitella scarsa di cervello, e che quindi non dovevo dare importanza alle sue sciocche parole. Ma ciò che non riuscivo a togliermi davanti agli occhi era la scena del sagrato, vale a dire la fuga precipitosa di Giovanni. In un attimo divenni l’uomo più infelice della terra, ed io che fino allora avevo sempre aspettato la fine della guerra con l’ansia di chi non vede l’ora che le cose si mettano a posto per cercar infine di realizzare i suoi sogni, sentivo che la pace nel mondo mi avrebbe oramai lasciato indifferente, amareggiato quasi. Avevo così tanto da perdere, io, con l’arrivo degli alleati, anche se stava giungendo il momento in cui avrei infine riabbracciato i miei famigliari, dopo lo tremenda avventura di cui sono stato protagonista. Non riuscivo a comprendere l’atteggiamento ostile dei Lusardi nei miei riguardi. Durante i sette mesi che ho vissuto con loro ho sempre fatto il mio dovere, e anche quando, per via del piede, mi era impossibile camminare, mi mettevo sull’aia a segar legna in compagnia di Annetta. Facevo tutto ciò che mi comandavano, tutto e senza mai aprir bocca, tanto che ad un certo momento credevo di essermi meritato lo loro stima. In quella notte e nei giorni che seguirono mi sentii profondamente umiliato. Non vedevo l’ora di poter liberamente partire per togliermi da davanti agli occhi i visi ostili dei Lusardi, sempre lì a spiarmi come se fossi un delinquente pericoloso od un mascalzone. Inoltre lo sguardo di Elda, sempre bagnato di pianto, mi straziava il cuore.
L’ADDIO
Il 13 maggio 1945, cioè non appena fui in possesso del lascia passare, decisi di partire. Con le lacrime agli occhi salutai don Costantino e lo ringraziai di tutto il bene che mi aveva fatto nel corso della mia permanenza a Montarsiccio. Abbracciai Zefiro e gli altri amici. Infine salutai anche i Lusardi, e per l’ultima volta baciai Elda. Partii affranto dal dolore e senza più nessuna speranza di ritornare su quei luoghi sacri per me come una reliquia.
Fu l’addio a Montarsiccio il saluto più triste della mia giovinezza. Era come se i miei passi mi conducessero nuovamente a Calice.
FINE Mulhouse, 22 aprile 1953
DE GUIO DINO
PUNTATA DI ALPINI PRE NATALIZIA
Il 17 Dicembre 1944, il presidio degli Alpini al Passo del Bocco effettuò una sortita su Santa Maria verso le ore 19 in pieno coprifuoco. In segreto e con il massimo silenzio, favoriti dalla oscurità, quando nessuno se li aspettava, gli alpini piombarono in paese, recandosi direttamente alla Trattoria Nando. In quel momento erano presenti molti uomini, riuniti per passare, come al solito la serata con una briscola distensiva.
Il tenente, che entrò per primo, spianò il mitra ed intimò subito il « mani in alto» perquisendo ad uno ad uno i presenti che dovevano anche esibire i loro documenti d’identità. Eseguito un sommario esame, arrestò una ventina dei più giovani, fra questi vi erano, quasi tutti i membri della polizia partigiana locale, e, sotto buona scorta, li condusse al Bocco. Il mattino successivo vennero interrogati e torturati solo sei vennero trattenuti, mentre tutti gli altri dietro interessamento del Commissario Civile, furono rilasciati.
I sei prigionieri erano: Lusardi Berto di Bartolomeo delle Piazze, Squeri Luigi di fu Ferdinando degli Squeri, Squeri Gino di Giovanni del Mezzano, Rota Umberto fu Guido del Casello, Cappelli Guido di Emilio e Giordan Renato di Giulio di Vallombraria. Ad eccezione del Lusardi che era partigiano e che in quei giorni si trovava in licenza, tutti gli altri appartenevano alla polizia partigiana locale che praticamente da quel momento cessò di esistere. Questi giovani furono tenuti prigionieri al Bocco e trattati brutalmente, specialmente il Lusardi e lo Squeri Luigi, ritenuti partigiani. Si cercò in tutti i modi di poterli liberare, ma purtroppo non fu possibile. Mentre noi eravamo in pena per questi nostri cari giovani e speravamo nell’opera del Commissario civile che spesso si portava al Bocco, i partigiani della Banda « Virgola» prelevarono il Commissario stesso, la sera del 19, mentre si trovava nel suo ufficio delle Piazze e nottetempo lo condussero a Valletti dove si trovava il comando: il giorno seguente venne però rilasciato. .
Il 24 Dicembre, i prigionieri del Bocco vennero legati strettamente l’uno l’altro, condotti a piedi a Borgonovo di Mezzanego presso l’altro presidio di Alpini ed ivi gettati di nuovo in prigione come ostaggi. In quei giorni, i partigiani in uno scontro a fuoco avevano ucciso cinque Alpini al Passo della Forcella sopra Borzonasca e allora, il Comando della Monterosa ordinò di uccidere per rappresaglia due prigionieri di Borgonovo e cioè il Lusardi e lo Squeri Luigi. Il Parroco e il popolo di Borgonovo venuti a conoscenza di quella terribile sentenza, s’adoperarono in tutti i modi per scongiurare l’esecuzione e salvare quindi i due giovani, ma purtroppo tutto fu inutile.
Alla vigilia di Natale verso le ore 16, dopo aver dato loro il tempo e la possibilità di confessarsi, vennero presi dalla prigione e tra i pianti e le grida della popolazione tutta furono legati e trascinati sul luogo del supplizio. I poveretti dichiaravano apertamente la loro innocenza e non riuscivano a persuadersi di dover morire, piangendo, invocando ad alta voce la loro mamma. Arrivati nel piccolo piazzale antistante l’entrata del Cimitero, vennero fucilati e caddero come fiori recisi in un mattino di primavera; Il Lusardi aveva 21 anni e lo Squeri 27. Dovevano essere subito sepolti, ma il Parroco ottenne che almeno le salme venissero restituite alle proprie famiglie. Il giorno di Natale a Borgonovo, la Messa solenne, venne celebrata da quel benemerito Parroco, alla presenza di tutto il popolo, in suffragio dei nostri due caduti.
Di questi dolorosi avvenimenti, a Santa Maria nulla si sapeva. Lo si apprese soltanto il mattino di S. Stefano 26 dicembre quando le sorelle dei Caduti che si erano portate a Borgonovo la sera innanzi per trovare i loro cari, tornarono con lo schianto nel cuore, a portare la ferale notizia. Non essendo ci tempo da perdere, si allestirono subito due bare a spese della popolazione, e alcuni volenterosi partirono con un carretto per prelevare a Borgonovo le care salme. Rientrarono la sera del giorno 27 portati nelle loro case vennero vegliati per tutta la notte. Il mattino seguente furono fatti i funerali, non con quella solennità che i giovani meritavano e che la popolazione desiderava, ma modestamente, per timore di una nuova sortita e rappresaglia degli Alpini specialmente verso i quattro prigionieri rimasti. I prigionieri che temevano da un momento all’altro di fare la stessa fine dei loro compagni, vennero invece trasferiti a Carasco e verso la fine di gennaio liberati con l’obbligo di presentarsi a fare il militare. Una volta però liberati divennero uccel di bosco, si unirono ai partigiani e restarono salvi e liberi per sempre.
INIZIO DEL RASTRELLAMENTO INVERNALE 1945

Erano appena ultimati i funerali dei nostri due giovani, vittime delle barbarie nazi-fasciste, che cominciarono ad affluire da Chiavari Alpini della Divisione « Monte Rosa». L’arrivo di queste truppe che occuparono nuovamente S. Maria, coincideva con l’inizio di un nuovo rastrellamento. Infatti si venne subito a sapere, che un rastrellamento era in corso nell’ Alta Val di Vara, nella zona di Valletti e di Comuneglia. A tarda sera di sabato 30 Dicembre, con un freddo intenso, reso ancor più rigido dall’impetuoso soffiare della gelida tramontana o vento del Penna, arrivarono altre truppe di fascisti e Tedeschi, provenienti da Valletti. Portarono con loro una quarantina di prigionieri fra i quali era anche il parroco, Don Bobbio.

Questo rastrellamento aveva già causato nell’ Alta Val Vara, molti morti fra i civili con incendi di case e, razzie di bestiame. A Valletti, saccheggiarono, novelli barbari, la Chiesa e la canonica, arrestando il Parroco, accusato di collaborazione con i partigiani. Quelle truppe nazi-fasciste trasportavano pure il bottino delle loro ruberie e saccheggi perpetrati in quelle zone, comprendenti candele e altri oggetti sacri della Chiesa, biancheria, bestiame ecc. che cercavano di liberarsene a qualsiasi prezzo. Domenica mattina 31-12 l’arciprete con il Commissario Civile, cercarono presso i Comandanti di far liberare il Parroco di Valletti con gli altri prigionieri, ma purtroppo non ci riuscirono. Si pensò quindi di avvicinarli aiutandoli nel miglior modo possibile, provvedendo a dar loro da mangiare e di tutte quelle cose di cui potevano avere bisogno; nello stesso pomeriggio vennero con un autocarro trasportati a Chiavari. Il Parroco di Valletti dopo un sommario ed affrettato processo, venne condannato a morte e subito fucilato nel cimitero di Chiavari era il 3-1-1945. Don Bobbio, degno sacerdote di Cristo si avviò alla morte, sereno, tranquillo e prima di essere fucilato pregò e perdonò i suoi nemici cadendo come un martire dei primi tempi del cristianesimo, non invocando odio e vendetta, ma amando e perdonando. Durante la permanenza di queste truppe a S. Maria, gli uomini, come al solito, si erano dati alla macchia, mettendosi al sicuro mentre le donne non si mossero da casa. Le funzioni religiose erano celebrate più modestamente e con l’intervento di ben poche persone, tanto da suscitare grande meraviglia nei tedeschi stessi.
L. Barilli . Fucilazione del Dordia, dipinto della Amministrazione Comunale di Varano Melegari Questi andavano dicendo che la Chiesa era bella e grande, ma pochi erano i fedeli, non rendendosi conto che la loro presenza era così poco gradita da impedire la venuta dei parrocchiani alla Chiesa; Il pomeriggio del capodanno 1945, le truppe nazi-fasciste, ben equipaggiate e con qualche piccolo cannone, sloggiarono da S. Maria, dirigendosi verso Bedonia, nonostante che la strada fosse interrotta in più punti. Seguendo questo spostamento, si temeva un nuovo attacco da parte dei partigiani e quindi nuove rappreseglie come in luglio. Fortunatamente in quel tempo cadde un’abbondante nevicata come da anni non si vedeva seguita da un freddo intenso che paralizzò momentaneamente ogni attività nei due campi avversi. I nazi-fascisti ripresero presto in grande stile il rastrellamento coadiuvati anche da ex prigionieri russi, molti di loro provenivano dalla Mongolia, sotto comando tedesco, meglio ambientati e acclimatati alla neve e al freddo. Essi dettero la caccia ai partigiani su tutto l’Appennino Ligure-Emiliano, riuscendo a disorganiziare parecchie bande. Sbandati e senza capi si cercava scampo in tutte le direzioni, in mezzo alla neve e a disagi di ogni genere.
Quel rastrellamento risultò per i partigiani uno dei più terribili causando gravi perdite in morti, congelati e prigionieri. I mongoli russi arrivarono anche a S. Maria dove si fermarono parecchi giorni alloggiando nelle case delle Piazze. Mentre in alcuni paesi della montagna, si resero tristemente famosi per violenza e atti di libidine, da noi, si mostrarono abbastanza disciplinati e non si dovettero lamentare gravi disordini.
IN ATTESA DELLA LIBERAZIONE
Dopo il rastrellamento invernale del 1945, moltissimi « Mongoli » del Turchestan e apolidi vari, aggregati alla divisione « Italia », disertarono e si rifugiarono nei casolari dei montanari. Tiranneggiavano gli abitanti, con una continua richiesta di cibo ed eliminavano sistematicamente, tutti i polli, conigli e maiali che capitavano loro sotto tiro. Ricostituito il Comando partigiano, il primo pensiero di « Bill » fu quello di regolarizzare la posizione di questi sbandati offrendo loro la possibilità di entrare volontariamente nel movimento partigiano. Si dovettero affrontare notevoli difficoltà di natura ideologica, per far loro capire, che la nostra popolazione era alleata e non doveva essere taglieggiata o trattata come ostile o come si trattasse di un paese di conquista. Dopo lunghe estenuanti trattative, cui partecipai direttamente, riuscimmo a costituire un gruppo di base che formò il distaccamento russo di Ponteceno. Il distaccamento dipendeva direttamente dal Comando posto ad Anzola, ma i Russi non vollero riconoscere un comandante o un commissario italiano. Loro capo fu riconosciuto all’unanimità un simpaticissimo « Ucraino » pseudo capitano mortaista, molto loquace che riusciva a farsi capire sia in italiano che in tedesco.
Furono stabilite anche le condizioni di garantire una regolare fornitura di vettovagliamento accompagnata da damigiane di grappa oltre a cappotti americani di lana per tutti e a due coperte militari a testa. In questo modo si ebbe ragione dei « contestatori» sicché dopo un primo periodo di prova, rientrarono anche i più recalcitranti. Nei nostri reparti non esistevano « mortaisti » e pertanto quando disponemmo dei primi mortai americani ricevuti con « aviolancio », ci mettemmo alla ricerca di esperti che sapessero utilizzarli alla prima occasione in combattimento. Il comandante non trovò di meglio che promuovere subito il distaccamento dei russi a « reparto mortaista d’assalto ». In verità le infiorate storie avventurose sui precedenti bellici del capitano, non convincevano nessuno cosicché con l’arrivo della primavera, giudicata ormai completata l’istruzione del reparto, si volle fare il battesimo del fuoco, pensando al suo futuro impiego tattico. L’azione, prevedeva un bombardamento da un’altura del Bocco sul presidio di Borgonuovo, dove fra l’altro era in postazione anche il cannone cal. 75/13 già ritirato al Passo del Bocco.
Inuna trincea naturale al riparo, assistevano con cannocchiali in pugno come fossero alle grandi manovre, il comando al completo e ufficiali di collegamento della missione alleata, arrivati appositamente da Compiano. II primo colpo di prova, con nostra grande delusione, finì nel bosco sottostante, quasi che la carica non lo avesse spinto abbastanza. II nostro « capitano» imperterrito, sbottò che il mortaio da cc. 88 americano era « m . . . » mentre se invece fosse stata una « Katiuscha » allora si . . . che. Comunque con la massima disinvoltura il colpo venne considerato come rientrante nei programmi previsti e il capitano fece infilare nel tubo del mortaio una carica di polvere supplementare, portò l’alzo più alto verso il cielo, con l’intenzione di imprimere alla bomba maggior spinta e allungare la curva parabolica per colpire il bersaglio a maggior distanza. Ciò che ne seguì fu un fuggi fuggi generale: La bomba così lanciata salì alta nel cielo con una traiettoria quasi a campanile, per ricadere poi, con un gran sibilo e tutta la forza di gravità sulla cascina antistante, che nello schema del bombardamento, serviva di copertura e nascondere al nemico la postazione della nostra batteria di mortai.
Da notare che ‘lo scoppio fu di tale sorpresa, che molti partigiani appostati in attesa del segnale di attacco dopo il bombardamento, lo considerarono come un colpo nemico che preventivamente avesse individuato le nostre postazioni. Inutile dire che in quel momento Bill avrebbe voluto disarmare tutto il reparto russo. Ma poi prevalse il buon senso; da quel momento questi nostri strani alleati vennero ignorati, con l’unico impegno di restarsene al loro distaccamento a bere grappa e a cantare inni rivoluzionari senza più uscire a infastidire la popolazione locale.
Per nostra buona sorte, si fece avanti un ex sergente mortai sta della « Monterosa » di nome Morini, rientrato dalla prigionia in Germania, che senza tanta prosopopea accettò di dirigere i nostri mortai al Passo del Bocco. II 12 aprile piazzata la batteria mortai, dietro la cima del Monte Ghiffi, iniziava un bombardamento a tappeto sul presidio e al terzo colpo centrava la S. Barbara della Caserma. La deflagrazione che seguì fu apocalittica . Va ricordato che fra l’altro vi erano depositati circa 70 q. li di dinamite, portati dai tedeschi per far saltare la strada del Bocco durante la ritirata. Una persiana dell’edificio, ex albergo, la vidi volare fino alle praterie di Giaiette a qualche chilometro di distanza.
Un nutrito ulteriore bombardamento, faceva brillare parte dei campi minati che circondavano il presidio e alle ore 13,30 partì il fatidico telegramma per il Comando Unico di Bardi; – Oggi alle ore 13,30 i valorosi garibaldini della 32′ brigata si sono attestati sulle rovine fumanti del Passo del Bocco dopo averlo espugnato ardimentosamente. Il Sergente Marini a fine della guerra sposò la Sig.na Bruni Luisa di Tomba e ritornò al suo paese per gestire il Consorzio Agrario di Ponte Taro.
Riprende il racconto di Don Costantino:
Rastrellamento invernale gennaio 1945
Ai primi giorni del 1945 il rastrellamento che abbiamo avuto, ci è capitato in paese, dopo che se ne parlava da qualche giorno. Gli Alpini venivano da Chiavari. Hanno setacciato quasi tutti i paesi che si trovavano sulla strada, da Chiavari a Bedonia. Il 1 gennaio, circa le ore 11, di ritorno da Spora, dove avevo celebrato la Santa Messa, mi vedo capitare in casa Volpini Don Riccardo, parroco di Strepeto, che era fuggito da casa sua con un gruppo di parrocchiani ricercati dagli alpini, che nella mattinata stessa erano giunti a Pontestrambo e si portavano verso la sua parrocchia. Attraversando il monte Orocco, che, per fortuna, in quei giorni non era coperto di neve, si era portato verso Chiesiola per andare poi a finire a Retorto dove aveva intenzione di fermarsi.
Dovendo egli ancora celebrare la S. Messa, lo pregai di celebrare nella mia chiesa. Egli accettò ben volentieri, ma appena terminato, non volle neppure accettare una tazza di caffè, e si dileguò coi suoi parrocchiani nella direzione dell’ Anzola. La sua fuga repentina da Chiesiola, mise in allarme un po’ tutto il paese e la vallata, e preparò quella psicosi che precedeva sempre un rastrellamento. La mattina del 3 gennaio ci vedemmo arrivare le prime colonne di Alpini. Una parte di essi si portò nelle parrocchie di Spora, Romezzano e Casalporino. A Drusco se ne videro pochi.
Nella mia canonica, presero non alloggio, ma la mensa un capitano e due tenenti. Questo rastrellamento non è stato per nulla un rastrellamento vero e proprio, perché gli alpini, ufficiali e truppa, una volta sistemati, non fecero che tenere lunghe chiacchierate, e (eravamo nel tempo natalizio) delle interminabili tombole nelle case dove si trovavano. L’esito innocuo di questo rastrellamento per quanto riguardava Chiesiola è merito principale della signora Mangiante che aveva tentato di intrattenere gli ufficiali, perché gli alpini non si allontanassero dal paese e non recassero disturbo ai partigiani, anche se non potevano fare a meno di recarne ai paesani.
Prima che gli alpini giungessero in paese quattro miei parrocchiani avevano trovato a circa mezzo chilometro di distanza dalla chiesa, un rifugio in un bosco. Sapevo della fuga dei quattro, ma non sapevo con precisione il luogo del rifugio. La mattina dopo l’arrivo degli alpini mi si presentò l’lrene, moglie di Serventi Pietro, e si mostrò preoccupata per il marito che si trovava nel rifugio senza cibo e bevanda. Intanto che stavo parlando con lei, si presentò anche la Moglie Virginia, dicendomi la medesima cosa per il suo vicino di casa, Mantegari Giovanni.
Come si poteva pervenire a loro e portarvi del cibo con gli alpini che avevano invaso il paese, dove si trovavano solo donne, vecchi e bambini? (Gli uomini validi erano tutti – a sentire coloro che erano rimasti in paese – sotto le armi o prigionieri in Russia). Il pericolo era grave, era grave non solo perché il farsi vedere in giro con fagotti poteva destare sospetto, ma anche per il fatto che durante la notte era caduta circa dieci centimetri di neve. Le orme sulla neve potevano essere una buona traccia per arrivare al rifugio da parte degli alpini, e prendere così facilmente in trappola i quattro.
Visto come si presentavano le cose, consigliai le donne di portare in canonica quanto desideravano fare giungere ai rifugiati. Avuta la roba, ne feci un unico pacco, ispezionai attorno alla canonica per vedere se potevo uscire ed allontanarmi senza essere osservato, e dopo aver avvertito i miei ospiti Mangiante, dicendo loro che mi dovevo recare a Spora per preparare la chiesa per la vicina festa dell’Epifania (infatti la parrocchia di Spora era vacante dopo la promozione del Rev. Don Davide Mantegari a parroco di Vigolo Valnure) mi inerpicai per un sentiero in un bosco già segnato da chi si era recato ad una stalla, di buon mattino, per accudire alle bestie.
Ad un certo punto dovevo uscire dal sentiero per avvicinarmi al rifugio indicatomi dalle due donne, quando scorgo davanti a me, a circa cinquanta metri, due alpini che transitavano per una stradetta in diagonale con il mio sentiero. Andavano a testa bassa, intenti a dove posavano i piedi. Non mi mossi, ma mi abbassai il più possibile, perché la mia tonaca nera era troppo visibile nel bianco della neve. Essi passarono senza avermi scorto. Allontanatisi i due, mi avvicinai a ritroso al rifugio che intravedevo, consegnai il fagotto dei viveri e, senza fermarmi minimamente, feci ritorno a casa senza fare nessun altro brutto incontro.
Di questo rastrellamento desidero notare un caso particolare che suppongo non fosse unico. Per il comportamento che ho tenuto in questa circostanza non posso, né voglio giudicarmi, spero davanti a Dio di non averne colpa. Le porte della mia canonica erano di notte vigilate di continuo da un alpino armato, per la paura di un’incursione dei partigiani, che invece si trovavano in ben altra località. L’alpino di guardia alla porta posteriore era un bel e grande giovanotto, veneto di nascita. Rimase al suo posto con una scrupolosità che mi meravigliava, si accontentava di coricarsi sulla panca della mia cucina.
Il giorno 4 gennaio, questo giovanotto si aprì con me raccontandomi che aveva indossato il grigio verde per paura che venisse fatto del male alla sua famiglia, ma non era per nulla convinto della possibilità che i repubblichini riuscissero a spuntarla coi partigiani. La diffidenza davanti a simili discorsi, in quei giorni, ed in simili circostanze, mi sembrò il migliore e più saggio atteggiamento da tenere. Non disturbati da nessuno, questo giovane mi raccontò un po’ tutta la sua vita, e terminò con una frase che mi fece sussultare:
Reverendo, mi dica dove sono i partigiani, che voglio andare con loro. Sono stanco di questa vita. Gli risposi che non sapevo dove esattamente si trovassero, infatti non sapevo con precisione dove si trovassero, perché parecchi giorni prima che arrivassero loro, alpini, si erano allontanati dalla nostra zona. Per quella sera questo argomento terminò così. La mattina dopo, 5 gennaio, vigilia della festa dell’Epifania, cominciò di nuovo a nevicare a larghe falde, e la neve sul terreno cresceva a vista d’occhio. Questa novità mise in subbuglio gli ufficiali e la truppa. Temevano di essere bloccati dalla neve nei paesi e di essere magari attaccati dai partigiani, per cui i comandi nei diversi paesi decisero di partire, al più tardi, nel pomeriggio di quello stesso giorno.
In poche ore la neve coprì tutta la vallata e se ne poté misurare sui 70-80 centimetri. In quell’anno l’inverno fu generoso di neve; quella nevicata, del 5 gennaio, fu la prima, a cui seguirono altre, altrettanto abbondanti fino al mese di marzo. Rividi il mio alpino di guardia, che mi ripeté la domanda della sera precedente, a cui diedi la medesima risposta. Circa le ore 11 giunsero in paese le truppe, che si erano accampate a Spora ed a Romezzano, per partire frettolosamente. Ad esse si unirono quelle che si erano fermate a Chiesiola. Gli ufficiali ed alcuni alpini vennero a salutarci prima di partire.
Mi trovavo sulla porta di casa e miravo la fila indiana di alpini che si allontanava, quando mi sento mettere una mano sulla spalla, mi volto e mi trovo davanti il giovane alpino di guardia, che mi dice: Reverendo, mi tenga qui con lei, voglio andare coi partigiani. In quel momento rimasi titubante. Questa mia incertezza è stata un gesto di prudenza o un atto di vigliaccheria? Me lo sono domandato tante volte in seguito. A mia discolpa ho cercato di quietare la mia coscienza con la cosiddetta «prudenza», necessaria in certe circostanze delicate ma me la vedo sempre davanti come la «prudenza» dei vigliacchi.
Una volta rivoltomi queste poche parole il povero giovanotto si sentì richiamare da un sergente che lo sollecitava a seguirlo presto. Egli mi porse la mano con un «arrivederci» e si buttò di corsa a seguire i suoi compagni. Quando si trovò nel punto dove la strada abbassandosi toglieva la visuale della canonica e della chiesa, si voltò e salutò ancora con un cenno della mano. Una volta scomparso alla mia vista quel povero giovanotto mi portai nella mia camera, mi buttai sul letto e piansi. Quanto male può fare la paura! Qualche giorno dopo seppi che il gruppo degli alpini, che in quei giorni erano stati nei nostri paesi, si erano scontrati con uno sparuto gruppo di partigiani e vi erano stati dei caduti e dei feriti.
Dalla descrizione avuta, posso essere quasi certo che fra i caduti di quello scontro c’era anche il mio giovane alpino, guardia alla porta della mia cucina. Durante questo rastrellamento le forze alpine, che avevano invaso le nostre case, si erano portate nella Valceno da Bedonia congiungendosi a ingenti altre forze che provenivano da Santo Stefano d’Aveto. Davanti a questo spiegamento di forze, i partigiani dopo diversi sganciamenti, si portarono, attraverso il Pelpi, verso Cereseto dove la nevicata abbondante impediva il regolare movimento necessario al gruppo. In questa località il 6 gennaio lasciò la vita un parrocchiano di Chiesiola, il giovane Bresadola Bruno, uno dei primi iscritti alla formazione partigiana del Monte Penna. Allontanatisi gli alpini, la salma venne in seguito, portata a Bedonia dove insieme con altri caduti è stato sepolto nel cimitero locale. In questa circostanza non pochi partigiani, fortemente provati dal freddo, ebbero i piedi congelati. Ad essi i paesani prestarono la loro opera di soccorso.
Tutti alla ricerca di vettovagliamento La Divina Provvidenza
Ho già accennato al fatto che la popolazione della vallata vedeva spesso presentarsi gente alla porta delle loro case. Erano persone che si erano portate in loco per trovare un rifugio, non reputando abbastanza sicura la località dove avevano la residenza abituale. Erano i partigiani che nel momento del bisogno chiedevano farina di grano, di castagne, polli o addirittura vitelli o vacche.In cambio lasciavano un buono, che sarebbe poi stato pagato in seguito. Purtroppo tanti di questi buoni sono rimasti tali sulla carta ed in mano di coloro che avevano allora compiuto un gesto di generosità. Infine quando si presentavano le truppe, sia tedesche, sia fasciste o alpine, bisognava rifocillarli durante il rastrellamento e caricarli di salmerie quando partivano; (questo gesto si faceva con grande gioia della popolazione).
Non poche volte alla porta si sono presentati dei gruppi di fascisti, a requisire, con le armi alla mano, quello che volevano. Con queste continue sottrazioni c’era da chiedersi: – Come si poteva soddisfare tanti richiedenti? Qui si faceva viva la Divina Provvidenza!!! Da anni non si era mai avuto un raccolto così abbondante. Nei nostri paesi nessuno in quei momenti si è lamentato di scarsezza di cibo. Se mai qualcuno si è lamentato per il vestito, di cui non ci si poteva provvedere per il fatto che non era conveniente allontanarsi da casa per il pericolo di incontri poco piacevoli.
Macellazione clandestina a fin di bene
Durante la guerra era obbligatorio da parte dei contadini consegnare il bestiame ai periodici raduni nella quantità fissata dall’autorità. In cambio di questo conferimento veniva consegnato un «buono», che di fatto non era buono a nulla. Chi non aderiva a questi raduni aveva noie a non finire da parte dei segretari e fiduciari politici fascisti. Quando invece nei nostri paesi subentrarono i partigiani, i contadini si azzardarono a non consegnare più il quantitativo di carne richiesta ed avevano istituito nei paesi una specie di cooperativa, con cui il bestiame veniva macellato in loco e distribuito fra le famiglie dei diversi paesi, anche perché fino ai nostri paesi, dispersi sui monti, non arrivava il condimento che già così scarsamente era fissato dalla carta annonaria.
Anche a Chiesiola veniva macellato a turno, qualche capo di bestiame. Accudiva a questa operazione, aiutato da altri, Serventi Pietro che abitava a poche diecine di metri dalla chiesa. In compenso del suo lavoro, aveva facoltà di tenersi la pelle della bestia macellata, che poi rivendeva. Si era durante l’inverno del 1944. La neve ricopriva tutta la nostra vallata, quando una mattina, aprendo la finestra della mia camera da letto, mi vidi dinanzi la distesa di neve tutta macchiata di rosso. Uscii di corsa di casa e constatai che purtroppo si trattava di sangue. Passai di casa in casa per potere avere una spiegazione del fatto e nessuno seppe dire nulla fino a quando sentimmo un abbaiare di cani nel bosco vicino. Uno dei presenti di corsa andò a vedere di che cosa si trattava. Al racconto di quello che aveva visto, scoppiammo tutti in una risatina di sollievo. I cani del paese avevano scovato, durante la notte, il ripostiglio dove Serventi teneva le pelli delle bestie macellate, e litigandosele a vicenda, le avevano trascinate sulla neve macchiandola di sangue, ed ora si trovavano nel bosco a disputarsi gli ultimi rimasugli.
Il primo avio lancio a Casalporino 19 marzo 1945 – S. Giuseppe
Il Parroco di Casalporino, Don Luigi Pilla, come ho già detto, fin dal 1944, si era allontanato dalla parrocchia, col permesso del vescovo diocesano, adducendo la scusa che doveva sottoporsi ad un’operazione per l’appendicite. Allontanandosi dalla parrocchia, non si è fatto più vedere se non a guerra terminata. Prima di partire mi aveva pregato di sostituirlo per il tempo necessario per l’operazione.
Stando così le cose, per la festa di San Giuseppe, 19 marzo 1945, mi ero portato in orario a Casalporino per la messa festiva. Sapevo che nella mattinata doveva avvenire un lancio da apparecchi inglesi a favore dei partigiani locali. Tale lancio era stato fissato in località vicino al paese, anziché sull’Orocco, come ordinariamente avveniva, però non sapevo con precisione quale era la località prescelta dal comando. Stavo celebrando la messa nella chiesa di Casalporino ed ero giunto quasi al termine, quando udii rumore di un aereo che volava a bassa quota. L’effetto del rumore si sentì anche in chiesa, infatti i più vicini alla porta uscirono per curiosità e, dopo i primi, la quasi totalità dei presenti uscì. Trattenni il chierichetto per non restare solo in chiesa, e terminai il sacro rito, poi uscii. L’aereo faceva volute nel tratto di cielo fra Casalporino e Chiesiola. Questo tratto di terreno era circondato da partigiani armati per proteggere il lancio da possibili detrazioni da parte di spettatori non desiderabili.
Fra l’altro io non potevo attendere la conclusione delle acrobazie dell’aereo, perché dovevo ritornare in orario a Chiesiola per l’altra funzione domenicale. Tra la disapprovazione generale dei parrocchiani di Casalporino mi misi a scendere per la china che mi avrebbe portato al Ceno, donde dovevo salire per arrivare a Chiesiola, quando arrivato a circa metà discesa, trovandomi nel mezzo di un prato, quindi in campo scoperto, mi sentii intimare: – Alto là! Mi feci conoscere e contemporaneamente sbucò fuori Carlo Squeri, vicecomandante, che sentito il motivo per cui mi trovavo lì, mi accompagnò fino alla salita di Chiesiola, dove però non ho potuto celebrare la funzione se non con quasi un’ora di ritardo perché i parrocchiani desideravano vedere fino al termine lo spettacolo della discesa dei variopinti paracaduti, spettacolo che oltre che essere molto bello ed attraente, era anche gratuito e senza pericoli.
Anzola S. Pasqua 1945
La comunione a tutti i partigiani
Si avvicinava la data della Pasqua del 1945. Un giorno mi recai a Drusco dall’arciprete Don Viviani, cappellano della Divisione Bisagno, che si trovava allora in parrocchia. Gli chiesi il suo aiuto per potere far fare pasqua con la comunione generale a tutta la brigata «Monte Penna». Si offrì volentieri ed insieme ci recammo a Tomba dove in quel periodo si trovava Bill, il comandante, col comando. Bill acconsentì ben volentieri alla proposta. Si fissò il giorno, il luogo e le altre modalità. Non potendo ospitare convenientemente un così numeroso gruppo di persone in nessuna delle nostre chiesette per una funzione unica, si decise di celebrarla all’aperto ad Anzola, località di facile accesso per le diverse squadre.
AI giorno fissato, dopo aver confessato i componenti le diverse squadre ci si trovò ad Anzola dove alcuni più volonterosi e capaci avevano preparato l’altare con addobbi ricavati da parecchi teli di paracaduti variopinti. Celebrò la S. Messa Mons. Primo Moglia, Parroco di Allegrezze, assistito da Don Viviani, che durante la sacra funzione rivolse paterne parole ai giovani a cui ha saputo strappare lacrime di commozione, e al momento opportuno si avvicinarono all’altare con devozione per ricevere dal celebrante l’ostia consacrata, mentre il loro coro accompagnava il rito con canti sacri. Era stata una giornata che i giovani anche dopo anni ricordano con piacere.
Come assistente del celebrante, notai una cosa durante la distribuzione della S. Comunione che mi lasciò perplesso: il commissario politico, presente alla funzione sacra: Dodo (Dott. Braga), era stato uno dei pochi a non accostarsi per ricevere l’ostia santa. Il giorno dopo ebbi occasione di incontrarlo e, data la confidenza che avevo con lui, gli dissi che era stata notata la sua mancata partecipazione alla comunione del giorno precedente. Capì che desideravo una risposta per poteri a riportare a chi aveva notato il suo gesto. Dopo un momento di riflessione, mi rispose:
Don Domenico, lei sa che io non credo. Non sono contrario a certe cerimonie, di cui posso apprezzare la utilità in determinate circostanze come le attuali… Ma lei, sapendo come la penso, avrebbe preferito vedermi compiere un gesto di cui non ero convinto o no? Non potei che stringergli la mano e dirgli: – Bravo! Hai fatto bene a comportarti come hai fatto.
Gli sfollati rientrano. visita a Casaliggio
Il 6 aprile 1945 lasciai la parrocchia per portarmi con don Paolo Botti a Casaliggio dove egli si trovava come curato di mio zio Don Pietro Delchiappo. Don Paolo, a piedi, da Casaliggio, si era portato fino a Chiesiola per mettermi al corrente dell’aggravamento del male che da tempo affliggeva lo zio. Prima di partire, non potendo abbandonare la parrocchia, perché gli unici parroci in loco, naturalmente oltre il sottoscritto, erano i Rev. Don Alfredo Lusardi di Spora e Don Davide Monteverdi di Casalporino, chiesi al caro Don Romualdo Gazzola, vicedirettore del seminario di Bedonia, di provvedere alla mia sostituzione per il tempo che mi era necessario fermarmi a Casaliggio. Egli accettò questo impegno di buon grado.
In questo tragitto, compiuto fino alle Moline con Don Paolo Botti e poi proseguito da solo, sono stato fermato e poi rilasciato prima dai tedeschi nelle vicinanze di Rivergaro, e poi. dai partigiani presso Rivalta. Dallo zio arciprete mi sorprese la notizia della resa del 25 aprile. Il giorno dopo (lo zio intanto si era ripreso un po’) feci ritorno in parrocchia. Una volta ritornata la tranquillità, i signori Mangiante desideravano rientrare a Lavagna. Si fermarono ancora qualche giorno, indi nel mese di maggio partirono. Volevano partire senza fare sapere nulla a nessuno, però non vi riuscirono perché tanto il signor ingegnere quanto la signora Ester avevano fatto troppo, in venti mesi di permanenza nella canonica, a favore e per la salvezza dei parrocchiani!
Quando sono partiti come era vuota e squallida la canonica!!

Liberazione 25 aprile 1945 e lapide sul M. Penna
La pace e la tranquillità che è seguita al 25 aprile 1945 ha permesso di tirare un sospiro di sollievo. Sollievo però che era costato lagrime e sangue sia da parte dei partigiani che da parte dei civili. Il loro sacrificio non doveva essere dimenticato anche se assai di frequente si cerca di non ricordare quello che ci ha portato sofferenze. Perché a noi ed ai posteri fosse un richiamo alla pace, alla concordia e all’amore di patria, sul Monte Penna, da cui il nostro gruppo partigiano aveva preso il nome, ai piedi della imponente statua di bronzo della Madonna di San Marco venne posta una lapide con i nomi di tutti i caduti partigiani e civili della Vai Ceno.
Il12 agosto 1945 venne inaugurato questo segno di ricorrenza ai nostri caduti ed alla Madonna di San Marco con una Santa Messa di suffragio e di ringraziamento celebrata dal sottoscritto come primo cappellano del gruppo Monte Penna, seguita da un breve discorso commemorativo tenuta dal dott. Carlo Squeri, partigiano.
Solenni celebrazioni di ringraziamento alla Madonna di S. Marco
Una volta ritornata la tranquillità, la popolazione della ValCeno riconobbe che, se la partecipazione forzata alla guerra da parte loro non era andata peggio, lo doveva ad un aiuto particolare della Madonna. Ho già accennato come durante questi anni nessuno aveva del rispetto umano nel manifestare la propria devozione alla Madonna. Le nostre chiese non erano state tanto affollate come allora, nelle famiglie era difficile che alla sera mancasse la recita del santo rosario. Terminato l’incubo della guerra, l’amore e la riconoscenza esplose in manifestazioni di ringraziamento: a Selvola di Drusco con la Solennità della Madonna della Guardia, a Chiesiola con la festa della Madonna di San Marco. Questa ultima festività venne celebrata con una solennità particolare: in adempimento di un voto fatto dalla parrocchia durante i rastrellamenti, i parrocchiani acquistarono una riproduzione della statua della Madonna di San Marco, la quale, dopo essere stata benedetta nel Santuario di Bedonia da Mons. Silvio Ferrari, venne portata processionalmente per i tredici chilometri che separano il Santuario stesso dalla Parrocchia.
La sacra Immagine sostò a Fontana Bonadi, a Montevacà, ai Cerri e ad Anzola prima di giungere a destinazione. In tutte queste località si trovavano numerosi gruppi di persone che desideravano vedere la statua e pregare davanti ad essa. L’anno successivo, la seconda domenica di maggio, con una funzione tutta particolare, preparata con una missione predicata da due Padri Cappuccini, la statua venne solennemente incoronata, per delega di Mons. Vescovo, da Mons. Giulio Biggi, rettore del Seminario, assistito da tutti i professori dello stesso Seminario e dai parroci limitrofi. Nel pomeriggio di detta festività la statua incoronata venne portata in processione nella frazione di Fornolo e Anzola prima di rientrare nella Chiesa parrocchiale. Questa ricorrenza venne ancora celebrata ogni anno in ricordo dell’assistenza materna di Maria in quei terribili giorni.
Conclusioni
Questi miei ricordi riordinati e stesi su invito di Mons. Manfredini, vescovo di Piacenza, che per il trentennio della Resistenza, ha espresso il desiderio di venire a conoscenza di quanto il clero della diocesi aveva compiuto in quelle circostanze cruciali, li ho desunti dai miei ricordi personali. Durante quegli anni avevo preso l’abitudine di annotare, a titolo di cronaca, su quadernetti o foglietti quello che succedeva. Siccome esprimevo in questo mio – quasi diario – gli avvenimenti come li avevo visti, o come mi erano stati riferiti, tenevo nascoste queste mie annotazioni perché non potessero compromettere né me, né i protagonisti dei fatti. La mia cucinetta era il mio rifugio dove, di sera, quando stimavo che durante il giorno fosse successo qualche cosa degno di essere notata, riempivo pagine su pagine, su quanto era avvenuto. Era logico che non potevo compiere questo lavoro durante i rastrellamenti o quando ero assente da casa, e dovevo differirlo.
Non poche volte non badavo al particolare delle date e notavo solo coi termini: ieri, oggi, ieri l’altro, per cui di certi fatti non ho potuto precisare il giorno; pensavo che il fatto avesse un’importanza tanto capitale che mi sarebbe stato impossibile dimenticare il giorno in cui era successo, invece la memoria in seguito mi ha tradito. Non pochi fatti non sono stati riportati in queste mie note personali, come l’eliminazione di Galli Arnaldo (fratello di Peppino) l’assalto notturno alla casa di Moglia Antonio a Porcy ed altri ancora in cui ho dovuto intervenire come sacerdote. Non ho creduto opportuno riportare questi fatti per motivi che credo inutile qui precisare. I fatti, da me notati, e di cui non sono stato protagonista o testimonio oculare, li ho riportati come e perché riferitimi da persone che ho stimato degne di fede. Se avessi scritto quanto allora si raccontava, avrei potuto scrivere almeno dieci volte quanto ho scritto; ma prima di annotare volevo essere sicuro, per quanto era possibile, che quanto mi veniva riferito corrispondesse a verità.
Le testimonianze avute in seguito, mi hanno confermato che quello che avevo notato corrispondeva al vero. Non ho potuto fare i nomi di coloro che mi hanno aiutato a stendere le mie annotazioni per le promesse che ho loro fatto di mantenere il segreto. Annotare i nomi voleva dire esporre a rappresaglie o dei partigiani o dei fascisti chi aveva parlato. Mi credo autorizzato a dire che fra coloro che mi hanno riferito fatti o particolari da me riportati non ci sono soltanto miei parrocchiani, ma anche persone estranee, come fascisti e tedeschi. Anche le testimonianze di questi ultimi le ho riscontrate in seguito, per vere.
Riordinando i miei ricordi e rileggendoli, mi auguro di non aver più la possibilità di trovarmi fra i protagonisti di fatti simili.
Don Domenico Dallacasa «Dado»
UNA LAPIDE SUL PENNA
Il giorno 12 agosto 1945 veniva inaugurata sul monte Penna una lapide commemorativa per i Caduti della 32′ Brigata Garibaldi e per i civili della nostra zona uccisi per rappresaglia. La lapide fissata nel piedistallo della monumentale statua della Madonna di S. Marco porta scolpita la seguente iscrizione:
I NOMI DEI CADUTI
INNALZATI SU QUESTE ROCCIE
NIDO DEL PATRIOTTISMO NOSTRO
RICORDINO NEI SECOLI
QUANTO SANGUE COSTARONO
ALLE POPOLAZIONI DEL BEDONIESE
DELL’ALTE VAL, TARO E VAL CENO
E ALLA LORO 32′ BRIGATA GARIBALDI
« MONTE PENNA»
VENTI MESI DI DURA IMPARI
VITTORIOSA LOTTA PER LA LIBERTA’
1943 SETTEMBRE-APRILE 1945
Presenziavano al rito di stretto carattere religioso patriottico il Comando di Brigata, la rappresentanza del C. L. N. di Bedonia e, un folto gruppo di valligiani. Officiava il primo cappellano del Gruppo Penna D. Domenico Dallacasa (Dado). Il partigiano Venor (On. Carlo Squeri) tenne la seguente orazione:
« Sarebbe forse più consono allo spirito del rito e del momento reprimere in gola ogni parola e lasciare parlare solo il cuore e lo sguardo fisso nell’altrui sguardo, commosso e cosciente. Ma, Compagni Caduti: che aleggiate oggi intorno a questa roccia, a questo altare, che sono la roccia e l’altare ideale del vostro martirio concedete ci ancora per oggi il ripiego della parola. Qui oggi ci siamo dati convegno per sentirvi parlare e per parlarvi. La terra già arrossata dal vostro sangue è arida e asciutta: le armi che vi hanno ucciso tacciono ammonticchiate nella ruggine, i vostri corpi si stanno dissolvendo assorbiti dalla terra avida e mai sazia; i vostri nomi vengono scolpiti nel marmo e nel sasso e innalzati sui monumenti; il pianto delle vostre mamme si è fatto più pacato e rassegnato.
Noi siamo tornati alla vita di un tempo, fatta di piccole idee e di piccole cose; ci siamo lasciati riprendere dall’ingranaggio delle misere passioni umane intrecciate di egoismo o di interesse; siamo ritornati i piccoli uomini che si arrabattano affannosamente alla ricerca d’una poltrona più alta e più soffice o di un desco più fornito e più invidiato. Voi, nel vostro martirio, vi siete alzati, noi siamo ritornati in basso, alla vita piatta di tutti i giorni. Ci si potrebbe chiedere se sia più da invidi arsi la nostra o la vostra sorte. Né io oso rispondere apertamente perché troppo dubito del consenso e dell’approvazione dei vivi. Sta di fatto, che in questo ritorno alla piccola vita normale, nessuno di noi può nascondere la delusione.
A noi per esservi meno lontani è dato solo di salire faticosamente le erte nelle ascese dello spirito. Siamo saliti su questa vetta con la stessa trepidazione con cui la scalavano, e ne sono testimonianza certa i millenari sentieri incavati nella roccia, i primi Liguri portando le vittime espiatorie per qui immolarle alla divinità. Abbiamo portato con noi il simbolo del vostro martirio, perché qui resista nei secoli e faccia di questa vetta, già altare di una religione pagana, già altare della Religione di Cristo, anche immensa naturale ara dedicata ai valori più profondi ed eterni della dignità umana che tutti si accentrano intorno all’ideale per cui vi siete battuti e siete caduti.
Come i vostri nomi sono qui scolpiti nel marmo e alzati nel cielo, così i nomi di tutti i Martiri caduti in ogni tempo per ideali puri e umani, siano scolpiti nel cuore di ogni uomo e alzati sulle vette dello spirito davanti a tutta l’umanità, vindici dei diritti e dei doveri dell’uomo. Sul Calvario del vostro martirio e del nostro ideale formuliamo il voto che a voi sia pace, a noi virtù, concordi e benessere. Nel nome del vostro sangue.
Carlo Squeri « V enor »
Discorso del senatore Gino Cacchioli ai pontremolesi nel 30° della liberazione 25 aprile 1975

Senatore Gino Cacchioli «Berretta»
In una raccolta di racconti sulla Resistenza in Valtaro e Valceno, mi sembrava di lasciare una grave lacuna informativa, non parlando delle Brigate Beretta. La presente indagine avrebbe dovuto descrivere solo fatti e avvenimenti accaduti attorno al M. Penna, da tutti ritenuto, senza ombra di dubbio, la culla del movimento patriottico del Nord Emilia e Ligure -Toscano. Tale tesi non poteva essere ampiamente trattata senza ricordare l’apporto di tali Brigate, forse storicamente determinante, nella evoluzione di tutta la Resistenza in quelle zone. Contemporaneamente non era mia intenzione riproporre un ennesimo panegirico delle Brigate Beretta, pertanto mi limiterò a riportare integralmente il discorso del suo eroico Comandante Senatore Gino Cacchioli «Beretta» pronunciato a Pontremoli nel 30° Anniversario della Liberazione. Per l’occasione quella civica comunità concesse la cittadinanza onoraria e medaglia d’oro al popolare comandante partigiano.
« La mattina del 27 Aprile 1945 gli uomini della Divisione Cisa, mentre il nemico è in fuga, entrano nella Città di Pontremoli e si incontrano poi con gli Alleati, che avanzano sulla città, dopo aver ricevuto l’invito dal Comando della Divisione partigiana. Rilevante è il numero delle perdite nemiche e dei prigionieri catturati. Ingente il bottino. Delirante l’entusiasmo della popolazione ». Questo il breve comunicato che conclude il « compendio storico della Divisione Cisa ».
Le operazioni delle formazioni « Beretta » aventi per obiettivi, l’occupazione del tratto ferroviario Borgotaro-Pontremoli, gli attacchi continui contro le truppe tedesche in ritirata lungo la statale della Cisa e, quindi, la liberazione della città, hanno inizio ai primi di Aprile del ’45 in concomitanza dell’offensiva e dello sfondamento della linea gotica operato sul versante tirrenico, dalle truppe alleate della V’ armata. Numerosissime furono le azioni di guerriglia eseguite in quei giorni sulla statale della Cisa; vengono respinti i massicci contrattacchi tedeschi nella zona di Grondola; si sventa la distruzione tentata dai Tedeschi della centrale di Teglia e con l’attacco ai caselli sulla linea ferroviaria Parma-La Spezia, nel tratto Borgotaro-Guinadi-Pontremoli; si sottrae al nemico questa importante linea di comunicazione con la pianura Padana e si evita la sicura distruzione della galleria del Borgallo, dalla quale si estraggono oltre 1.000 quintali di esplosivo recuperando 5 locomotive, 7 locomotori elettrici e 26 carri di materiale vario.
Gran parte di queste operazioni vennero portate a termine dai valorosi partigiani pontremolesi della III Brigata Beretta, e da distaccamenti della la Brigata, molti dei componenti erano di queste zone e di. Zeri. La liberazione di Pontremoli che si concluse senza drammatiche distruzioni ed eccidi fu certamente favorita oltre che dall’audacia e dal coraggio dei suoi partigiani, anche dal prezioso apporto dei membri del locale Comitato di Liberazione e dallo spirito di abnegazione e di collaborazione che la sua popolazione seppe offrire durante quelle decisive giornate.
Mi si presenta al ricordo l’eccezionale figura del Vescovo Mons. Giovanni Sismondo, che offrendosi più volte ostaggio alle forze nazi – fasciste per evitare esecuzioni sommarie contro la popolazione, dette costantemente prova di raro coraggio e di autentico spirito cristiano e si prodigò anche presso il Comando partigiano per impedire azioni di guerra nei centri abitati, che avrebbero scatenato la selvaggia rappresaglia del nemico. Il conforto del suo illuminato consiglio e la umana bontà che caratterizzava ogni suo comportamento non mancarono di influenzare la decisione che il Comando della Divisione Cisa emanò subito dopo la liberazione della città di Pontremoli.
L’ordine, cioè, di impedire qualsiasi atto di violenza o di ritorsione contro i nemici, pur avendo essi all’alba del 27 Aprile barbaramente fucilato 3 partigiani in questa piazza, e fu certamente questo opportuno e generoso provvedimento che evitò ulteriore spargimento di sangue, consentendo così una rapida normalizzazione della vita cittadina. La manifestazione di oggi ci offre, nel trentesimo anniversario, l’occasione di esporre alcune rapide considerazioni sugli eventi anche politici che caratterizzarono la lotta di liberazione. La Resistenza come fatto politico non si identificò solo con la lotta armata del 1943-45, ma nacque nel momento in cui il Partito fascista abolì le libertà civili e politiche ed instaurò la dittatura. Fu appunto da tale evento che ebbe inizio il periodo clandestino del movimento antifascista, cui parteciparono in misure diverse per organizzazione e per continuità le forze politiche che già avevano assunto un atteggiamento preciso durante la secessione aventiniana. Il quadro politico della lotta contro il fascismo si articolò con la presenza dei comunisti di Gramsci, dei cattolici di Sturzo e di De Gasperi, dei socialisti massimalisti e riformisti, degli aderenti al Partito d’Azione e dei liberali di Croce.
Ma mentre queste forze politiche erano concordi sulla valutazione negativa del fascismo e sulla necessità di combatterlo, non altrettanto lo erano in ordine alla individuazione delle strutture e degli aspetti essenziali che avrebbero dovuto caratterizzare il futuro Stato e il conseguente modello di società. Questo divario di impostazione ideale e politica ripropostosi all’inizio delle lotte partigiane, sarà in seguito superato dall’obiettivo primario che animava i combattenti; quello, cioè, di liberare il Paese dalle forze naziste e fasciste. Gli ideali, infatti, che spinsero tanti giovani a scegliere la lotta armata, non furono almeno per molti di essi, il risultato di una maturazione culturale e politica, che il fascismo non aveva consentito, ma piuttosto l’effetto di una intenzione che li faceva decidere a battersi per riconquistare la indipendenza del Paese; per consentire a tutti i cittadini il legittimo esercizio delle libertà civili e politiche; per promuovere la realizzazione di una società più giusta ed umana e per concorrere alla fondazione di uno Stato democratico il cui fine primario doveva essere l’elevazione morale, culturale, politica ed economica dei cittadini, nella rigorosa salvaguardia della pace.
Possiamo dire che fu per i giovani una vera « scoperta» del significato della libertà, della sovranità popolare, del metodo democratico. Il fascismo ebbe anche un aspetto di inganno delle giovani coscienze per deviarle, con la propaganda ed il mito della violenza, da una maturazione culturale e pluralistica. Questa non fu l’ultima delle sue colpe di fronte alla Storia. Quindi, all’origine del movimento partigiano vi fu una profonda tensione ideale, anche se sofferta nella ricerca, diretta a ristabilire nella loro pienezza i diritti fondamentali dell’uomo. E ciò che conferì al movimento una dimensione originale e qualificante sotto il profilo politico, fu la partecipazione di tutti i ceti sociali, che intorno a quegli ideali trovarono la ragione di una proficua unità d’azione.
Clero, operai, contadini, studenti, professionisti, ex militari lottarono uniti senza riserve. Se è vero, infatti, che per la lotta armata furono promotori una esigua élite di partigiani che combatterono tenacemente sulle montagne, è certo però, che intorno ad essi si manifestò subito una eccezionale solidarietà di popolo.
In questo senso si può parlare di secondo risorgimento; il movimento elitario dei Padri della Patria divenne movimento di popolo, unità spirituale. Cogliamo in questa partecipazione un profondo significato: gli ideali che furono il segno distintivo della Resistenza si rivelarono così radicati: nella coscienza popolare che senza sforzo, tutto il popolo fu unito nel combattere per una causa che trascendeva partiti ed ideologie particolari. Poche pubblicazioni hanno fin ‘ora evidenziato, ad esempio, l’apporto del clero e delle forze armate alla lotta di liberazione, nonché il contributo morale dei prigionieri militari e civili internati nei campi di concentramento nazisti, che rifiutarono ogni forma di collaborazione, pur minacciosamente richiesta.
Basterà ricordare, che in quel periodo ben 730 sacerdoti furono fucilati o morirono in combattimento o nei campi di sterminio. La partecipazione, poi, delle Forze Armate? fu significativa. Oltre ai molti ufficiali e sottufficiali effettivi che militarono nelle formazioni partigiane, vanno ricordati: la difesa di Roma, gli eroici fatti d’arme di Cefalonia, di Corfù, di Rodi, di Lero e l’importante concorso dato dal corpo Italiano a fianco degli Alleati, nella liberazione del Paese. Ma se la dignità di una causa si commisura dal contributo sincero, ardente, incondizionato di pensiero e di azione che i migliori offrono all’appello e al trionfo della causa stessa, sono i Martiri a configurare. il volto autentico della Resistenza e a dare un senso valido e sincero alla Causa per la quale lottarono e caddero.
Basta leggere, per rendersene conto, quelle pagine stupende delle « Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana ». C’è in esse al di là di ogni odio e di ogni oscura passione, l’invito insistente alla solidarietà umana, ad operare perché la Giustizia si realizzi e con essa si rafforzi la libera convivenza fra gli uomini. Dio, famiglia, libertà e Patria sono i motivi ricorrenti che dominano ed accompagnano i momenti del doloroso itinerario dei morituri. Non è possibile trovare in quelle lettere parole di odio, di vendetta e di maledizione.
Le testimonianze lasciate dai «Condannati a morte» pongono indubbiamente non solo questi martiri della libertà, ma la Resistenza stessa ad un livello morale di incontrastata superiorità. Ma la lezione che ci pervenne dalla lotta di liberazione non fu di semplice protesta contro la tirannide, rappresentò anche la esigenza profonda di un democratico rinnovamento del nostro Paese. Per questo, seppur brevemente, ritengo sia opportuno, specie nel trentennale della lotta di liberazione, verificare se e quanto il patrimonio della Resistenza, recepito nella nostra Costituzione, sia stato attuato sul piano politico.
Come abbiamo già affermato, i modelli proposti per strutturare il Paese al momento del ritorno alla libertà, si configuravano in modo diverso a seconda della matrice ideologica. La scelta, democraticamente elaborata nei contenuti della nostra Costituzione, fu quella di una democrazia parlamentare, pluralista, ad economia mista e socialmente avanzata. Questo modello ha retto alle prove per questi trattamenti ed è oggi accettato, almeno attraverso le dichiarazioni ufficiali, da tutte le forze politiche che hanno rappresentanze in Parlamento.
Dare, quindi, credito alla suggestione dell’utopia, volere ad arte confondere l’autorità della legge democratica con l’autoritarismo, pretendere un egualitarismo anarchico e velleitario ed accusare, secondo questa visione, di tradimento degli ideali resistenziali la classe politica, significa non interpretare nel suo spirito informatore il dettato costituzionale. Questo, intende favorire la ricerca e la sintesi di tutti gli apporti positivi del pluralismo politico e culturale e pone tutte le energie rinnovatrici su di un piano di eguaglianza, di possibilità, nel confronto, nella dialettica delle idee e della ricerca del consenso. Se tanto, come negarlo, sul piano politico si è realizzato nel nostro Paese, molto resta ancora da fare, per conseguire l’attuazione continua degli ideali resistenziali nel cammino della Storia.
Riconosciamo, infatti, che lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese, pur avendo registrato significativi progressi, evidenzia ancora rilevanti anomalie e squilibri, che alimentano tensioni sociali e politiche. L’opinione pubblica è da tempo sconcertata per gli atti di terrorismo che minacciano l’ordine democratico, posti in atto da forze eversive che mirano ad abbattere le libere istituzioni del Paese. Sulla collaborazione politica di queste forze, troppo superficialmente si dissente, preferendo alcuni condannare solo quelle di estrema destra, ed altri solo quelle di estrema sinistra, senza rendersi conto che l’atto di terrorismo attuato contro un sistema democratico, denota in chi lo ispira e lo realizza una abbietta mentalità sopraffattrice ed un profondo disprezzo dei più essenziali valori umani.
I gravi fatti di violenza politica che anche nei giorni scorsi si sono manifestati in diverse città italiane, dimostrano che v’è in atto una spirale di eversione, che occorre reprimere con estrema energia, senza fermarsi ai soli esecutori materiali, ma colpendo anche i possibili mandanti, a qualsiasi parte politica essi appartengano. Ma anche le forze politiche sociali subiscono il travaglio di una preoccupante crisi, dovuta non solo alla rapida trasformazione della nostra società, ma soprattutto alla attenuata tensione morale, e con esse anche le stesse situazioni ne sono insidiate. Diceva, giustamente, De Gasperi, che la tenuta alle avventure autoritarie non ha alcun senso, se il Parlamento e l’esecutivo non vengono reintegrati di tutti i poteri quando questi di fatto sono compromessi da interessi corporativi e settoriali.
L’appello, quindi, che gli autentici democratici rivolgono specie ai partiti di governo, è quello di sollecitarli a dare adeguate risposte programmatiche e di direzione politica rispondenti alle necessità del momento e in prospettiva al rafforzamento del quadro istituzionale e democratico. Il neo-fascismo e l’estremismo esasperato ed utopistico di segno opposto, non si combattono solo attraverso le professioni di fede, ma dimostrando con atti politici concreti e responsabili, il primato dei valori ideali della democrazia. Di fronte alle carenze e alle difficoltà del momento, comprendiamo come a volte i giovani e anche coloro che lottarono per una sostanziale libertà e per una giustizia sociale più avanzata provino sentimenti di amarezza e di sconforto.
Ma a costoro occorre far comprendere che il cammino per la edificazione di una democrazia sempre più ricca di contenuti, è lento ed irto di ostacoli. La democrazia si conquista ogni giorno con tenacia e si realizza, infatti, non con la sola elaborazione, pur necessaria di leggi adeguate e tempestive, ma soprattutto attraverso la lenta e consapevole educazione culturale e politica delle coscienze. Oserei dire che a volte gli stessi difetti che si riscontrano e che si ha il coraggio di denunciare attraverso il proficuo dibattito democratico, servano a migliorare i rapporti fra i cittadini e la sua classe dirigente, nella misura in cui questa, sappia rimuovere se stessa e realizzi sempre di più il sostanziale collegamento politico con gli elettori. Prima, di concludere, consentitemi di rivolgere un caloroso saluto a tutte le Autorità, ai partigiani e ai cittadini presenti ed un particolare ringraziamento al Sindaco e ai Consiglieri comunali per avermi conferito la cittadinanza onoraria della vostra città.
L’importante onorificenza, si intende certamente assegnata, tramite mio, a tutti coloro che in quei giorni concorsero ad operare per ristabilire nel nostro paese i valori della democrazia in precedenza soppressi e, quindi, idealmente questo significativo atto va ad onorare quanti offrirono la vita per quegli ideali e a quanti affrontarono sacrifici perché essi democraticamente si realizzassero. Per questo sento e mi assumo la responsabilità che mi viene da questa vostra attestazione di stima e di amicizia, che mi richiama in questo momento anche il commosso ricordo di mio fratello Guglielmo già cittadino onorario di Pontremoli, cercherò quindi di esserne degno, nel diuturno impegno politico, nelle grandi, come nelle piccole cose.
Pontremoli 25 aprile 1975.
Gino Cacchioli « Berretta »
Riassunto conclusivo sulla Resistenza in Valtaro, premessa per la concessione della medaglia d’oro.
OTTO LUSTRI SONO ORMAI TRASCORSI DA QUEL LONTANO 25 APRILE DEL 1945 CHE VIDE SPUNTARE SUL NOSTRO PAESE L’ALBA DELLA LIBERTA’
Si era spento da poco l’eco del crepiti o delle armi che nel Natale del ’43 da Osacca rimbalzò sulle pendi ci del Santa Donna, monte sacro alla memoria dei Valtaresi di oggi e di domani, quando a marzo, lungo la strada ferrata che dalla Spezia adduce a Parma, l’iniziativa passava in mano partigiana, consacrando in Valmozzola il coraggio e la determinazione di Mario Betti, l’eroe sconosciuto, e dei suoi giovani compagni.
Il seme gettato con abbondanza nelle nostre terre da uomini di diversa estrazione sociale e politica, che già aveva dato un primo esile germoglio il 15 dicembre del ’43, quando in Sambuceto di Bedonia un gruppo di patrioti del costituendo Gruppo Penna, nel mentre trasportava armi, le poche armi in verità che allora era stato possibile mettere insieme, ebbe a scontrarsi con una pattuglia di carabinieri in perlustrazione, questo seme proliferò in fretta e con abbondanza, sicché fu un fiorire di iniziative, un sorgere impetuoso di gruppi, dal Penna al Centocroci, dal Betti ai gruppi del Molinatico e della Val Gotra, e i ribelli valtaresi cui si erano aggregati uomini dello Spezzino e militari sbandati tagliati fuori per gli eventi bellici dai rispettivi luoghi di origine, si insediarono saldamente su queste terre, e attraverso azioni continue, condotte con il sostegno determinante delle popolazioni locali, giunsero a liberare fra il giugno e il luglio del ’44 tutta la valle, da Ghiare di Berceto fino ai passi del Bocco e di Centocroci.
Si costituì in tal modo il Territorio libero della Val Taro, che rappresentò un luminoso punto di riferimento per tutta la Resistenza della valle, e non soltanto di questa, a testimoniare che il cammino percorso era stato sì arduo e faticoso, ma altrettanto fecondo e fruttuoso, così da passare dalla iniziale fase cospirativa e organizzativa ai primi disarticolati scontri, espressione talora di improvvisazioni temerarie, ma pur sempre testimonianza di estremo coraggio e di grande passione patriottica; per divenire infine un impetuoso movimento popolare articolato, fortemente organizzato, capace di controllare una vallata di grande interesse strategico, dal momento che essa è’ percorsa da tre strade di valico e da una ferrovia che collegano il Tirreno con la pianura padana; in grado di impegnare duramente rilevanti forze nemiche, e di annientare di fatto la pretenziosa presenza fascista che svanirà giorno per giorno nell’ombra ignominiosa della propria impotenza e della propria viltà.
Tutto ciò fu pagato ad altissimo prezzo: un prezzo costituito dall’inestimabile valore delle vite stroncate dei nostri giovani compagni di lotta, dei nostri concittadini di ogni età fucilati per rappresaglia, o uccisi freddamente, rei soltanto di avere alimentato nel proprio cuore la fiamma dell’amore e della cristiana solidarietà, di avere risposto all’invito evangelico di sfamare chi chiedeva pane per difendere per sé e per tutti, per le generazioni presenti e per quelle future, il diritto di vivere da uomini liberi. Ma noi non siamo qui oggi per piangerli: giacché il loro ricordo è scolpito indelebile nelle nostre più intime fibre, e si è fatto parte di noi, è divenuto sangue del nostro sangue, pensiero costante del nostro pensare. Qualcuno ha parlato negli anni passati di Resistenza tradita; e l’affermazione ha trovato risonanza – perché non ammetterlo? – nel cuore di taluni di noi, usi forse a pensare più in termini di idealità che non di realismo, di utopia ancor più che di politica.
Fu l’epoca delle attese messianiche, delle sognate palingenesi che obbedivano troppo spesso a forzature ideologiche basate su assunti acritici, di trasposizioni storiche del tutto arbitrarie e troppo spesso sfornate, non so con quanta buona fede, come miracolosi toccasana capaci di risolvere d’un tocco tutti i mali della nostra società. Il tempo galantuomo si è incaricato di fare giustizia dei miti, di restituire alle vicende i loro autentici connotati, di ristabilire alcune fondamentali verità che hanno contrassegnato la nostra vita civile di questi otto lustri trascorsi. In primo luogo la Costituzione. L’Italia vanta una delle più avanzate e democratiche costituzioni esistenti al mondo; e questa legge fondamentale dello Stato è permeata – diciamolo con giustificato orgoglio – dei principi ideali che animarono la Resistenza.
Essa sancisce il diritto di ogni cittadino alla libertà nel senso più ampio della parola, e assicura al Paese un presente e un futuro di stato democratico. Non dimentichiamo mai che nella millenaria storia d’Italia solo poco più di 50 anni, dall’Unità del 1870 al 1922, furono caratterizzati da una democrazia, oltretutto imperfetta e assai limitata. La Repubblica. Senza colpo ferire, attraverso la libera espressione della volontà popolare, il Paese si è liberato di una monarchia compromessa fino al midollo delle ossa con il fascismo, e responsabile in prima persona dei disastri che la dittatura, e la guerra imposta dalla dittatura, avevano arrecato alla nazione, e si è dato un nuovo assetto istituzionale che riconosce nel popolo la sovranità assoluta.


Fac. simile della medaglia d’oro concessa il 21/9/85 alla Valtaro con menzione delle Brigate operanti nella zona.
La ricostruzione. Nel volgere di pochi anni, attraverso l’impegno e lo spirito di sacrificio di operai, contadini, imprenditori, in una parola di tutte le classi sociali l’Italia, uscita prostrata dalla guerra che dal 1942 aveva imperversato sul territorio nazionale, dapprima attraverso micidiali e terrificanti bombardamenti aerei, successivamente con lo sbarco degli alleati sul suolo nazionale, e infine, dopo 1’8 settembre del ’43, per effetto della lotta senza quartiere che vide opposti alleati e partigiani agli occupanti tedeschi, questa Italia dicevo ha saputo risanare le proprie ferite, ricostruire le strade devastate e i ponti abbattuti, le città bombardate, le fabbriche distrutte, e si colloca da anni, pur in assenza di materie prime atte a garantirle un minimo di autosufficienza, fra le prime otto potenze industriali del mondo.
Lo Statuto dei lavoratori. Possiamo affermare in piena consapevolezza che pochi Paesi al mondo dispongono di uno strumento legislativo tanto progredito, così atto a tutelare gli interessi dei lavoratori; e le organizzazioni sindacali hanno assunto nel corso degli anni un ruolo sempre più importante e decisivo nella vita della nazione, fino a divenire un asse portante della democrazia. Certo: tutto questo è accaduto non perché piovuto per buona sorte dal cielo, bensì attraverso dure lotte, a mezzo di scontri talora aspri, a conferma che la democrazia non è, né può essere mai una astrazione, è invece una realtà che ogni giorno va costruita, ampliata, irrobustita e difesa con la partecipazione cosciente delle masse popolari.
Ricordo ancora come già in altre circostanze, dopo il commosso ricordo degli avvenimenti che avevano visto la nostra valle protagonista di storia, affrontai senza mezzi termini il problema, che già all’epoca si poneva, del terrorismo. C’era stata non poca reticenza a quel tempo, e dubbi espressi da più parti, in modi talora subdoli, talvolta velati, sulla opportunità di riconoscere la esistenza di un terrorismo derivante da opposti estremismi. I primi atti di violenza avevano coinvolto dirigenti d’azienda, e un malinteso operaismo aveva creduto di potere, se non giustificare, quanto meno slittare su fatti che avrebbero in seguito assunto una ben precisa connotazione.
Ebbene, le mie tesi, non furono condivise da taluni: fatto questo per niente deprecabile, posto che l’unanimismo sol di rado si addice alla democrazia, o quanto meno, non ne costituisce una costante; ma bastò attendere qualche tempo, perché le idee si schiarissero anche ai più increduli: poco dopo infatti, e per l’esattezza il 16 marzo 1978 l’on. Aldo Moro, Presidente della Democrazia Cristiana, mentre si recava a Montecitorio per votare la fiducia al primo governo di unità nazionale, il primo dalla ormai lontana liquidazione del primo gabinetto De Gasperi, veniva rapito in Via Fani dalle brigate rosse, e la sua scorta trucidata. 54 giorni dopo il suo corpo senza vita veniva ritrovato nel baule di una auto in sosta in via Caetani, a metà strada tra sede della Democrazia Cristiana e quella del P.C.I.
Tutti allora compresero quello che le forze resistenziali avevano capito da tempo: e cioè che era in atto un tentativo di eversione rivolto contro lo Stato democratico, tentativo condotto da uno sciagurato estremismo di diversa ispirazione, con l’unico e comune scopo di scardinare le fondamenta dell’ordinamento nato dal sacrificio di tutto un popolo e dal sangue nobilissimo dei nostri Caduti. E seguirono anni di piombo: l’operaio Guido Rossa, il giudice Bachelet, il giornalista Walter Tobagi, il generale Galvaligi, e ne ricordiamo soltanto alcuni, tutti caddero sotto i colpi liberticidi di pseudo – rivoluzionari, che univano le proprie azioni delittuose a quelle folli e vili e sanguinarie che i neo-fascisti operavano con le stragi di Piazza Fontana, di Bologna, di Piazza della Loggia, dell’Italicus.
Ebbene, di fronte a questa incalzante offensiva, fatta di omicidi, di ricatti, di stragi, il Paese seppe opporre grande fermezza, e senza provvedimenti eccezionali, con la sola forza della democrazia e delle leggi, riuscì a isolare prima, e a portare poi durissimi colpi al terrorismo, manifestando con ciò un alto grado di maturità, testimoniando che i semi della libertà e della democrazia avevano bene fruttificato e fissato nelle coscienze profonde radici. E poiché siamo in argomento, mi sia consentito di affermare che sarebbe ingenuo, per non dire colpevole, abbassare oggi la guardia. Troppe voci interessate circolano petulanti, volte a sminuire le colpe degli assassini, a suggerire la opportunità di un colpo di spugna, che cancelli le gravissime responsabilità di quanti per anni tennero col fiato sospeso un popolo intero, che vedeva minacciata ogni giorno la propria esistenza di popolo libero.
Che dire di un parlamentare il cui comportamento al riguardo avrebbe ai tempi nostri, ai tempi della Lotta di Liberazione, condotto difilato dinnanzi al plotone di esecuzione per tradimento? Esiste un deputato che, reso si uccel di bosco dopo che la Camera aveva concesso nei suoi confronti l’autorizzazione a procedere per il sospetto di gravi responsabilità nell’azione terroristica, continua a percepire l’indennità parlamentare, mentre si richiama al rispetto dei suoi doveri – e diciamo pure giustamente – il dipendente pubblico o privato che si assenti arbitrariamente o ingiustificatamente dal lavoro.
Io credo dunque di poter qui affermare che errarono quanti ebbero a parlare di tradimento della Resistenza; essa aveva indicato al popolo grandi obiettivi ideali: libertà, giustizia, democrazia, pace, dignità umana. Rileggiamola la nostra Costituzione, questo vangelo laico delle coscienze libere. « Nelle montagne della guerra partigiana, nelle carceri dove furono torturati, nei campi di concentramento dove furono impiccati, nei deserti o nelle steppe dove caddero combattendo, ovunque un italiano ha sofferto e versato il suo sangue per colpa del fascismo, ivi è nata la nostra Costituzione ».
Essa indica queste mete, e a queste, in una civile diuturna battaglia noi ci richiamiamo, con vicende alterne, con risultati talvolta contradditori, poiché la vita di un popolo è un divenire continuo, è un impegno che si rinnova, e gli ideali che questa vita alimentano vanno ogni giorno sostenuti, vivificati con la presenza, la partecipazione, e se necessario, con la lotta di tutti i cittadini. Quello che importa, scriveva Ferruccio Parri, l’indimenticabile « Maurizio » comandante generale del Corpo Volontari della Libertà, « quello che importa è portare avanti con coerenza, con fermezza il progresso civile e sociale del nostro Paese, nel chiaro quadro democratico delineato dalla Costituzione, questa grande legge dei diritti e dei doveri del cittadino italiano ». E’ con siffatto impegno, nel solco degli ideali sanciti dalla grande lotta nazionale contro il nazifascismo per la indipendenza, per la libertà e il rinnovamento della Patria, che noi avvertiamo oggi il dovere di indicare alla nostra gente, nel giorno anniversario della Liberazione, tre emergenze che si impongono alla attenzione della pubblica opinione, alle coscienze degli italiani.
La prima riguarda la lotta alla criminalità organizzata e, in stretta connessione con questa, la necessità di moralizzare la vita pubblica. Esistono vaste aree del paese, dalla Sicilia alla Campania, dove l’arbitrio, la violenza, l’azione delittuosa si sono sostituite alla legge, determinando un pericolosissimo inquinamento delle strutture amministrative, dalle regioni alle province, dai comuni ai consorzi, ai settori economici di pubblica gestione, Mafia e camorra operano con una ferocia, con una protervia e una spregiudicatezza che annullano e ridicolizzano la presenza dello Stato, sconvolgendo i rapporti sociali, distruggendo le basi della democrazia. Droga, sequestri di persona, controllo dei mercati, taglieggiamenti, riciclaggio di denaro sporco, mistificazione di appalti, omicidi a catena che, da regolamento dei conti all’interno delle bande per il controllo di questa o di quella zona, hanno alzato il tiro fino a colpire i gangli della democrazia, mettendo nel mirino parlamentari, amministratori, magistrati, giornalisti, e lo stesso Alto Commissario per la lotta alla mafia, generale Dalla Chiesa.
Una catena inarrestabile di delitti, che può contare sulla omertà di popolazioni da troppo tempo adusate al servaggio, e sulla inerzia e sulla impotenza di uno Stato burocratizzato e sclerotizzato da inutili, assurdi atteggiamenti bizantini e parolai di una classe politica abitualmente in ritardo rispetto ai problemi che la società viene di volta in volta ponendo sul terreno. Si affianca al fenomeno, in parte quale diretta conseguenza di esso, ma soprattutto per una perdita di tensione morale, aggravatasi vieppiù negli anni fino a scadere a livelli da basso impero, la profonda immoralità di troppi uomini politici, per i quali il tornaconto personale, l’appropriazione indebita, la truffa, l’affarismo, l’interesse privato in atti d’ufficio, per dirla con formula ricorrente, sono divenuti una costante della loro pubblica attività. Il Paese deve reagire a siffatto stato di cose, imponendo alla classe politica l’adozione di adeguate misure, volte a stroncare con la necessaria durezza il fenomeno della criminalità organizzata, i cui legami con il terrorismo sono oltretutto ormai ben noti.
Occorre una mobilitazione delle coscienze per scuotere e vincere la acquiescenza di intere popolazioni, che hanno da troppi decenni accettato uno stato di soggezione al sopruso, alla violenza e al crimine, e nel contempo per imporre ai partiti una radicale pulizia della proprie strutture, la cacciata con infamia dei disonesti, dei ladri, dei prevaricatori. Noi fummo a suo tempo sostenitori del finanziamento pubblico dei Partiti, per la positiva valutazione delle insostituibili funzioni che essi esercitano per l’attuazione, la difesa e lo sviluppo della democrazia. Ciò non significa pur tuttavia che noi riconosciamo ai Partiti il diritto di impadronirsi di tutti gli organismi pubblici, dalle banche ai settori economici irizzati, per finire ai mezzi di comunicazione di massa al settore sanitario e via di seguito. .
Ogni giorno ci troviamo di fronte a lottizzazioni selvagge, nelle quali finisce per trionfare, in luogo della professionalità, competenza e onestà, una proterva volontà di arrampicamento sociale, quando addirittura non s’imponga la sudditanza ai voleri di piccoli o grandi « boss» locali o nazionali, usi a pretendere l’affermazione degli interessi correntizi o di partito ai danni e in prevaricazione degli interessi generali della società nazionale. . La Costituzione all’art. 49 recita testualmente: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ». Tutto qui.
Occorre pertanto che i partiti rientrino con sollecitudine nell’alveo delle funzioni ad essi assegnate e riconosciute dalla suprema legge dello Stato, evitando così di divenire enormi carrozzoni, al cui sostentamento si provvede in modo troppo spesso spregiudicato, altre volte illecito, se non addirittura talora delittuoso, vanificando in tal modo gli obiettivi che la legge per il finanziamento pubblico aveva fissato con sufficiente chiarezza. La seconda emergenza ha per oggetto l’ingiustizia tributaria, o se più aggrada, l’evasione fiscale, e insieme ad essa, la disoccupazione giovanile.
Sono di recente pubblicazione i dati rilevati dal Censis, in ordine alla reale partecipazione contributiva delle diverse categorie o classi sociali. Voglio esimermi da ogni commento per non incorrere nel reato di turpiloquio. . Noi ci auguriamo soltanto che il Parlamento, e quanti hanno il dovere di intervenire, mettano mano con estrema rapidità ai provvedimenti necessari per far cessare questo scandalo. Giacché non è lecito, nel quadro di una politica tesa a conseguire il sacrosanto obiettivo di porre un serio freno al galoppo di quella maledetta malattia che si chiama inflazione, non è lecito dicevo pretendere sacrifici dai lavoratori a reddito fisso, per lasciare poi briglia sciolta alle categorie autonome, concedendo addirittura ad esse il diritto di ridicolizzare, con paradossali dichiarazioni di reddito, il dettato costituzionale, là dove afferma che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
E questo affermiamo oggi, non soltanto per un legittimo senso di giustizia fiscale; poiché si collegano a questo problema, di indubbio e profondo significato politico e morale, altre due questioni sulle quali sarà bene che quanto prima l’opinione pubblica appunti la propria attenzione, e faccia udire alta la sua voce: mi riferisco al disavanzo pubblico e alla disoccupazione giovanile. E’ noto anche ai più disattenti, e a quanti masticano con difficoltà concetti anche elementari di economia, che il disavanzo dello Stato, per la gestione in corso, supererà i centomila miliardi.
E’ noto altresì che lo Stato ha, nei confronti di una larga fetta di cittadini possessori di buoni del tesoro, di certificati di credito; di buoni fruttiferi postali, di buoni poliennali del tesoro, una posizione debitoria che si aggira sui 500 miliardi di lire, posizione che ogni mese è destinata ad aggravarsi, per la necessità che ha il Tesoro di ricorrere all’emissione di nuovi titoli, al fine di rastrellare nell’area del risparmio denaro fresco che consenta di pagare gli interessi dovuti ai possessori dei 500 mila miliardi di titoli, e di provvedere altresì alle necessità correnti di cassa.
Tra le conseguenze che tale situazione produce va sottolineato l’alto costo del denaro, che impone agli imprenditori e a quanti intendano ricorrere al finanziamento bancario il pagamento di alti tassi di interesse, non potendo ovviamente le banche ridurre oltre un certo limite gli interessi che le stesse corrispondono ai depositi, e ciò per la concorrenza che in tale campo esercita a loro danno lo Stato. Ora noi non apparteniamo – per le negative esperienze fatte in materia in Italia e altrove – alla schiera di coloro che vedono nelle nazionalizzazioni il rimedio per determinare l’espansione della produttività, e la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro.
Riteniamo per contro che lo Stato non abbia nessun titolo per gestire imprese dolciarie, o aziende agricole fallimentari, o giornali le cui passività gravano inevitabilmente sul contribuente onesto. Ci sia tuttavia consentito di affermare sommessamente che la eliminazione della evasione fiscale, ancorché difficile, porrebbe termine innanzitutto a una profonda ingiustizia sociale, e garantirebbe inoltre i mezzi per cominciare a contenere e a ridurre il disavanzo e l’indebitamento pubblico, e a porre mano al volano della economia con appropriati interventi di natura finanziaria, atti a favorire – con la ripresa economica e produttiva – la creazione di nuovi posti di lavoro. Noi non possiamo guardare con animo insensibile al grande dramma costituito dalla disoccupazione giovanile. Non ha senso alcuno la conquista della libertà e della democrazia se ad essa non si accompagna un impegno costante per assicurare ai giovani un lavoro. Ora io so i grandi errori commessi dalla classe politica, allorché con visione demagogica del problema apre le porte dell’università a folte sterminate di giovani, senza peraltro assicurare le infrastrutture didattiche necessarie, destinandoli poi, inevitabilmente, a lunghissimi periodi di disoccupazione o di sottoccupazione.
Ma so anche che nella frustrazione dell’ozio forzato allignano i germi delle più impensate devianze, tra le quali, gravissima, la maledizione della droga. Ecco perché il Paese, i partiti, i democratici debbono impegnarsi a fondo su questo problema, dalla cui tempestiva soluzione dipenderà in gran parte l’avanzata o l’arretramento della democrazia, l’affermarsi degli ideali della Resistenza e del dettato costituzionale, o la seduzione di scorciatoie, al fondo delle quali compare sempre l’autoritarismo.
La terza e ultima emergenza ha nome pace.
Noi che abbiamo conosciuto le profonde sofferenze e gli indicibili orrori della guerra, riteniamo nostro assoluto dovere, proprio per l’esperienza vissuta e in coerenza col nostro passato, rivolgerci a tutti i cittadini, e in particolare ai giovani, per invitarli a riflettere sul momento attuale. L’umanità intera è in grave pericolo: la sopravvivenza del genere umano è minacciata da armi terrificanti, mai impiegate prima d’ora, ma che lo sarebbero sicuramente in caso di conflitto tra le super-potenze. Noi, che respingiamo il principio degli arsenali sempre più forniti in un mondo che conosce ancora carestie drammatiche e morti per denutrizione, non possiamo accettare che le super-potenze facciano dipendere la loro grandezza dal proprio potere militare, e ci rifiutiamo di riconoscere ad esse il diritto di decidere il destino dell’Europa è del mondo.
La scienza e la tecnica possono e debbono essere messe al servizio dell’uomo, e non divenire strumenti di sterminio. Da qui scaturisce la nostra richiesta alle superpotenze, a tutti gli stati del mondo, affinché sia ricercata con onestà, e senza pretestuosi irrigidimenti, la via che deve portare alla distensione e alla pace, al disarmo generale e controllato, assicurando il pieno rispetto della indipendenza e della libertà di ogni popolo. Da qui il nostro impegno e di tutti i cittadini, di ogni credo politico e fede religiosa, di tutte le istituzioni e di tutte le forze attive operanti sul nostro territorio, perché Governo e Parlamento avviino tutte le iniziative possibili per riportare le superpotenze a quelle trattative che dovranno sfociare nella distruzione degli arsenali nucleari, e garantire la pace alla nostra generazione e a quelle che verranno.
Questi, cittadini e amici partigiani, gli impegni che noi oggi, nel celebrare l’anniversario della Liberazione, assumiamo di fronte ai nostri morti. Sono impegni coerenti con le lotte del passato, nel solco dei dettami della Costituzione, nel rispetto della sacra memoria dei nostri caduti e di tutte le vittime della passata guerra. Un popolo intero insorse contro la tirannia, contro il sopruso, contro l’invasore, contro la guerra. Un popolo, che aveva saputo compiere fino in fondo il proprio dovere, lasciando tanti dei suoi figli sulle aspre montagne di Grecia, di Albania e di Jugoslavia, nei torridi deserti africani e nelle gelide steppe russe, generosi giovani ai quali tutti si inchina riverente la nostra memoria, vittime di una insensata guerra di rapina, voluta dalla criminale incoscienza di una classe dirigente che aveva cercato nella guerra lo strumento della propria sopravvivenza, questo popolo, le cui antiche origini testimoniano un non mai sopito amore per la dignità umana e per la libertà, ha saputo affrontare con estremo coraggio e spirito di sacrificio, spinto fino alle estreme conseguenze, una impari lotta contro un nemico crudele e possente, scrivendo in tal modo una meravigliosa pagina di storia che nulla e nessuno mai potrà cancellare nei secoli a venire.
Montevaccà, Tasola, Valmozzola, Grifola, Pelosa, Manubiola, Ostia, Santa Donna, queste le tappe di un riscatto sofferto, di un cammino aspro, colmo di insidie, denso di sacrifici e di lutti, al fondo del quale sorgeva il grande faro della libertà. Sacerdoti, contadini, studenti, operai, professionisti, tutti fecero il loro dovere. Per questi fondati motivi noi siamo profondamente convinti che questa valle abbia bene meritato nei riguardi della Patria. E nel giorno del conferimento della medaglia d’oro, che riconoscerà finalmente a questa nostra gente i lutti e le lacrime di tante famiglie, i dolori sofferti, i sacrifici compiuti, le rinunce continue e i servizi costantemente resi, ci saremo tutti, giovani e anziani, inginocchiati dinanzi al monumento ai caduti, a ricordare in un abbraccio corale, dettato dall’amore e dalla riconoscenza, le vittime di tutti i fronti della ingiusta guerra, i morti dei bombardamenti, i civili abbattuti dalla barbarie, le vittime dei campi di concentramento, gli amici di lotta che ci hanno preceduto nel riposo eterno, e i nostri compagni partigiani, che hanno santificato, con il loro purissimo sangue, questa nostra amata terra.
Viva la Resistenza!
Giovanni Timossi